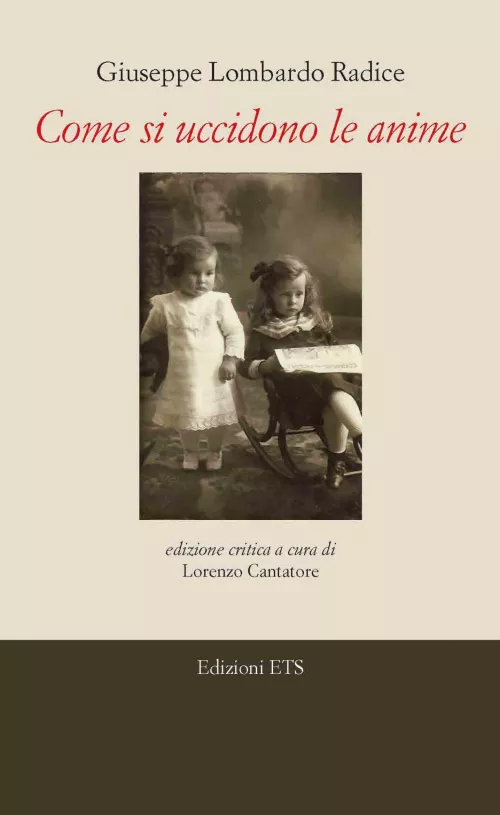Giuseppe Lombardo Radice / Scuola: come si uccidono le anime
In Il nome della rosa di Umberto Eco (e nell’omonimo film rimesso in onda per commemorare la recente scomparsa di Sean Connery) l’anziano monaco cieco Jorge tenta in tutti i modi, persino attraverso efferati delitti, di occultare un testo inedito di Aristotele. Nel secondo libro della “Poetica” lo Stagirita avrebbe trattato della commedia e del riso, del beneficio del ridere, e questo per la Chiesa è un fattore che potrebbe rivelarsi letale: “Il riso uccide la paura, e senza la paura non ci può essere la fede. Senza paura del demonio non c’è bisogno del timore di Dio”. Guglielmo da Baskerville, invece, incaricato di fermare la lunga serie di morti sospette, decanta le virtù del riso, ne elogia la caratteristica tutta umana, a dispetto degli altri animali da cui pure noi discendiamo. È un giallo, Il nome della rosa, ma al contempo riflessione semiologica, filosofica, linguistica, storica, pedagogica, oltre che naturalmente divertissement letterario.
Una questione tra le altre, quella del “cosa” e del “come” educare a scuola, e dunque studiare, è affrontata anche da Giuseppe Lombardo Radice, pedagogista (chissà se avrebbe amato essere definito tale, o semplicemente essere definito) che nel 1915 dà alle stampe un pamphlet, Come si uccidono le anime, frutto di una conferenza di due anni prima all’Università popolare di Fiume e presso la Lega degli insegnanti di Trieste, «istituzioni e luoghi molto significativi», scrive nella sua edizione critica Lorenzo Cantatore (Ets, 2020) in quanto «il nord-est italiano era l’area geografica che, insieme alla Sicilia e al Canton Ticino, fu sempre al centro della vita intellettuale e affettiva di Lombardo Radice». Vita intellettuale che si apre nel segno della filosofia, di Hegel, e sarà “l’esperienza” didattica a permettergli di intercettare la propria vocazione pedagogica, a riflettere sulla sua natura.
In questo testo Lombardo Radice, due anni dopo il suo saggio forse più noto e importante, Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, si scaglia contro il gesuitismo, una dottrina che ha punito più volte chi insegna una qualche teoria “contraria ad Aristotele” (vedi Il nome della rosa). O, più generalmente, chi si professa “novatore” e compie nuovi studi, si lancia in avanti nel progresso, nella comprensione della realtà: «spietata la caccia al professore sospetto di “novità”». Dimenticando, pertanto, che «In ogni atto della vita abbiamo bisogno di portare qualcosa di nostro, e nostro vuol dire nuovo»: il nuovo è il nostro, noi siamo la novità, il neo-venuto alla luce. I nostri ragazzi sono nostri perché sono nuovi. «Aiuta al male… la pedagogia, o meglio il pedagogismo, che rattrappisce nella scuola tutta l’educazione» (Come si uccidono le anime; come tutte le citazioni che seguono, tranne dove esplicitamente indicato). Educarsi è fuori, è altrove, è ovunque: è nel fare esperienza diretta del vivere. «Rendersi conto, questo è imparare».
Quelle gesuitiche erano, in particolare, «scuole della passività», «scuola che costruisce canoni e guida per mano, come se non avesse fede in chi educa, anzi non come se, ma non avendo fede in chi educa», con quella «pigrizia educativa [che è] reazione e attentato alle anime». Si pensi, scrive Lombardo Radice, «alla manualite di tante scuole moderne: basterà per identificare i due mali, la cui diagnosi è identica: la considerazione della scienza come risultato (come fatto), non come problema […]; informazione non formazione». “Manualite”, malattia contemporanea non eradicata, che fa da contraltare alla “manualità” che mai dovrebbe perdersi nei percorsi educativi, secondo il pensiero e le teorie dell’“attivismo pedagogico” di Dewey.
E non è un caso che Lombardo Radice faccia tradurre per primo in Italia nello stesso anno, il 1915, un’opera del filosofo e pedagogista americano, Scuola e società, testo che nel 2018 ha rivisto la luce – ed è dunque ancora nuovo, ancora nostro – grazie ai tipi delle edizioni Conoscenza con introduzione critica di Francesca Borruso. «Gli errori della vecchia scuola, secondo Dewey, risiedono in primo luogo nella centralità del sapere del maestro che prevale su quello degli alunni; nella concezione del testo scolastico come depositario del sapere certo e incontrovertibile; nella uniformità dei programmi e dei metodi utilizzati che sono uguali per tutti i bambini, non contemplando la diversità di interessi e predisposizioni che caratterizza ciascun individuo; nella visione dell’apprendimento come trasferimento di nozioni che il ragazzo, passivamente, deve recepire» (Scuola e società). Capovolgere, dunque.
Da quel “passivamente” si intuisce bene come Lombardo Radice debba aver fatto propria la lezione di Dewey, come il suo pamphlet si sia necessariamente nutrito di un testo che il filosofo americano aveva elaborato nel 1899, parlando non a caso di «rivoluzione copernicana» nel campo dell’educazione: «Ora con l’educazione nuova si sta verificando lo spostamento del centro di gravità. È un cambiamento, una rivoluzione, non diversa da quella provocata da Copernico, quando spostò il centro dell’astronomia dalla terra al sole. Nel nostro caso il fanciullo diventa il sole intorno al quale girano gli strumenti dell’educazione. Esso è il centro intorno al quale essi sono organizzati» (Dewey, cit.). Una rivoluzione non ancora del tutto compiuta, se si pensa alle difficoltà che la scuola attraversa, pur nella distanza.

La convergenza tra Dewey e Lombardo Radice emerge ancora più forte nella dimensione creativa del fanciullo, nella valorizzazione del momento “magico” rappresentato dalla sua fantasia (Cantatore parla, infatti, di «attenzione vygotskiana» e di «sensibilità educativa» che ritroveremo più tardi nel Rodari della Grammatica della fantasia): «In iscuola le colpe e i castighi sono prestabiliti. Durante la lezione: passa una musica, un ragazzo batte il tempo e non ascolta più: delitto; due scolari si molestano tra loro, e non si indaga il perché nelle loro piccole anime: disturbatori tutti e due, punizione; un bambino ha portato a scuola la sua piccola collezione di cianfrusaglie raccolte dappertutto (che cosa non si trova nelle tasche di uno scolaro!): invece di ammirare e sorridere e coglier magari l’occasione d’una simpatica conversazione, vengono le sgridate, la punizione; un altro sgorbia di pupazzi un quaderno, la qualcosa è purtroppo assai spesso l’unico modo che abbia di dare sfogo alla sua attività, diciamo così, artistica; ma… è distratto: nota in condotta; due si aiutano in una prova, l’aiutarsi è frode: e si dovrebbe invece incoraggiare la collaborazione e promuovere le amicizie!».
Proprio «eretico e corsaro», Lombardo Radice, specie quando sostiene senza mezzi termini che «La scuola […] può segnare un arresto educativo, quanto la mancanza di scuola» perché «le classi dirigenti hanno un ideale ben preciso di scuola; la scuola misurata, l’uomo “su misura” […]. Aiuta questa meccanizzazione della scuola il cristallizzarsi della cultura in cultura fatta». Cos’è una “cultura fatta”? Una cultura paga di sé, dei “risultati” raggiunti. Ha un corpo la cultura in Lombardo Radice, proprio come un «uomo fatto» non prosegue nella conoscenza che considera acquisita e indiscutibile. Ma il «pensiero fatto» così «non è più pensiero». Il passato diventa inservibile se non «è quel che tu fai, ri-creandolo».
Impossibile non rilevare l’attualità di Come si uccidono le anime (e di Scuola e società, figli anche di una comune matrice hegeliana), la drammatica attualità pandemica di queste considerazioni in seno a una constatazione: 105 anni dopo la pubblicazione del saggio di Lombardo Radice, nel secolo della velocità delle scoperte scientifiche, siamo ancora di fronte all’incredulità per una scienza, la medicina nello specifico, che non ci dà risposte, almeno non immediate, non fondate sulla certezza. Il problema è allora “il problema”: la nostra educazione vorrebbe risolvere, fornire risposte, mentre il suo cuore, la sua insostituibilità sta nel «rigenerare il problema», come spiega ancora Cantatore e come scrive anche Franco Cambi, per il quale «la didattica di Lombardo Radice si risolve in una «ricerca continua e problematica». Educatore, dunque, alla stregua d’un maestro che forgia in bottega il giovane artista, pittore, poeta; riecheggiano i versi di Titos Patrikios da “I simulacri e le cose”: «Passando in rassegna le cose già accadute / la poesia cerca risposte / a domande non ancora fatte». Lombardo Radice lamenta proprio che «l’ignorante popolo sano non ha ancora trovato il poeta che canti la sua rozzezza, tutta piena di desiderio di comprendere», ragionando su un paradosso espresso da Prezzolini: «“La cultura popolare esisteva quando non se ne parlava, ed ha cominciato a finire quando se ne è parlato”.
Ossia, mentre il popolo, quasi abbandonato a se stesso, era costretto a farsi da sé una cultura, vera e propria, perché spontanea, perché originale, perché autoctona; ora il popolo imboccato la riceve già fatta, come cosa non sua, la subisce, non spontanea, nata in altro clima e in altro terreno. Quella di prima era una cultura popolare (del popolo), quella di oggi è una cultura popolarizzata (data al popolo). […] La cultura… composta di tabloidi, “scienza per tutti”, di pillole e di compresse “manuali e riassunti”. Non ha radici naturali nel popolo». Un’anticipazione della definizione di cultura pop che di lì a poco si sarebbe fatta avanti con urgenza.
E, a proposito di “cultura pop”: il cinema, le arti visive. Nel 1943, all’interno degli studi EIAR, s’incontrano due giovani artisti in sala di registrazione per incidere le voci di Cico e Pallina, un fortunato radiodramma dell’epoca. Ma fortunato è anche l’incontro, come tra Cico e Pallina, tra Federico e Giulietta, Federico Fellini e Giulietta Masina. Una storia che ora è raccontata anche in un picture book delizioso, Giulietta e Federico (Carmelozampa, 2020), scritto da Federica Iacobelli e illustrato da Puck Koper. Forse lo stesso Fellini ne sarebbe rimasto estasiato, almeno così s’intuisce leggendo la lunga intervista a cura di Giovanni Grazzini confluita nel volume Sul cinema (“Il Saggiatore”, 2019).
Una conversazione dove risalta, tra gli altri, un tema: la sensibilità educativa di Fellini, una felliniana attenzione alla creatività infantile. «Il bambino – spiega il regista riminese – arriva a scuola in un’età in cui i confini fra l’immaginazione e la realtà, fra il mondo della coscienza, che è appena agli inizi, e quello assai più ampio e scontornato dell’irrazionale, del sogno, della comunicazione profonda, sono confini molto esili, separati da una membrana ancora sottilissima che conserva un respiro poroso in cui si verificano scambi, osmosi, improvvise infiltrazioni. Questa specie di stato di grazia che poi scompare rapidamente con gli anni, invece di essere riconosciuto e di venir protetto come cosa preziosa, un deposito aureo di conoscenza, di dilatamento delle capacità vitali, viene dalla scuola programmaticamente ignorato, quasi visto con sospetto, con diffidenza, se va a interferire con quell’ordine convenzionale in cui il bambino deve essere incasellato.
Non è colpa di nessuno, fa parte della pigrizia mentale, della svogliatezza, dell’incapacità che in genere mettiamo nei problemi dell’educazione» (Sul cinema, cit.). No, questo non è Lombardo Radice, è Federico Fellini, un Fellini che si rammarica di non aver mai girato questo film: «una storia con una trentina di bambini di due, tre anni, che vivono in un caseggiato alla periferia della città. Mi attraggono le misteriose comunicazioni telepatiche fra i bambini, gli sguardi che si scambiano negli incontri per le scale o sui pianerottoli, quando stanno dietro una porta o dentro una culla o sono tenuti per mano come mazzi di insalata» (ivi). Mi accorgo di aver riportato, inizialmente, “telematiche” in luogo di “telepatiche”: forse uno dei segni, dei sogni, dei disegni tipicamente felliniani, tremendamente “bambiniani”. E segno/sogno di una problematica tremendamente irrisolta, forse irrisolvibile, ma certamente e perciò ancora discutibile, nel suo senso più pieno, nel senso che ancora oggi ci ricorda l’attualità di Lombardo Radice.