Maggio Fiorentino / La Siberia resuscitata di Umberto Giordano
I - Cum mortuis in lingua mortua
Come si resuscitano i morti? Secondo il dottor Frankenstein è questione di elettricità, secondo Federico Ruysch di conservazione e congiunzioni astrali, se invece sentiamo la vera Autorità, "Lui", non c'è tecnica che tenga. Ma se per 'morti' intendiamo opere non più eseguite, dimenticate negli archivi degli editori, e per 'resuscitare' rimettere in scena, riaprire per esse il grande libro del Repertorio e far spazio nei margini per il loro nome, le autorità sono altre, e alcune devono senz'altro risiedere a Wexford, in Irlanda, e a Martina Franca, in Valle D'Itria, dove da anni ci si adopera a questo scopo – altre ancora nel piccolo Teatro Grattacielo di New York, un'enclave italiana di melomani coraggiosi. I nomi degli impavidi sono pochi, molti i morti che attendono, a diritto o meno, di essere riportati in vita.
Entriamo in queste catacombe, aggiriamoci tra i loculi. Sono centinaia: qui un bozzetto di vita napoletana, su testo di Salvatore Di Giacomo (Mese mariano), qui un'opera di ambientazione medievale, fiabesco e dannunziante (L'amore dei tre re, di Sem Benelli/Montemezzi), qui un D'Annunzio vero ed erotico (Isabeau per Mascagni), qui quasi un giallo, quasi un complotto internazionale (Fedora, ancora Giordano), né mancano due premi Nobel (Risurrezione di Hanau/Alfano da Tolstoj) e, molto più tardi, I Cavalieri di Ekebù di Rossato/Zandonai da Selma Lagerlöf).

Tanti di questi appartengono alla cosiddetta "opera verista", un'indicazione vaga che mette insieme i lavori di compositori nati nella seconda metà dell'Ottocento, detti anche della "Giovane scuola". Perché tanti caduti fra loro? Chi li ha ammazzati?
I maggiori sospettati sono gli specialisti: gira la voce secondo cui alla prima riunione dei collaboratori scelti per la capitale Storia dell'Opera italiana EDT si fosse subito messo in chiaro «il Verismo naturalmente non lo facciamo». Da un lato, a metà Novecento, l'attenzione degli studiosi militanti era più incline a quella radicalità degli esperimenti formali forse meno allettanti per il pubblico, certo più consoni alla contemporaneità, almeno secondo la lettura adorniana. Insieme a ciò, si provava un certo imbarazzo per quei compositori che erano stati costretti, o avevano cercato, per restare a galla, compiacenti rapporti con il regime fascista. Mascagni ne è un esempio, non solo per il greve Nerone, ma anche per tutta la pubblicistica dei Carri di Tespi, e dei concertoni celebrativi – ma anche Giordano dovette resistere alla richiesta di un'opera su Enea.
E poi c'è stato, e c'è, il pubblico, occupato dalle tante Renaissance della seconda parte del Novecento, da Verdi, a Rossini, al belcanto in generale, alla più recente barocca. Musica che imponeva le sue difficoltà esecutive, di volta in volta diverse, ma di certo esonerava i cantanti dall'affrontare orchestrazioni dense e sforzi, scritture vocali talvolta violente, pericolose per le voci.
Eppure in quel mondo, in quegli Ultimi splendori dell'opera italiana, per citare un imponente volume a cura di Johannes Stricher su Francesco Cilea, Umberto Giordano e Franco Alfano, c'è tanto da scoprire: se il futuro del melodramma italiano è stato "interrotto" come Michele Girardi ha azzardato, dalla morte di Puccini e dall'impossibilità di portare a compimento la svolta drammaturgica di cui Turandot aveva gettato le basi, tanti sono i nomi che i cartelloni ignorano, non tutti aprioristicamente privi di valore: Smareglia, Franchetti, Montemezzi, Gnecchi e tanti altri, tutti nati nel ventennio dalla metà degli anni '50 alla metà dei '70.
Resuscitare i morti: l'ingrediente che non deve, non può mancare è la fiducia – fiducia nella storia rappresentata, nelle qualità della partitura, nel cast. Più facile, naturalmente, è resuscitare un morto fresco, come deve aver fatto Verdi con La Traviata e Giacomo Puccini con la sua Madama Butterfly a Brescia dopo il fiasco della prima scaligera del 1904.
II - «Cosa essere tu?»
Ecco, ripartiamo da Butterfly. Giulio Ricordi descrive quella caduta sul palco della Scala «come se i russi in serrati battaglioni d’oste nemica volessero dar l’assalto al palcoscenico per spazzar via tutti i giapponesi pucciniani» alludendo alla contemporanea guerra russo-giapponese, ma anche, secondo quanto ci ricorda lo stesso Girardi, alla probabile adozione di una potente clacque a danno della piccola Cio-cio-san pucciniana. E da chi sarebbero stati capitanati i "battaglioni russi"?
Tre mesi prima, il 19 dicembre del 1903, su quello stesso palco debuttava Siberia, opera lirica in tre atti di Luigi Illica, musica di Umberto Giordano. Con Butterfly Siberia condivideva i tre protagonisti (Rosina Storchio, Giovanni Zenatello, Giuseppe De Luca), e il direttore Cleofonte Campanini. L'esito, stavolta positivo, avrebbe consentito all'opera nuova nata di compiere un giro tra piccole e grandi città nei mesi e poi negli anni successivi.

Questa divergenza di fortuna ha origine in un momento particolarmente burrascoso della guerra editorial-impresariale tra le case Ricordi (Puccini) e Sonzogno (Giordano), e non è escluso che il primo abbia imputato proprio al secondo l'opera di sabotaggio del pubblico. È un dato di fatto, però, che come le produzioni di Madama Butterfly da Brescia in poi (nel maggio di quello stesso anno) crebbero, e oggi non accennano a diminuire, quelle di Siberia, nonostante la partecipazione di qualche grande voce come Titta Ruffo, Gilda Dalla Rizza, Maria Caniglia, e bacchette come Toscanini, Mascheroni, de Fabritiis, si diradarono sempre più, fin quasi a scomparire. Nel secondo '900 in Italia se ne contano quattro in tutto, di cui tre nella città natale del compositore, Foggia, nel teatro a lui dedicato. Due nei 2000, una a Martina Franca (2003), l'altra al Conservatorio di Milano (2014), in forma non scenica.
Come riportare allora Siberia in vita? Intanto facendo la sua conoscenza, provando a scrutarla, a interrogarla come Alice: «cosa essere tu?», le chiedeva il Brucaliffo.
Il Maggio Musicale Fiorentino ce ne dà l'occasione con quattro repliche estive di una nuova produzione: Sonya Yoncheva nel ruolo della protagonista (Stephana), Gianandrea Noseda direttore alla testa del complesso dell'opera fiorentina, Roberto Andò regista.
La trama è un collage del librettista Luigi Illica, proveniente da fonti diverse: da Memorie da una casa di morti di Dostoevskij per sua stessa ammissione, da Resurrezione di Tolstoj (Alfano ne avrebbe tratto la sua Risurrezione nemmeno un anno dopo), dal Reportage Siberia dell'americano George Kennan (lo suggerisce Franca Cella), e persino, come propone Simonetta Petruzzi, dagli Orrori della Siberia di Emilio Salgari, usciti nel 1900.
I versi dell'incontenibile Illica sono, come sempre, caratterizzati da goffaggini («Se tu mi baci io bacio l'acuto odor / di tutti i fior»), tentativi di letterarietà alta («Oh quando schiuderai l'ala raggiante / sognata libertà!»), zoppi preziosismi («Le nostre voci / che rassembran baci/ sono feroci!.../ Tacciamo»), lievi sadismi pruriginosi («La conobbi quand'era fanciulla, / aveva una sdrucita corta gonnella /che le copriva... nulla», in cui la povertà e l'inesperienza di Stephana sono tutt'uno), e la capacità, nei momenti di acme passionale, di unire tutto ciò nello spazio relativamente contenuto di pochi versi:
«Sei tu la mia tortura umana?
[...]
Io vedo mille braccia
intorno a te! A miriadi!...
A selve di tentacoli!...
Pel seno! Pei capelli!...
Sovra il tuo fronte
tutte l'onte
veggo e la mia viltà!»
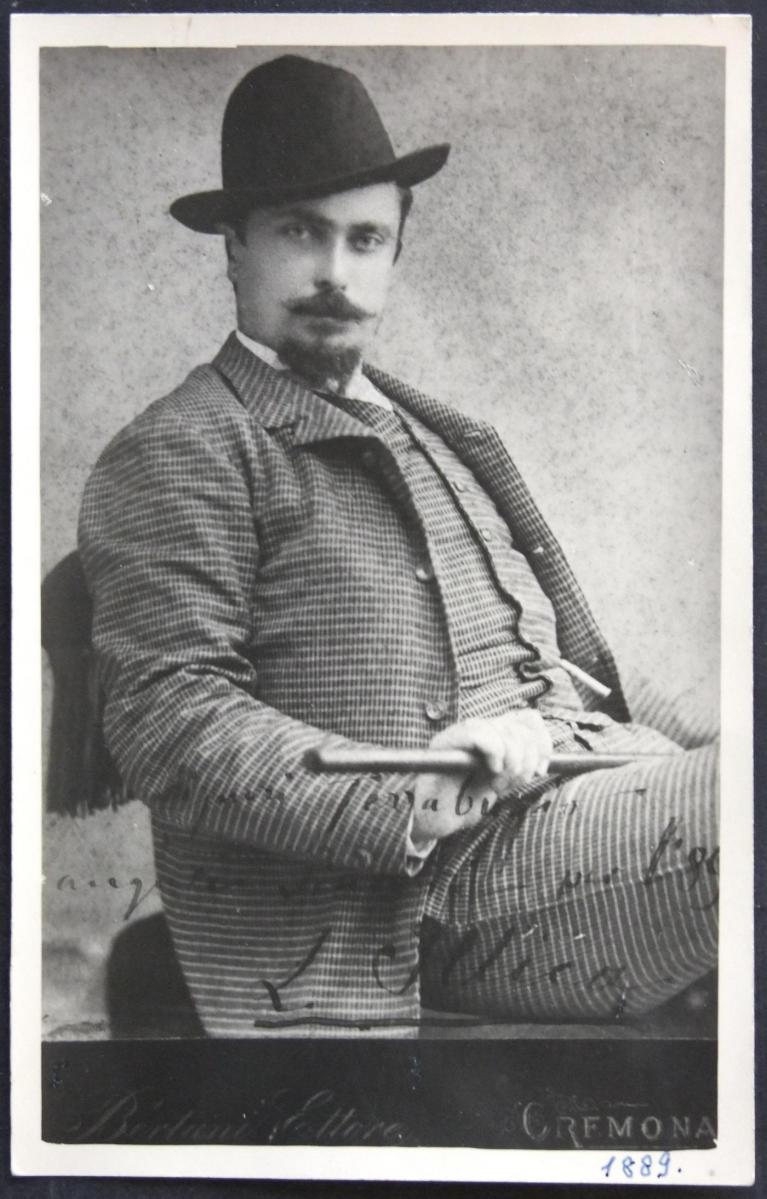
La forza di Illica non è mai stata nel verseggiare (Puccini e Ricordi lo capirono bene, e lo affiancarono al più elegante Giacosa, con qualche protesta dell'arquatese), ma nel taglio drammaturgico dei libretti. E qui non fa eccezione. Ogni atto ha una sua chiara struttura interna e l'intera opera ha un segno chiaro di "sprofondamento" che si conclude precisamente sottoterra – a proposito di resurrezioni.
Il primo si svolge a San Pietroburgo ed è l'atto "cittadino". Qui, un po' convenzionalmente, si dipinge un ambiente sociale vivace e corrotto, in cui la mantenuta Stephana (soprano), ben istruita dal suo primo amante e attuale lenone Glèby (baritono), accetta regali dal principino Alexei (tenore), pur amando da due mesi il giovane soldato Vassili (tenore), in procinto di partire per la guerra, il quale non sa nulla della vita dissipata di lei, che per amore sta già pensando a cambiare rotta. Quando Vassili, giunto in casa per salutare la vecchia famigliare Nikona, cameriera in quella casa, scopre la condizione di Stephana ma, soprattutto, il suo rapporto con il principe Alexei, perde la testa e con la sciabola lo ferisce.
Le conseguenze saranno nell'atto secondo: Vassili è in Siberia e, similmente a quanto accade in Resurrezione, ma a ruoli invertiti, la sua amata lo raggiunge per scontare con lui la sua pena. È questo l'atto universalmente più amato dell'opera (ne scrisse bene Gabriel Fauré e il Preludio è stato registrato diverse volte come pezzo staccato): c'è un coro dei battellieri del Volga, adottato da Giordano come grande effetto di ingresso della "catena umana" dei forzati, che conducono una marcia nella neve fino all'arrivo al campo; c'è qualche piccola scena di pietà fra povera gente, la figlia di un forzato e un cosacco di buon cuore; c'è l'ingresso di Stephana che ha raggiunto il suo Vassili e vuol vivere con lui; c'è la chiusa sulle note dalla "catena umana" che riparte. Il terzo atto vede nuovamente l'ingresso di Gléby, che, ancora acceso per la «bella Stephana», vuol fuggire con lei attraverso un passaggio segreto di cui è venuto a conoscenza, nascosto dentro a un pozzo asciutto. Lei ovviamente non vuole saperne e lui, ricevuto il suo rifiuto, prima svela ancor più chiaramente a Vassili la condizione della sua amante-mantenuta, poi, resosi conto che intendono scappare per il passaggio da lui suggerito, li denuncia alle guardie. Queste li seguono, parte una fucilata, lei muore, Vassili si dispera, si annuncia l'arrivo di nuovi prigionieri al campo.
Fatta la sua conoscenza, studiato l'attento inserimento di temi originali, la mancanza di una cantabilità diffusa che ci aspetteremmo, a favore di un nervosismo passionale spezzato e pieno di accelerazioni, ora a questo lavoro occorre dare fiducia.
III - Spazio e fiducia a Siberia
Gianandrea Noseda gliela dà, insistendo sulla densità della partitura con un piglio sinfonico, pieno di colori, talvolta, specie nel primo atto, correndo il rischio di mettere in secondo piano le voci (nel secondo e terzo atto i "pesi" in campo sono più cospicui, compreso quello del coro), o comunque di non fonderle appieno nel crogiuolo vivissimo della sua orchestra. Il coro è preciso e conscio del suo ruolo, riesce a conferire, per quanto è nelle possibilità della scrittura Giordaniana, l'"effetto russo" allo spettacolo.
I tre protagonisti, guidati da Yoncheva, sono ineguali nella resa. Il Vassili di Giorgi Sturua fatica a imprimere al suo mezzo un indirizzo preciso, forse esageratamente preso dalle richieste tecniche pur onerose della parte, e risolve il compito ricorrendo alla corda eroica ma non luminosa, piuttosto grigia nel complesso: ne scapitano la chiarezza della dizione, la varietà dell'accento ma, soprattutto, una resa più sottile del personaggio che anche scenicamente risulta lasciato a sé stesso. Al contrario, il Glèby di George Petean, pur non potendo vantare un colore particolarmente scuro e volgendo il suo personaggio più allo scaltro che al violento, costruisce un vilain insinuante e, dove occorre, volgare, ben in sintonia con i versi di Illica.

Ma a brillare è Sonya Yoncheva: laddove lei è convinta, poiché questa di Siberia sembra proprio una battaglia personale sua e di Noseda, laddove riesce a stringere con la buca un rapporto saldo e profondo, lì emerge vocalmente luminosa, rotonda, e la musica mette le ali dando conto del senso di un'operazione come questa. Ed è in effetti la più in parte fra tutti, specialmente negli atti del campo, ove comprende che non deve sovrastare il grande meccanismo di un'opera-quadro, ampia. Illica l'avrebbe voluta più storica ma, nonostante le sfoltiture di Giordano («niente nihilisti, niente decabristi» chiedeva al suo librettista) Siberia rimane un affresco ampio, popolato da un coro spesso in primo piano e da diversi brulicanti personaggi minori – anche con il taglio di due di essi nella versione del '27 che vediamo a Firenze, considerata dall'autore definitiva.
Purtroppo, ciò nonostante, è la parte registica che fallisce e che sovente lascia sola la protagonista, con tutti i suoi sforzi.
I problemi registici di questa produzione si possono distinguere in tre livelli: quelli minimi, dei dettagli, insignificanti da un punto vista generale ma sintomatici di un approccio affrettato, generico; quelli di ambientazione, di medio calibro; quelli fondamentali, di lettura e resa, sui quali si gioca la delicatissima operazione di porgere un'opera a un pubblico che non la conosce.
I primi: finale atto primo, Vassili ferisce Alexis con la sciabola. La didascalia recita «[...] due ufficiali affrontano Vassili che, sorpreso egli pure dalla rapidità di quanto è accaduto, gitta lontano da sé la sciabola sua, rassegnato al suo destino». Nella regia di Andò, invece, Vassili punta a freddo una pistola contro il petto di un Alexis disarmato e fa fuoco quasi a bruciapelo. Più avanti, finale dell'opera: sulla musica straniante di un concerto di balalaike, Stephana e Vassili in fuga sono raggiunti nel pozzo, lei è colpita da una fucilata, i due sono trascinati fuori, lui legato, lei in fin di vita canta l'addio.
Della prima parte della scena il pubblico non dovrebbe veder nulla, tranne forse l'ansia di Glèby, che dopo aver denunciato i due attende allo scoperto che vengano catturati; nella seconda dovrebbe, semplicemente, piangere. In ciò sta un elemento di spaventoso vuoto di azione ma non di tensione, che la regia dovrebbe saper tradurre con i suoi strumenti scenici, a cui segue lo sfogo del finale. Nella messinscena fiorentina l'inseguimento è ripreso e proiettato in un video, accompagnato dalle balalaike, poi i due escono dal sotterraneo praticamente con le loro gambe, lui lontano e invisibile, quasi oltre il pozzo che sorge a metà scena, lei agonizzante, pure da sola, senza nemmeno una guardia a trascinarla in terra. Il regista prima non riesce a far vivere quel vuoto di azione e lo copre con un video, poi dimentica l'azione vera, quando i protagonisti sono alla scena finale, sul palco.
Questi due esempi non si appuntano sull'obbligatorietà del rispetto del libretto nelle sue didascalie, ma sulla necessità di una lettura di testo e musica più attenta. L'azione di Vassili nel primo atto non è un'esecuzione sommaria, ma un'intemperanza da giovane con conseguenze spaventose (la storia di Siberia non è quella di una giusta punizione di un assassino, ma quella, sulla scia di Traviata dell'impossibilità di redenzione, anche pagata con la propria stessa vita).

Passiamo al secondo "calibro" dei problemi: l'azione è trasferita al tempo delle purghe staliniane – e fin qui l'operazione è legittima, anche con qualche "correzione" del libretto, persino con qualche trovata che sa di boutade, come la proiezione del faccione di Stalin durante il «Cristo è risorto». Ciò che è invece autolesionista, e certamente non originale, è l'idea di costruire un secondo ulteriore piano drammaturgico per cui tutta la vicenda rappresentata è all'interno di un set cinematografico, in un teatro di posa nel quale, di tanto in tanto (ma nemmeno così spesso) tre sparuti soggetti, un cameraman, un microfonista, un assistente di produzione girano attorno ai cantanti che recitano la loro parte. E tutti gli edifici hanno i loro bravi telai e cantinelle a vista.
Anche qui: la costruzione di un piano ulteriore, "fuori", non costituisce un problema di infedeltà alla lettera, né perché banale, né perché discontinuo. Dimostra l'incomprensione del canale comunicativo di Illica e Giordano, che non è quello della presa di distanza, ma anzi dell'immersione, dell'"effetto", anche dell'"effettaccio", in alcuni casi. Attraverso l'effetto i due ci tirano nel groviglio tra storia personale e storie comuni, tra destino del singolo e complessivo. Musicalmente questa dinamica è resa da Giordano in maniera un po' convenzionale ma comunque efficace: nel secondo atto è un continuo andirivieni dal singolo all'insieme, così nel terzo, in cui sia lo svelamento di Stephana a opera di Gleby che il violento rintuzzarlo sono compiuti di fronte alla comunità dei deportati. E il finale: dopo la morte della protagonista emerge una voce, che annuncia l'arrivo di una nuova colonna umana, ed è l'ultima battuta del libretto: la storia dei due amanti è già pronta per essere riassorbita dalla macchina del campo.
Scenicamente questa dinamica si tradurrebbe nei rapporti tra masse e singoli, tra pieni e vuoti, tra gli angusti spazi del privato e gli slargati del pubblico, con l'immensa Siberia ai quattro lati. Ma una scelta drammaturgica come quella del set cinematografico annulla già al principio questa possibilità. Gli inserti video, spesso stretti sui protagonisti, non servono a questo scopo. Ecco il terzo errore.
Anche la scena della catena umana dei forzati, da molti commentatori del tempo riferita come impressionante nel suo lento emergere dal non-luogo della marcia, manca: essi sono già tutti in scena, cantano verso il fondo, poi si voltano lentamente. L'elemento sonoro è in parte mantenuto, non quello spaziale. Senza studio e dialettica degli spazi, la musica scenica non ha luogo per estendersi ed evocare; i protagonisti non sanno dove si trovano né sono in dialogo con il pubblico; il coro sta seduto in terra. Sono questi i problemi fondamentali della resa scenica di questa Siberia, quelli che possono rischiare di mancare l'incontro con la platea.
Ma se al comparto di regia è mancata la fiducia in un'opera da leggere, da comprendere, da restituire, fortunatamente la fiducia nell'oscura, appassionante pratica dell'evocazione dall'oltretomba è salda nella direzione artistica del Maggio: dopo questa Siberia, preceduta da La Rondine, Risurrezione, Adriana Lecouvreur, si prepara per l'anno prossimo un Amico Fritz, la più elegante, l'unica borghese tra le opere del livornese Pietro Mascagni.







