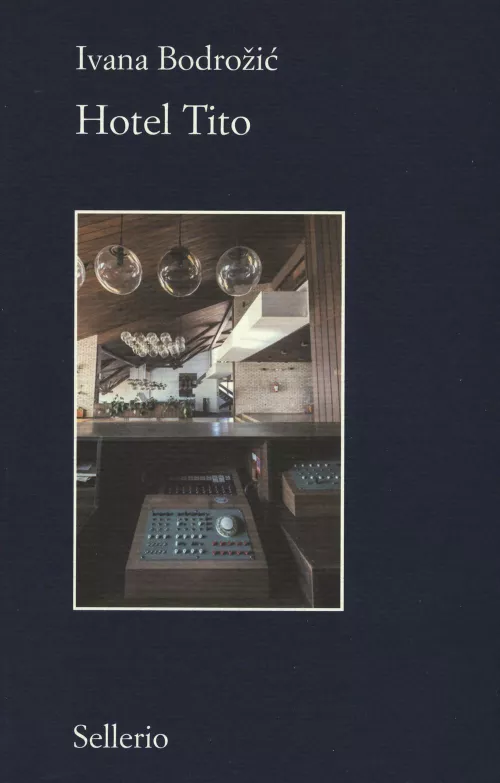Vukovar / Hotel Tito
Aveva nove anni nel 1991 Ivana Bodrožić quando, in una torrida estate, la guerra ha inghiottito la sua infanzia e ha segnato la sua vita una volta per tutte. Il ricordo trattiene qualche flash, una battuta del padre, un certo nervosismo nell'aria. Un litigio tra i genitori, la notte prima della partenza per il mare, lei, il fratello di sedici anni e una vicina, perché il padre si era rifutato di accompagnarli fino a Vinkovci per evitare che si potesse pensare a una fuga, per il timore di possibili ritorsioni. Ma tanto i serbi che i croati cercano di mettere al sicuro i figli. Per chi rimane è un conto alla rovescia, il 25 agosto inizia l'assedio di Vukovar.
Per Ivana è la prima volta su un'isola, ci sono giochi e dispetti del fratello, il soggiorno si prolunga e arriva la nostalgia di casa, mentre sta entrando in un'altra dimensione dove il domani diventerà uno stato di apprensione continua. Non si torna a scuola, si va a Zagabria, dai parenti, all'inizio affettuosi e solidali, poi, con il passare delle settimane, sempre più insofferenti.
“Era già da un po' di tempo che papà non si faceva sentire. Io e mia cugina pregavamo spesso. Ci inginocchiavamo davanti al divano e ad alta voce, per farci sentire da tutti, pregavamo per tutto quello che ci veniva in mente. Per la pace, per l'esercito croato, per Petrinja, per Cesare e Cleopatra, dopodiché facevamo le sciocchine e ridevamo, ma di nascosto”.
La ragazzina origlia i discorsi dei grandi, cerca di captare le notizie, mette in uno schema mentale i noi e i loro, gli ustascia e i cetnici, parole che intanto sono diventate pallottole.
Chi scrive Hotel Tito (trad. di Estera Miočić, Sellerio, 2019) è una donna ormai adulta, il testo originale è del 2010, il discorso interiore e i ragionamenti sono quelli di una ragazzina che sta crescendo mentre, poco lontano, la sua città sta diventando un cumulo di macerie e qualcosa di incredibile come la guerra penetra nella quotidianità. I profughi di Vukovar, che sono arrivati a Zagabria, sono stati prima ammassati e poi sparpagliati, distribuiti in location via via più distanti dal centro città. La madre, il fratello e Ivana finiscono in una costruzione stramba, che ha 150 camere, un ambulatorio, una sala sportiva e un rifugio atomico: è l'ex scuola di partito della Lega dei comunisti a Kumrovec (la struttura in rovina è stata recentemente acquistata da un'imprenditrice cinese, la signora Ju), dove è nato Tito e si può visitare la sua casa natale. Si trova nella regione dello Zagorje, ai confini della Slovenia, terra di rivolte contadine, tradizionalmente poverissima, benestante poi.
“Quando siamo arrivati era uno splendido autunno. (…) La gente litigava e c'era ressa. Tutti volevano avere una camera in più, una camera al primo piano per i bambini, per il marito che sarebbe tornato o in nome di qualche altro diritto per il quale era giusto urlare”. Una stanza si trasforma in luogo di preghiera, ogni domenica si celebra la messa, l'altare è la grande scrivania dove sono stati stipati i libri e i ritratti di Tito.
Nell'albergo sopravvive una collettività sofferente, di vecchi donne bambini, costretta a una intimità forzata e claustrofobica che durerà anni. Ivana descrive quello che capita con la sincerità della spietatezza adolescente. Anche nel suo triangolo famigliare la tensione è inevitabile, quando i bisogni di abiti musica serie tivù si scontrano con le condizioni di un'esistenza ridotta all'essenziale, con il dolore di una madre che cerca di reagire: ma come si fa a dirle che si vuole andare in disco? “Mia madre diceva spesso che a Vukovar non si reggeva in piedi per la stanchezza del lavoro in fabbrica, del dover stare dietro ai figli, alla suocera, alla casa. Ora invece poteva dormire quanto le pareva, anche tutto il giorno se voleva, perché all’hotel non c’era niente da fare, se non aspettare. L’attesa. Aspettavamo il ritorno di papà, la liberazione di Vukovar, una casa. Anche se nessuna di queste cose dipendeva dalla nostra volontà noi cercavamo comunque di fare qualcosa. Andavamo alla Croce Rossa, lasciavamo la foto di papà, l’immagine dell’uomo abbronzato con addosso una canottiera nell’ombra della casa di famiglia il giorno del mio nono compleanno”.

Il racconto di Ivana fa venire in mente un libro importante come L'età del transito e del conflitto. Bambini e adolescenti tra guerre e dopoguerra 1939-2015 (a cura di Maria Bacchi e Nella Roveri, il Mulino, 2016), raccolta di voci, memorie d’infanzia di chi ha vissuto durante la Shoah, le guerre jugoslave, le fughe dall’Afghanistan e dall’Africa.
A Kumrovec un centinaio di ragazzini frequenta la scuola di paese, dove i locali, che hanno addosso l'odore della stalla, sono sbeffeggiati e chiamati Porcellini da chi è nato in una vera città. Le differenze sociali e culturali, le abitudini e gli stili di vita: tutto si mescola e si esaspera nella vita parallela dell’Hotel Tito. Ivana avverte sulla propria pelle le sfumature ambivalenti della solidarietà, perché il profugo è trattato come uno sfigato, ma è considerato anche un privilegiato che non deve pagare nulla.
La madre e il fratello continuano a scrivere lettere tragicamente gentili − al presidente del nuovo stato, ai rappresentanti dell’esercito − per chiedere l’appartamento al quale hanno diritto. Passeranno anni prima che riescano ad avere una piccola nuova casa. “Bianco. Innanzitutto mi ha accecato il biancore delle pareti fresche di pittura. Uno spazio puro e privo di parole pronunciate; le pareti innocenti che non avevano ancora udito liti, pianti, risate. Abbiamo perlustrato lo spazio, stanza dopo stanza, camminato sul parquet come se non fosse nostro, abbiamo deciso chi andava dove, sentendoci come in un sogno…”.
Solo alla fine del libro, tradotto in più lingue e pluripremiato, arrivano i ricordi felici del mondo di ieri, di un padre simpatico che viziava la figlia ed era benvoluto. Non si vuole immaginare il dopo. La paura, il terrore, la violenza. Il massacro di militari e civili, nella notte tra il 20 e il 21 novembre, due giorni dopo la resa della città, liquidati nella zona agricola di Ovčara. Il corpo del padre di Ivana Bodrožić è tra quelli che non sono mai stati ritrovati.
La battaglia per Vukovar riporta la guerra in Europa. Le modalità belliche del conflitto inter-jugoslavo di fine Novecento continueranno a replicare il suo copione. La provincia aveva 82.024 abitanti, il 37,4% era costituito da serbi, il 43,7 % da croati, tutt’intorno alla città villaggi a maggioranza serba si susseguivano a quelli a maggioranza croata – i casi di scontri interetnici sono dieci volte più numerosi in quelli colonizzati dopo la seconda guerra mondiale da abitanti delle zone povere del paese, serbi della Bosnia e della Krajina, croati del retroterra della Dalmazia e dell’Erzegovina occidentale. Subito a nord c’è Borovo selo, il paese dei pini, dove il 1° maggio 1991 un pullmino di poliziotti croati viene attaccato da gruppi di miliziani serbi “secessionisti” che temono il nuovo governo di Franjo Tudjman. E il referendum che avrebbe dichiarato l’indipendenza e minacciato l’autonomia della componente serba, fino a quel momento dominante nell’esercito, nella polizia e nell’appena disciolta Lega dei comunisti. Vukovar è destinata a diventare un simbolo. La posta in gioco è il futuro assetto della federazione jugoslava. Per Franjo Tudjman i morti di Vukovar − i civili sono cinque volte i militari − non sono mai troppi, se devono servire a convincere la comunità internazionale a riconoscere il nuovo stato. Slobodan Milošević sta cercando di serbizzare l’esercito, fino a quel momento formalmente ancora federale, l’efferatezza è la firma delle bande di Arkan che arrivano da Belgrado.
Un’escalation inesorabile: per la “pulizia” di territori che non verranno spartiti, ma “liberati”. La popolazione civile fa da bottino: trasformato in assassino o profugo ogni singolo diventa nemico dell'altra etnia e ostaggio della propria. Ancora oggi, per l'opinione pubblica croata, l'assedio di Vukovar è un tema tabù: per i crimini compiuti dai signorotti locali, per il sospetto che i politici della metropoli abbiano speculato sulla caduta della città (un bel libro è quello di Alenka Mrkovic, 91,6 MHZ, Con la voce contro i cannoni, Algoritam, Zagreb 1997, giovane giornalista che racconta l’esperienza dei radio-amatori di Vukovar).
Le differenze storiche e culturali fra i diversi territori che formano la Jugoslavia del “secolo breve” determinano tensioni nelle regioni miste come la Slavonia, terra ricca, con grandi tradizioni di lotte politiche dove le giravolte della storia hanno sempre prodotto rovesciamenti nell’equilibrio di forze tra le diverse anime nazionali. Oggi le foto color seppia dicono la nostalgia per la cittadina liberty, i memoriali ricordano quanto è accaduto. Ricominciare a mischiarsi non è stato facile, dopo che una parte dell’accordo di Dayton (1995) ha previsto la reintegrazione della regione nel neo stato croato e il ritorno della componente serba (ora il 33%). I politici continuano a costruire la loro legittimità sulla divisione, l’uso dell’alfabeto cirillico è continuamente contestato. Nelle scuole i bambini si dividono già sulla soglia, gli stessi insegnanti lavorano separati. Come in città fanno tutti: si sa esattamente quale bar è serbo e quale croato, chi ascolta Radio Danubio e chi invece Radio Vukovar. Anche l’iniziativa di un asilo inglese super partes ha prodotto il suo doppio, un asilo americano.
Ivana Bodrožić prova a catturare gli ultimi pensieri di suo padre: “pensava a me, a mia mamma, a mio fratello. Poi di nuovo a me. I pensieri erano spezzati, era difficile creare un flusso. In mezzo a tutte quelle urla, colpi, tagli, spari. Mentre noi eravamo non lontano da lì, al sicuro, in una casa di Zagabria, loro venivano macellati. L’ultimo prigioniero se la sarebbe vista più brutta di tutti, avrebbe dovuto assistere ad ancora nove ore di sterminio. Macellare era un lavoro duro, bisognava pure mangiare e bere qualcosa per tirarsi su, rifocillarsi. Che non mi stia immaginando una fiction americana, avevo pensato quella volta, non potendo credere, come tuttora, che le cose fossero andate davvero in quel modo”.
Hotel Tito ha il ritmo della fiction, ma deriva la sua origine dalla faction. Scriveva Danilo Kiš: riuscire a dare forma alla fiction permette di non perdere il senno per la faction.