L’uovo al tegamino di Aldo Moro
Nel suo ultimo film – in realtà una serie televisiva in sei puntate – Marco Bellocchio torna sul sequestro Moro che aveva trattato in un precedente lungometraggio, Buongiorno, notte, nel 2003. Ora il nuovo film, Esterno notte s’avvale della straordinaria interpretazione di Fabrizio Gifuni nel ruolo del leader democristiano: un Moro più Moro del Moro vero. Del resto, cos’è un attore se non una maschera? Il potere della “maschera” è proprio quello di svelare ciò che nella realtà non è sempre comprensibile, se non ad occhi acuti e perspicaci. L’interpretazione di Gifuni mette a fuoco quelle che erano le caratteristiche uniche del personaggio Aldo Moro fornendone una sintesi fulminante. La sceneggiatura cerca poi di mettere in rilievo l’aspetto “privato” dello statista entrando nella sua casa, mostrandolo insieme alla sposa e ai tre figli, mettendo al centro di uno degli episodi del film Eleonora Moro, moglie dello statista, interpretata con grande bravura da Margherita Buy.

In una delle scene memorabili della prima parte, Moro torna a casa alla sera. Tutti dormono e dopo aver congedato il suo accompagnatore – il maresciallo Leonardi, sua ombra, ucciso dai brigatisti nel corso del sequestro –, si fa un uovo al tegamino e mangia in silenzio dopo aver apparecchiato in modo sommario la tavola. Questa immagine, cita probabilmente un dettaglio riferito da uno dei suoi segretari, Corrado Guerzoni, e mostra uno degli aspetti salienti della sua figura di politico: la solitudine.
Nel suo intervento sul libro di Sciascia, L’affaire Moro (“L’Ora”, 4 novembre 1978), Italo Calvino parlava della solitudine di chi riveste un ruolo di potere. Non si riferisce esplicitamente a quella del sovrano, protagonista di tanti testi classici a partire da Shakespeare, ma è esattamente il tema stesso di Moro. Lo scrittore ricorda come esista un legame antichissimo che collega la morte con l’esercizio del potere: “Chi sceglie di fare l’uomo politico – scrive – lo sa: gli addii alla famiglia li ha fatti nel momento in cui ha scelto quella carriera”. La scena dell'uovo al tegamino deriva dalla decisione di Bellocchio di iscrivere la vicenda del sequestro nello spazio famigliare del leader democristiano. In questo modo cerca di attenuare lo iato che esiste tra il ruolo pubblico del presidente della Democrazia Cristiana e la sua personalità umana. Il regista ha puntato su questo duplice aspetto, il privato e il pubblico, un pubblico intriso di privato, che è il substrato stesso del libro di Sciascia: da personaggio a uomo solo e infine a creatura. Proprio la recitazione di Gifuni, la maschera indossata anche in famiglia, ci fa capire chi sia stato in realtà questo “sovrano” – la sovranità, stigma della differenza e del lato di distanza sacra permane, anzi si esalta nelle fotografie delle Brigate rosse: è un sovrano destituito.
A un certo punto viene messa in bocca a una delle figlie una battuta quanto mai efficace. Mentre tutti insieme in famiglia guardano la prima delle due foto polaroid delle Brigate rosse pubblicate sui giornali, la figlia dice: la faccia è la sua, quella di uno che non si sa mai cosa pensi. Questo è Moro anche per i suoi famigliari.
Quello di Bellocchio non è solo un bel film, ma un’opera visiva che ci proietta per la durata complessiva di cinque ore in un mondo antico, remoto, che non esiste più. La fisicità di Moro, interpretato da Gifuni, appartiene a un universo arcaico: Moro di Bellocchio è uno degli ultimi dinosauri, uno dei sovrani estinti della Terra. Forse l’unico che ancora coltiva per necessità la solitudine del potere è Vladimir Putin, se non fosse che il suo viso attuale, per quanto invecchiato e gonfio, è pur sempre quello inespressivo di un uomo qualunque. Masha Gessen in un libro del 2001 appena riedito l’ha ben definito nel titolo: L’uomo senza volto (Sellerio), una designazione perfetta. Moro ha un volto, Putin invece no.
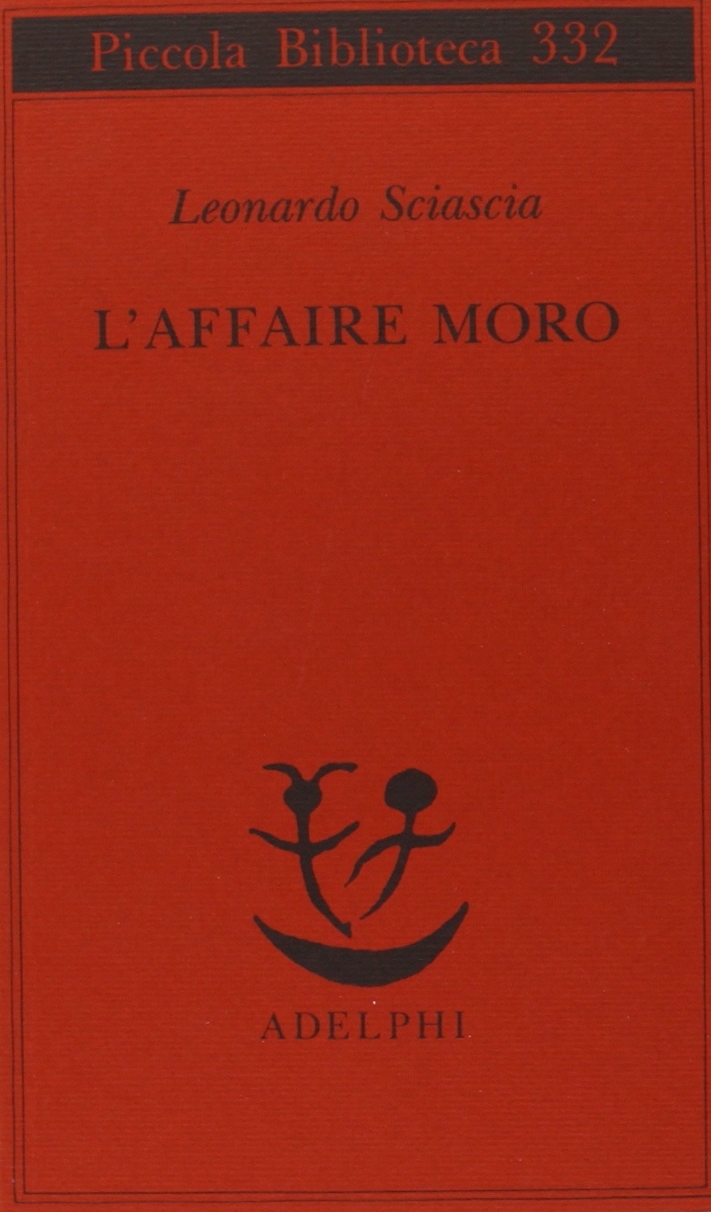
Dopo Moro, dopo i volti funebri dei notabili democristiani con cui si apre e chiude il film – sono quelli funebri, di condannati a morte, come aveva scritto Pasolini in uno degli articoli in cui chiedeva il Processo al potere della Democrazia cristiana –, l’Italia ha cambiato faccia. La prima ad apparire diversa è stata quella rotonda, quasi mascelluta di Bettino Craxi, che abbiamo visto nel film di Gianni Amelio, Hammamet, interpretata anche in questo caso magnificamente da Pierfrancesco Favino; poi quella brianzola e accattivante di Silvio Berlusconi, l’uomo col sorriso in tasca, che ha avuto il suo ritratto in Toni Servillo nel film di Paolo Sorrentino, Loro. Infine la faccia di Matteo Salvini, che ha dominato negli ultimi anni le televisioni e i social con altrettanta dovizia di dettagli, per ora non ha ancora avuto una traduzione cinematografica – mancanza di interesse per questo politico o intuizione della sua transitorietà?
Là dove Moro esibiva un evidente carisma fondato su una misteriosa unione di imperscrutabilità e sovrana calma, Salvini e i suoi predecessori invece manifestano una doppia radice nevrotica e narcisistica. Per dirla con le parole di un acuto psicoanalista, Christopher Bollas, si tratta di figure in cui l’aspetto visivo appare dominante come accade nelle forme narcisistiche: la richiesta d’attenzione. La politica ha sposato in Occidente l’aspetto narcisistico del corpo del capo, quello che Bollas chiama il “patto narcisistico”, che si sintetizza nella formula: “Ti incoraggio a esaltare te stesso, tu fai la stessa cosa con me”. La radice populistica non è soltanto politica ma prima di tutto psichica, come aveva capito Andy Warhol in un suo libretto dedicato all’America, e coinvolge i leader e le masse quali specchi vicendevoli, dove le immagini si moltiplicano all’infinito – in definitiva questa è la cattiva infinità dei social in cui avviene la negazione stessa della mortalità a favore di una infinità dei singoli Io: io io io.

La solitudine di Moro è l’esatto contrario. Non che anche questa non abbia i suoi aspetti negativi. Come ci mostra in questi anni la figura di Putin, esiste anche l’elemento paranoico. Si tratta di una malattia mentale, come scrive Luigi Zoja in un libro importante, Paranoia. La follia che fa storia (Bollati Boringhieri), l’unica contagiosa, caratterizzata da deliri sistematici, di persecuzione e di grandezza, in assenza di altri disturbi della personalità. Zoja sottolinea come la paranoia non si opponga alla ragione, ma finga di collaborare con essa. Non è riconducibile a fattori organici, e chi ne soffre è di fatto un essere fragile che “sposta nel tempo un problema vitale che non riesce ad affrontare”. Il problema principale del paranoico, come dimostra Putin, è il tempo, l’avversario più ostico e coriaceo, su cui non riesce ad avere la meglio e che finisce per consumare in farneticamenti e follie belliche.
Il caso di Salvini è invece quello di un delirio narcisistico spinto sino all’estremo che ha nel visuale l’aspetto dominante. Le felpe indossate negli anni scorsi, messaggi espliciti inviati ai tifosi, o aspiranti tali, nel corso dei comizi – la felpa con la scritta del paese, città o regione in cui si recava – ne sono il simbolo, per quanto oramai logorato e distante nel tempo. Il verbale e il simbolico in Salvini sono due aspetti quasi assenti, tanto è vero che concentrando sulla sua persona, sul suo corpo, il messaggio visivo, slogan compresi, Salvini ha finito per logorare il patrimonio simbolico della Lega di Bossi, riducendo a un pugnetto di cenere la capacità di presa del colore verde, degli slogan e l’apparato di simboli leghisti. Ora Salvini sembra arrivato a fine corsa, mentre sta cominciando l’ascesa della ragazza-acqua-sapone, Giorgia Meloni, il cui aspetto narcisistico appare attenuato, e la cui propaganda somiglia sempre più a quella di uno shampoo o a un prodotto per la cura della pelle, che non a un progetto politico, che pure c’è ma è nascosto dietro alla sua immagine dominante – Patria come parola d’ordine.
Chissà se ci sarà un regista disposto a raccontare il passaggio dal sovrano all’influencer, da Moro (e Berlinguer) a Salvini e Chiara Ferragni. Un film che ci farebbe certamente divertire e pensare, ma anche capire chi eravamo, e soprattutto chi saremo, un film visionario com’è, a suo modo, anche quello di Bellocchio – si pensi alle parti su Cossiga, le più angoscianti dell’intero film, legate al passato e all’incubo familistico che insegue Bellocchio dai tempi di I pugni in tasca. Chi ci proverà? Non è un film facile, ma necessario.







