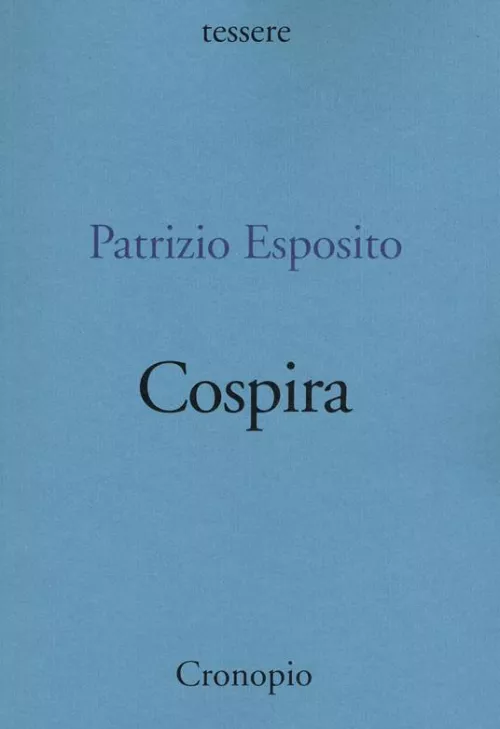Patrizio Esposito, azione e sguardo
«Spostarmi è ciò che ho fatto nella vita», scrive Patrizio Esposito in una parentesi del capitolo Specchio in Cospira (Napoli, Cronopio, 2022, p. 104), il libro in cui ha raccolto appunti di un diario intermittente e perpetuo o quaderno di lavoro – e di frammenti di vita – di molti anni. E certo lo spostarsi qui si può in prima battuta intendere nel senso del viaggiare, quale può praticare un fotografo di lungo corsocome lui: «Cosa ho fotografato? Paesaggi, cioè donne e uomini, animali, piante, oggetti» (ibid.); ma di foto nel libro ce n’è una sola (e sta in coda, con le sobriedediche), e va detto che al lavoro di Esposito si addice una nozione differente e più complessa di quella che rinvia a codici prestabiliti, a generi consolidati o a singoli mestieri.
Lo attestano non solo il suo curriculum di collaboratore di Antonio Neiwiller, Thierry Salmon, Claudio Morganti e i suoi numerosi progetti in giro per il mondo, ma le pagine stesse di Cospira, e fin nel ritmo delle frasi. A imporsi al lettore, per loro tramite, è il senso di un ingaggio che non dà spazio a liturgie “odeporiche”: i luoghi visitati e vissuti designano anzitutto, nel mobile e frastagliato configurarsi, una mappa orientata, carica di risonanze storiche e latrice di un severo (e brechtiano) appello, lo stesso iscritto nei volti incontrati lungo il percorso. La Palestina e Chatila, Beirut, Slovenia e Carinzia, Cina, Sahara Occidentale e Mato Grosso non sono scenari da descrivere, bensì segnavia la cui direzione comporta uno sguardo di parte, uno scarto fondante, l’assunzione di un punto di vista non conforme alle coordinate del discorso corrente, globalizzato fin nel lessico e nella sintassi.
Lo spazio elettivo di questi appunti, semmai, è il vuoto della cartina in cui si muovono i Sahrawi, o la città delle ombre di Chatila: una geografia della rimozione, a cui appartengono altresì le «cittadelle punitive» delle istituzioni che ospitano e annullanoi devianti dalla norma, ovvero esemplarmente, nel caso, gli ospedali psichiatrici di Napoli e di Volterra – tra i nomi ricorrenti, sui versanti coloniale e sociale, ci sono quelli di Franz Fanon e di Franco Basaglia –, tema ed oggetto di ricognizioni fra le più intense del libro.

È in questi luoghi che il lavoro di Esposito si fa insieme azione e sguardo e lo spostamento diviene disallineamento, una forma di straniamento in cui affiora il silenzioso mandato di una committenza relegata nel non-essere, per la precisione quella che «questa idiota parte di mondo» (p. 181) non vuol vedere, e che pure abita il nostro tempo. C’è una bellissima poesia “militare” (1908) di Umberto Saba che finisce con questi versi: «… Il volo che nel grano entra e poi scatta, / la pecora ricorda che i ginocchi / piega, indi pare che tutta s’abbatta. / E vedono il terreno oggi i miei occhi / come artista non mai, credo, lo scorse. / Così le bestie lo vedono forse.»
Lo sguardo del soldato nell’appiattirsi a terra è una forma di appostamento che consente una rivelazione, e la rivelazione è data nello sguardo dell’animale, letteralmente umile e veggente. È in fondo anche la posizione da cui Esposito interroga il mondo, dal suolo (quella dall’alto è «vicina alle ragioni di chi sorveglia il cielo per possedere l’astro», p. 47), tesa a cogliere «quanto è trascurato o velato dai vocabolari egemoni» (p. 11). Si leggano dei passaggi emblematici:
Fisso gli animali da quando bambino avevo sul balcone una capra, poi galline, cani, una pecora. […] Sogno più animali che uomini, non so a cosa conduca. (Sorgente. Studenca, p. 52)
Nel nascondere (pp. 180-181)
Portare specchi, schegge, lasciarli nei sottoscala, nei punti in cui la luce prima o poi arriva, nei punti dove all’improvviso si specchia e si irradia, si dibatte infiammando lo scuro. Lì i gatti osservano: impauriti, curiosi, combattivi, lì i gatti tornano, sì, tornano a vedere il bagliore a distanza nell’ora in cui si ripete il prodigio, la coda e la schiena inarcate, la pupilla perpendicolare, la membrana nittante di una terza palpebra, la seconda retina […]
O ancora, ecco il ricordo di Fabrizia Ramondino, che
al ritorno da una visita ai campi profughi sahrawi, nel 1997, raccontava che la vicinanza tra uomini e animali appena vissuta nel deserto, le sembrava parte di un’utopia da noi perduta, quella di un mondo non separato (p. 51)
Da qui – da questo fondamento spiazzante, da un dislivello d’origine – proviene anche, sul piano narrativo, la dominante del discontinuo e la coerenza dell’incompiuto, che paradossalmente costituiscono la forma itinerante del libro, disancorata da una cronologia lineare e consegnata ai frammenti. Anzi, è proprio contro la linearità del tempo «omogeneo e vuoto» di cui parla Benjamin nelle Tesi di filosofia della storia che muove Cospira nel suo moto interno di protesta: non per caso a un certo punto è citato il passo delle Tesi che rammenta gli spari agli orologi di Parigi durante la Rivoluzione di Luglio.
L’interruzione, come lo spostamento e l’«interferenza» (altra parola-chiave in Cospira), è una forma di sabotaggio che corrisponde all’insofferenza immedicabiledel testo nei confronti della violenza esercitata dal dominio, dalla forza corrotta e proterva delle complicità e delle connivenze, dal ricatto dell’apparenza (cioè dell’ideologia). Non è da stupirsi, allora, se l’autore riprende l’affermazione di Heiner Müller «Scrivo, se non potessi scrivere appiccherei il fuoco» (p. 61). Una opzione incendiaria e a favore del disordine innerva la scrittura e serba il ricordo dell’utopia.«È portando disordine, tramortendo, mentre ti leva sonno e parola, che il teatro funziona»: così a proposito di Thierry Salmon (p. 121). E dunque il viaggio è «Uno spavento. Una sosta» (p. 105). Il tempo, in quella pausa sospesa, si fa «pura negligenza» (ibid.).

Sopralluoghi, ricognizioni, azioni del tutto spoglie di retorica – è un lavoro «appartato» quello di Esposito, «fatto di metodi e di risultati che non hanno né corpo né scopo» – compongono il mosaico di Cospira. Ritorni: a casa di Pinelli, a parlare con Licia:
Parliamo di relazioni, di visioni e di cose sognate, di come siamo stati o siamo, di come va zoppicando il mondo. Nessuna nostalgia, nessuna tristezza ci prende mai. Neppure quando compaiono le ferite.» (p. 20)
Nella casa di Badolato, in rovina, di Antonio Neiwiller, venticinque anni dopo la sua morte:
Non so qual è stato il destino dell’abitazione chiamata il “Tempio”, ma negli ambienti presi dall’umidità, nel solaio crollato e nel tetto pericolante della casa comprata e vissuta brevemente, le sue tracce sono più evidenti che mai. Un cassettone ha ceduto per le infiltrazioni piovane, un piede di legno è marcito e i cassetti sono caduti in avanti insieme al loro contenuto: coperte e stoffe piegate con cura sono avvolte dalla muffa, diventano dipinti, fondali da teatro, cortecce. Materia viva, in movimento. Erano fibre venute dall’erba, tornano erba. Il mutamento desiderato da sempre, ostinatamente, da solo e con altri, in ogni angolo della vita, serpeggia nei teli. Pennelli, barattoli, carte, galleggiano in una bacinella colma d’acqua, su un copriletto ora asciutto, vicino all’ingresso, il quadrato rosso della copertina di Asylums, di Erving Goffman, si curva su sé stesso, si inarca come legna sul fuoco. Una lampada sprofonda tra altre stoffe umide come in una minuscola palude domestica. Su uno dei grandi cartoni disegnati prima della morte, trovati quel pomeriggio, è scritto: «Lasciare sempre gli spazi vuoti, conservare sempre il soffio».(pp. 61-62)
In chiave con questi appunti e con il «teatro clandestino» di Neiwiller lo spazio di Cospira si apre alla metamorfosi ed all’attesa, ad una significazione ulteriore e ad una trasmissione singolare, come per un affidamento. Sulla soglia di un vero, penetriamo con l’autore nelle case abbandonate, quelle in cui si entra «dai tetti, sempre», come a Podpeč, in Slovenia, che «hanno un tempo lungo per mostrarsi agli estranei. Un tempo rallentato e diseguale. Uno per ogni visitatore.» (p. 47). Dimore consegnate alla rovina perché «molto è accaduto» (p. 46):
Una da poco: conserva il tetto, ha infissi integri, la porta è chiusa. Gli scuri aperti di una finestra della cucina permettono di osservare l’interno ordinato: ogni cosa sembra salutata all’improvviso e solo di recente. Il tavolo centrale, coperto da un’incerata a piccoli fiori gialli, tagliata con forbici seghettate da sarto, è stretto tra panche di legno. […] La credenza, in buono stato, ha le mensole colme di piatti, scodelle, tazze da caffè. Sul lato interno dei vetri, ad evitare la polvere, sono sistemate undici fotografie di diverso formato. Sono ritratti di singoli e di coppie, fotografie della comunione di due bambini, la fotografia di un matrimonio, la fotografia di un viaggio di nozze. Chi è andato via ha deposto la propria immagine.
Molto è accaduto e continuerà ad accadere, se non impareremo uno sguardo nuovosul mondo, attenti allo “scorgere” più che al “vedere”. Nel farlo, se un metodo c’è, è intermittente, quindi non confidabile: compare per dileguarsi. Con i suoi titoli scarni e in apparenza minimalisti (Focàia, Prossimo, Piccolo combattimento, Sghemba, Assistere, Nel nascondere…), a cui fanno da sponda le citazioni disseminate nel corpo del testo (da Char, Fortini, Badiou, Wittgenstein, Nancy, Ranchetti) il libro di Esposito punta proprio per questo a comporre un lessico per un uso diverso del presente e del passato. Lo scorgere impenitente che è all’origine di questo librosarebbe piaciuto a John Berger, che in Sul guardare (a cura di Maria Nadotti, Il Saggiatore, 2003, p. 64) annotava: «Il compito di una pratica fotografica alternativa è di incorporare la fotografia nella memoria sociale e politica, invece di usarla come un sostituto che ne incoraggia l’atrofia». Nell’universo saturo di immagini che ci paralizza e nel rumore infinito che ci assorda «Non si tratta di cospirare in silenzio, ma di cospirare il silenzio» (Cospira, p. 31).