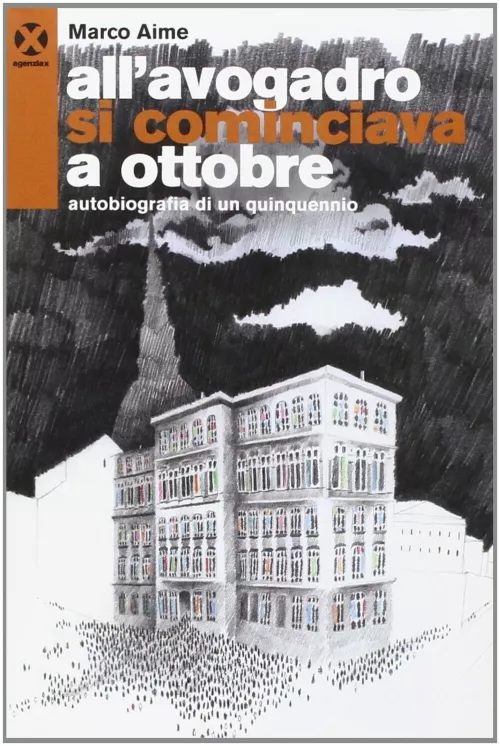Aime. All'Avogadro si cominciava a ottobre
La scuola è sempre luogo di formazione e di scoperta, un punto di intersezione tra cultura alta e bassa e un laboratorio continuo di avvicinamento alla realtà sociale e politica: ed è per questo un luogo mitico a cui è riservato uno spazio speciale nella memoria.
Marco Aime, antropologo e saggista, dà corpo a questa idea raccontando la sua esperienza di studente nel periodo 1970-1975 in All'Avogadro si cominciava a ottobre, nel quale lascia (apparentemente) da parte i ferri del mestiere e recupera pezzi di una dimensione affettiva.
È una pagina di storia della scuola, e della società che in essa si rispecchia, vista da uno studente in età di formazione, che per Andrea Bajani, nell’introduzione, racconta «un'Italia di quarant'anni fa che (…) sembra la promessa tradita di un mondo che non c'è stato».
Senza nostalgia, racconta soprattutto Torino. Una Torino molto «torinese» che gli studenti attuali di Aime, divenuto un professore universitario, fanno fatica a immaginare: «grigia, sobria, austera, non troppo brillante, quadrata come i suoi viali sabaudi, operosa e operaia. Una grande fabbrica con delle case intorno», ancora la motor city italiana: la cornice del potere in cui si inscrive la quasi totalità della vita sociale è la Fiat, che vuol dire anche «La stampa» (la busiarda) e Juventus (venerata o odiata), rispetto alla quale al limite si esprime dissenso. La città di Giuanin Lamiera, l'Avvocato Agnelli, e dei barachin, gli operai, in cui si mangia pranzo a mezzogiorno e cena alle sette e «trovare un bar aperto alle dieci di sera era impresa ardua».
Qui, a partire dallo sviluppo economico si inseriscono la vita della provincia, la cintura torinese da cui viene lo stesso autore, e la migrazione dei napuli, come per estensione i piemontesi chiamavano tutti quelli nati sotto la Toscana. E che per gli anziani continuano a essere tali ancora oggi, anche se sono amici e alla fine “proprio come noi”.
Di questa dimensione, in cui sud e nord si incontrano sotto forma salsicce piccanti e barbera, i giovani torinesi sono l'avanguardia della trasformazione. Aime racconta dell'Istituto tecnico Avogadro, una versione in piccolo del Politecnico, in cui le aziende (l'azienda) reclutano direttamente giovani specializzati. In classi da «trentacinque [...], figli del baby boom», si vivono gli anni plurali (uno dei titoli possibili per il libro) a indicare un tema caro all'autore-antropologo: lo spirito di una esperienza collettiva in anni di forte conflitto sociale e mobilitazioni studentesche in cui convivono agitazione politica, ribellismo giovanile e impegno di studio: «all'avo si inizia a ottobre […] ma le lezioni vere e proprie, quelle regolari, cominciavano a gennaio» e poi, fatalmente, noti i programmi da studiare, le cose le si dovevano sapere. Il libro, organizzato in capitoli tematici, è inoltre sostanziato da una scrittura collettiva anche grazie al felice uso delle mail scambiate tra ex-compagni di classe che sono state incorporate nel testo.

Il tratto politico è duplice: da un lato un'appartenenza istintiva a sinistra per provenienza e orgoglio di classe, proletaria o piccolo borghese, insieme alla simpatia per l'uguaglianza e alla tensione per il riscatto sociale; dall'altra, al netto di qualsiasi retorica sull'autenticità e sul radicalismo di ieri, una dimensione in cui individualismo, edonismo e narcisismo degli anni Ottanta stentano ancora a comparire nell'orizzonte cognitivo. «Le parti erano chiare, i ruoli definiti. Non potevi far finta di niente e non volevi fare finta di niente. Non si aveva paura di essere classificati, essere identificato era proprio quello che volevi.»
Il look «non era stato ancora inventato ma c'era»: e i ragazzi del tecnico con il tascapane e l'eskimo di ordinanza si contrappongono idealmente ai “cremini” (i fighetti cittadini che si trovavano in cremeria) radicati nei licei bene del centro, appannaggio delle borghesie sabauda, come è stato anche raccontato da altri scrittori torinesi come Giuseppe Culicchia e Maurizio Ferrarotti.
Comprensibilmente per una scuola tecnica, compare una dimensione di genere («tremila maschi»!), in cui le logiche da spogliatoio sfumano nella ricerca del femminile, siano le ragazze dei licei limitrofi o le giovani professoresse; ma un ruolo decisivo è quello che spetta alla musica, mondo estetico che si fa attitudine. In questo senso emergono gli interventi di microstoria degli oggetti come i passi sul vinile, portato in giro con il lato copertina «sempre in vista», condiviso e passato di mano in mano e suonato di impianto in impianto (Dylan, Rolling Stones, Led Zeppelin, Who, Pink Floyd, King Crimson, Jethro Tull, Hendrix, Genesis, Guccini, De André, Battisti, Cohen, Gaber); o come l’elogio delle C-90, le audiocassette (ma lo devo davvero spiegare?) che hanno democratizzato la musica prima di ogni altra cosa.
Nel libro vengono riportati all'attenzione i luoghi tipici dell'adolescenza (torinese): bar, con biliardi, ping pong, calciobalilla, juke box; cinema aperti al mattino, in cui si vedono documentari rock soprattutto. E poi ci sono le birrerie, esperienze “europee” di pionierismo di socialità metropolitana che sostituiscono le osterie, nelle quali si va in gruppo e dalle quali si esce odorosi di fumo e patate fritte.
Il libro è materiato di cose intime e quotidiane, veri e propri documenti di vita comune, prototipi nei quali ognuno potrà riconosce i propri, siano le liste di cose da portare in viaggi immaginari e reali (Parigi!) o le narrazioni conservate in diverse versioni di episodi, epici per chi li ha vissuti ancora prima che il tempo le consacrasse.
Su tutto, quasi un topos dell'incoscienza e della vita eccedente la sua programmazione, arriva in chiusura il racconto di un'ascesa al Rocciamelone, una vera montagna della Val Susa, per vedere un ghiacciaio, due giorni prima dell'esame di maturità. Il rito di passaggio con cui – mi piace pensare – l'antropologo riconosce la parte di sé rimasta indietro, nell'altrove del passato, per diventare altro.