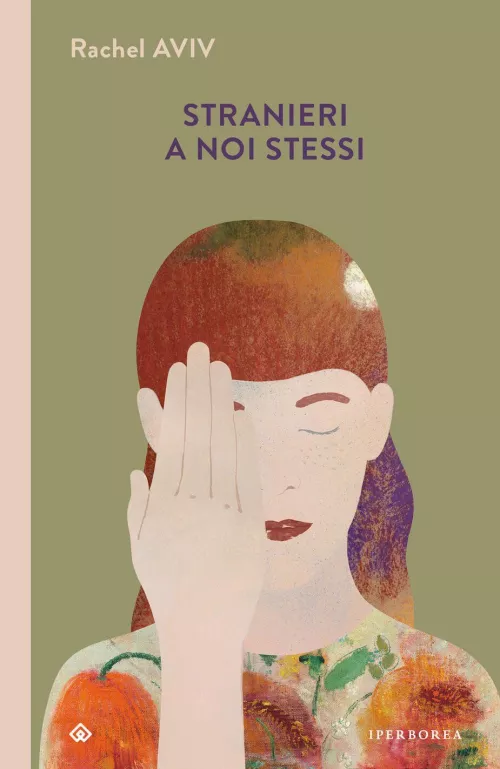La cura parlata
Nella mitologia nordica si narra che ogni mattina il dio Odino inviasse nel mondo due corvi, Hughinn (pensiero) e Muninn (memoria). I due uccelli, tornando a casa al calar del sole, avevano il compito di raccontare al loro padrone ciò che avevano visto e ascoltato al di fuori della loro terra. È da questa leggenda che la recente collana della casa editrice Iperborea “I Corvi” trae la sua ispirazione: uscire dai confini abituali del Nord Europa – terra d'elezione del progetto editoriale della casa editrice – per raccontare storie che giungono da altre parti del mondo. Si tratta di una collana che raccoglie saggi narrativi caratterizzati da uno stile che mescola il giornalismo di inchiesta alla narrazione letteraria. Il saggio Stranieri a noi stessi (2024) di Rachel Aviv trova in questa collana la sua perfetta collocazione. L'autrice è una giornalista statunitense che lavora per The New Yorker dove si occupa di diverse tematiche tra cui la psichiatria, l'etica medica, la giustizia penale e l'istruzione. Alcuni di questi interessi traspaiono nel saggio Stranieri a noi stessi nel quale l'autrice si occupa di indagare il mondo della sofferenza psichica e del suo trattamento. L'ipotesi che guida il lavoro di costruzione e di ricerca di Aviv è che le storie, nel bene e nel male, hanno il potere di cambiare le nostre identità e le nostre vite. Un'ipotesi che, a prima vista, può sembrare semplicistica ma che, in realtà, rivela un'intuizione più profonda e cioè che il “fatto determinante” (espressione utilizzata da Hava, un personaggio del libro) della vita di una persona ha a che fare con l'incontro traumatico con quella che chiamerei l'intraducibilità del proprio essere.
Il saggio si apre con un ricordo infantile dell'autrice. Quando viene ricoverata nell'ospedale di Detroit con la diagnosi di anoressia, infatti, Rachel ha solo sei anni. Si dice, le si dice, che è la più giovane paziente mai ricoverata con quella diagnosi. L'ospedalizzazione dura qualche settimana, trascorse le quali, la bambina ricomincia a mangiare con gusto e regolarità. Il rientro a scuola e alla vita quotidiana avviene con una certa semplicità. Tuttavia il ricordo di quel periodo non smette di interrogarla. Che cosa era accaduto allora? Che cosa le era accaduto?
Queste domande si configurano come un resto non integrabile, eccedente, rispetto allo scorrere della sua vita. Un qualcosa di cui, anche a distanza di molti anni, non sa dire bene l'essenza. Forse è proprio la natura misteriosa di questo resto a far sì che tale eccesso prenda la forma del lavoro che ci troviamo tra le mani: “La malattia, scrive Aviv, non divenne mai una «carriera» per me. Non mi fornì il linguaggio con cui imparai a capire me stessa” (p. 29).
Oltre alla sua, nel saggio l'autrice racconta altre cinque storie di vite affette da una sofferenza psichica; sono “vite [che] si dipanano in tempi e culture diverse, ma condividono uno scenario: le periferie della psiche, le fasce esterne dell'esperienza umana, dove il linguaggio tende a fallire” (p. 33). Sono storie differenti tra loro per quel che concerne i dati biografici, le diagnosi e gli ambienti di appartenenza ma legate dal comune sforzo dei protagonisti di interrogare lo squarcio tra soggetto sofferente e mondo. E il mondo di cui ci parla Aviv è un mondo fatto di linguaggio. Proprio per questo, la sofferenza di cui ci parla è legata all'esperienza che un soggetto fa dell'intraducibilità del proprio essere.
Una delle vite raccontate nel libro, ad esempio, è quella di Rapahel “Ray” Osheroff. Ray è un medico di successo di una quarantina d'anni quando viene ricoverato per la prima volta presso il Chestnut Lodge nel Maryland. Soffre di “una forma di melanconia, non di lutto” scrive lo psichiatra che lo ha in cura, alludendo alla differenza fatta da Freud in Lutto e melanconia. Si tratta, infatti, di una clinica a stampo psicoanalitico quella cui si rivolge Ray; una clinica insolita – soprattutto nel territorio statunitense – dove ai farmaci viene preferita la talking cure.
Nel 1982, diversi anni dopo la sua degenza, Ray denuncia il Lodge perché non era stato in grado di guarirlo. L'udienza preliminare vede affrontarsi due visioni antitetiche della sofferenza mentale. Le accuse di Ray si trasformano così in un caso mediatico che contribuiscono in maniera decisa alle sorti dell'avvenire della cura del disagio psichico in terra statunitense. A seguito di un incontro d'amore, nel frattempo, Ray decide di patteggiare e non andare a processo. Tuttavia gli psichiatri continuano a riferirsi all'evento come alla resa dei conti finale della psicoanalisi.
A poco a poco Ray viene così fatto fuori dal suo stesso discorso, non c'è più, e nessuno se ne accorge.
Due sono gli esiti principali di questo scontro: uno per il mondo e uno per Ray. Per ciò che riguarda il mondo, “le eleganti narrazioni dei conflitti dei pazienti furono rimpiazzate da elenchi di sintomi […] la cura della salute mentale iniziò a essere trattata come un bene qualunque, invece che come una collaborazione […] gli psichiatri divennero «fornitori» e i pazienti «consumatori» la cui sofferenza veniva sintetizzata tramite le diagnosi sul DSM” (p. 67). Come scrive l'antropologo Alistair Donald nel saggio The Wal-Marting of American Psychiatry, “il vero paziente è sostituito da descrizioni comportamentali e così è diventato inconoscibile”. Per ciò che riguarda Ray, invece, è lasciato alla sua solitudine, fuori discorso, nell'impossibilità di trovare un posto nel mondo e nella incapacità del mondo di fargli un posto: “Ma Ray intuiva anche che qualsiasi storia capace di risolvere i suoi problemi in maniera troppo completa non era vera, era un'evasione dall'ignoto. «Sul finire della vita, dopo aver perso tutto, forse sono solo una crepitante foglia autunnale che vola via nel vento crudele di ottobre»” (p. 75).
Così ognuna delle vite che compare nel saggio di Aviv ci racconta la frattura insanabile tra mondo e soggetto insieme al tentativo di ricucirne i pezzi. Ammirevole la ricostruzione paziente fatta dall'autrice che unisce gli scritti personali dei protagonisti a conversazioni avute coi familiari, partner e medici curanti, e che intesse questo materiale alla cultura (psichiatrica, umanistica, scientifica e religiosa) di riferimento. Diversamente da una più frequente e diffusa tendenza alla ricerca di spiegazioni e di certezze, il saggio “parla di storie mancanti, di sfaccettature dell'identità che le nostre teorie sulla mente non riescono a catturare” (p. 34).

Come accennavamo poc'anzi, tutta la lavorazione avviene sullo sfondo di una ricerca che si rivela molto più intima e personale. Il primo e l'ultimo capitolo offrono al lettore un taglio attraverso cui leggere le storie che Aviv presenta. Se è vero, infatti, che tutto il libro – come ci suggerisce la quarta di copertina – è “un'esplorazione del rapporto fra diagnosi e identità”, quando la giornalista scrive il suo racconto, si spinge un passo oltre. Ci porta un passo oltre. Ci offre, dicevamo, uno sguardo attraverso cui leggere quelle storie.
Quando, infatti, Aviv raccoglie e ricuce gli stralci delle cartelle cliniche del suo ricovero e le ricerche sull'anoressia con i ricordi dei suoi genitori e dei medici e con i suoi, quello che il lettore estrae dalle sue parole è uno sguardo. Così ci sentiamo colpiti dall'insignificanza del discorso che cerca di significare il rifiuto del cibo da parte di quella bambina. Ci procura una sensazione di straniamento che ci accompagna durante tutta la lettura del testo. Tutte queste voci – quelle dei genitori, dei medici, degli esperti, degli studi – coprono il silenzio infantile. Solo tra le righe compare il corpo di una bambina che vede e ascolta, rifiuta o acconsente; affascinata dalle ragazzine più grandi ed estranea alle parole degli adulti.
All'interno del racconto, allora, sembra quasi possibile distinguere le parole che la circondano da quelle propriamente sue. Di quel periodo, scrive Rachel, non ricorda il ragionamento che sottostava al suo rifiuto del cibo ma ha ben in mente le reazioni che esso provocava negli adulti intorno a lei. Ciò che ricorda, invece, è il ghigno di piacere apparso sul suo volto quando per la prima volta risponde negativamente all'offerta di cibo da parte dell'insegnante oltre al suo tentativo di nascondere quel piacere indicibile e sconosciuto che appariva nel suo corpo. Un piacere di cui non si sa e non si può dire niente.
Così, immersa nel linguaggio che cerca di dare ragione di ciò che le accade, la bambina sceglie e afferra solo alcune delle parole che la circondano. Parole scelte, parole prese e apprese, che le permettono di costruire una domanda rispetto al suo incontro con un inspiegabile accadimento del corpo. Ecco, dunque, che quel punto di intraducibilità dell'essere che l'esperienza del corpo rivela si manifesta nella sua possibilità creativa; la possibilità cioè di fare in modo che una domanda venga formulata e costituisca la base per un'esistenza psichica.
Mi torna alla mente un meraviglioso albo illustrato pubblicato un paio di anni fa dalla casa editrice Orecchio Acerbo. Sto parlando di L'estate dei tuffi di Sara Stridberg (con le illustrazioni di Sara Lundberg); un lavoro che mi sento di affiancare a quello di Aviv. Similmente a ciò che accade in Stranieri a noi stessi, anche nell'albo è raccontata l'esperienza di un incontro precoce coi luoghi di cura del disagio psichico e, anche in questo caso, il racconto trae ispirazione da un ricordo infantile dell'autrice. Qui è il padre di Zoe, la bambina protagonista, a essere ricoverato nel reparto di psichiatria a causa di una depressione. È difficile dire cosa sia accaduto al giovane uomo. La madre di Zoe così come i medici cercano di spiegare alla bambina cosa stia accadendo al padre ma non riescono a placare le sue domande. Tanto Zoe quanto Rachel sono circondate da adulti che, per dirla alla Winnicott, potremmo definire “sufficientemente buoni”; sono adulti incerti e disponibili, sofferenti e presenti. Questa sufficienza – e dunque una mancata pienezza – sembra essere ciò che permette alle bambine di muoversi e di cercare altrove delle parole che possano fare al caso loro. Accade così che in questa ricerca avvengano degli incontri inaspettati. Durante la sua ospedalizzazione Rachel fa la conoscenza di due ragazzine più grandi, Carrie e Hava, verso le quali prova una profonda fascinazione. È a loro che insistentemente pone la domanda, pensi che io sia strana?
In modo analogo, Zoe si interroga sul malessere del padre: “Come si fa a non aver voglia di vivere quando esistono i cani e le farfalle e il cielo? Come si fa a non aver voglia di vivere quando esisto io? […] Come si fa a non ricordarsi com'è stare bene? Come si fa a non ricordarsi di me? […]”. Fino a domandare a Sabina, una paziente dell'ospedale psichiatrico con la quale ha instaurato un'amicizia, credi che il mio papà tornerà presto?
Ecco, allora, che qualcosa accade. Carrie sbuffa e, voltandosi verso Rachel, le risponde bruscamente: chiedimelo un'altra volta e ti risponderò di sì! Sabina, invece, alza le spalle e allegramente si rivolge a Zoe dicendole: e io come faccio a saperlo? Non sono mica un'indovina!
Sono risposte che hanno il potere di funzionare come segno di interpunzione; sono parole che mettono un punto all'angoscia delle bambine pur senza rassicurarle.
“La responsabilità della crescita del bambino è in un certo senso contraria al mondo – scriveva la Arendt in La crisi dell'istruzione – il bambino deve essere protetto con cure speciali, perché non lo tocchi nessuna delle facoltà distruttive del mondo. Ma anche il mondo deve essere protetto per non essere devastato e distrutto dall'ondata di novità che esplode con ogni nuova generazione”.
Quelli con Carrie e con Sabina sono incontri che permettono di tutelare il nuovo che è racchiuso in ogni bambino. Tutelare il nuovo, allora, rimanda al compito dell'adulto di mantenere in vita le domande infantili facendo in modo che esse possano sopravvivere alla crescita del bambino e diventare così motore di creatività e di lavoro nella vita adulta.
Forse è questa l'impressione principale che la lettura di Stranieri a noi stessi ci lascia: non c'è sollievo né risoluzione al problema dell'intraducibilità dell'essere ma c'è la possibilità di fare spazio a questo nuovo racchiuso in ogni essere parlante. Ed è questo il dono che Rachel Aviv fa ai protagonisti delle sue storie. Una scrittura animata dall'incontro con un posto vuoto, svuotato cioè da un sapere convenzionale. In un'epoca di fervore diagnostico, questo è un radicale atto di amore per la lingua e per l'umano.
Forse è segno del debito contratto con quel posto vuoto incontrato nell'infanzia; un vuoto di significato ma non di corpo. In fondo, sia per Rachel che per Zoe, è l'incontro con una voce che non dice loro chi sono ma che incoraggia a fare di quella loro domanda di sapere sul mistero insondabile dello stare al mondo, un tesoro da esplorare nel corso della vita.
Stranieri a noi stessi ci fa (ri)scoprire l'infanzia come esperienza di corpo e di linguaggio e ci suggerisce che “si può imparare molto da come uno vive la sofferenza”. In un'epoca di spiegazioni prolisse e di grandi proclami, l'accuratezza nella scelta delle parole, la dedizione alla ricerca e la misura delle affermazioni con cui Aviv si avvicina a tutto questo sono sicuramente degne di nota.