Lessico Foucault. Eterotopie
Alcuni pensieri formulati da Michel Foucault rappresentano una chiave ancora preziosa per comprendere da un lato la percezione sociale dell’alterità, dall’altro le dinamiche delle pratiche di esclusione e di detenzione con le quali oggi quell’alterità viene affrontata. Queste per esempio, tratte dalla conferenza radiofonica del 1966 Eterotopie, ho avuto modo di riportarle di recente nel salutare il Parlamento al termine del mandato quale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale:
«[…] Ci sono le regioni di passaggio, le strade, i treni, le metropolitane; ci sono le regioni aperte della zona transitoria, i caffè, i cinema, le spiagge, gli alberghi, e poi ci sono le regioni chiuse del riposo e della casa. Ora fra tutti questi luoghi che si distinguono gli uni dagli altri, ce ne sono alcuni che sono in qualche modo assolutamente differenti; luoghi che si oppongono a tutti gli altri e sono destinati a cancellarli, a compensarli, a neutralizzarli o a purificarli. Si tratta in qualche modo di contro-spazi. […] Si potrebbero forse classificare le società secondo le eterotopie che preferiscono, secondo le eterotopie che creano. Le società cosiddette primitive, per esempio, hanno, come anche noi d'altronde, dei luoghi privilegiati, sacri o interdetti, ma questi luoghi privilegiati o sacri sono in generale riservati agli individui in crisi biologica. […]
Queste eterotopie biologiche, queste eterotopie di crisi stanno scomparendo sempre di più, e sono sostituite da eterotopie di deviazione; i luoghi, cioè, che la società organizza ai suoi margini, nelle spiagge vuote che la circondano, sono riservati piuttosto agli individui il cui comportamento è deviante rispetto alla media o alla norma richiesta. Di qui le case di cura, di qui le cliniche psichiatriche, di qui inoltre, certamente, le prigioni. Bisognerebbe forse aggiungere anche gli ospizi per anziani, perché, in fin dei conti, in una società così affaccendata come la nostra, l’ozio è una specie di deviazione […]».
Le eterotopie di distinzione e di deviazione, dunque, hanno caratteristiche mutevoli nel tempo, perché è l’esclusione stessa a mutare nella motivazione e nel contenuto, riflettendosi nell’evoluzione dei sistemi in cui si realizza. La sua forma archetipica è naturalmente quella del muro. Ma anche le mura di una città, di una fortezza o di una prigione non sono rimaste sempre uguali a sé stesse e hanno subito, anzi, significative trasformazioni.
Le antiche mura
Più volte mi è capitato di riflettere su quale pregio artistico costituisca per il panorama europeo, pur devastato nei secoli da molte guerre, l’avere città ancora circondate dalla cinta muraria di epoca antica. Alcune, come Roma, conservano mura dell’età classica dei primi secoli dopo Cristo, altre sono di epoca più tarda, ma lo schema che consiste non solo nell’erigere una difesa contro le mire espansionistiche di nemici, ma anche nel cingere l’interno rispetto a un esterno visto come “altrove”, non cambia. Poiché la funzione non varia e unico è il significato attribuito alla cinta muraria, i suoi i caratteri stilistici si somigliano ovunque. Nei secoli, però, questo significato è mutato e ciò che implicitamente confermava l’esterno come nemico si è aperto a esso, anzi lo richiama, ormai amico, come visitatore e consumatore. Quando non sono state abbattute per dare spazio alla viabilità, le mura si sono allora trasformate in oggetti estetici e persino in scenari per eventi artistici, come quello puramente onirico di Christo Yavachev che nel 1974 imballò, avvolse con teli 250 metri delle mura aureliane di Roma.
Il muro come separatore e come distinzione di luoghi “altri”, tuttavia, non è sparito dal nostro sguardo e neppure dal nostro panorama relazionale. Basterebbe ricordare la vicenda del muro di Berlino, segno di separazione invalicabile, ma anche di speranza al momento della sua caduta. Quel muro scavalcato, perforato, abbattuto e lo smantellamento di quella sua implicita estensione nel filo spinato che separava l’Europa occidentale da quella centro-orientale, hanno alimentato per un breve tempo il sogno di un’Europa diversa, coesa nel riconoscersi arcipelago di culture e non insieme di isole separate incapaci di riconoscersi l’una con l’altra.
Tutto ciò, però, non è avvenuto. Al contrario, l’Europa di oggi è circondata da muri, taluni materiali, fatti di mattoni e filo spinato, altri costruiti con il piantonamento delle onde del mare eseguito da staffette respingenti e altri ancora da muri immateriali di leggi frettolose che negano l’arrivo a chi tali sbarramenti tenta di sfidare o direttamente respingono.
Le nuove mura
La chiusura arroccata e timorosa del panorama europeo attuale non si caratterizza tuttavia soltanto per la presenza di nuove mura ai suoi confini. Anche al suo interno ci sono barriere materiali e immateriali che separano, frazionano, rendono difficile l’unitarietà: sono i luoghi della privazione della libertà, che ripropongono ancora muri, separazioni, tentativi di non vedere, al di là della caratterizzazione tipologica delle persone che ospitano, trattengono, detengono e, quindi, della motivazione del loro essere ivi ristretti.
La globalizzazione e la connessa mobilità di massa hanno avuto un impatto profondo anche sulla giustizia penale e sul suo esercizio: dalla previsione in molte giurisdizioni di nuovi reati connessi con l’immigrazione e la sua irregolarità, all’utilizzo della privazione della libertà come forma di controllo all’accesso ai luoghi e ai territori, fino alla progressiva esposizione delle persone presenti e non effettivamente inserite al rischio della commissione di reati e, conseguentemente, alla loro espulsione. È così progressivamente mutato il significato stesso della privazione della libertà, finalizzandola a un esito espulsivo e non a un difficile e a volte forse ambiguo percorso di reintegrazione ‘corretta’ nel contesto sociale. Di fatto configurandola invece come quota in più di sofferenza da applicare a vite già sofferenti, poste al di là di muri spesso più invalicabili di quelli fisici.
Il nemico che questi nuovi muri interni alle nazioni vogliono inibire non è quello che armato tentava l’assalto delle mura della città, bensì quello disarmato che pone noi stessi in conflitto con le nostre paure. Con quel processo che converte le insicurezze sociali e le difficoltà individuali che esse determinano in individuazione di possibili soggettività ostili, così costruendo prima un muro mentale rispetto agli interrogativi che le loro vite pongono, poi un muro materiale rispetto al fastidio che la loro visione determina.
I Centri per migranti irregolari sul territorio nazionale, dove si attua la detenzione amministrativa, e le carceri dove invece si concretizza la detenzione penale, spesso esito di altre precedenti segregazioni, sono eterotopie circondate da una triplice cinta di mura. La prima, spesso a sua volta multipla, è quella che separa la struttura edilizia dal resto della collettività. La seconda è quella della distanza che separa le strutture di più recente costruzione dai luoghi del normale abitare e le colloca nel non visibile e nel non visto. La terza è quella mentale della società che stenta a riconoscere la comune appartenenza al proprio corpo sociale delle persone che in tali luoghi sono ristrette.
L’inversione della funzione tra mura esterne e mura interne è indicativa di un processo di incapacità di integrazione reso visibile in modo quasi plastico da questi Centri: dapprima il muro esterno del confine europeo o nazionale, che svolge l’antico ruolo oppositivo all’ingresso; poi, se si è dentro, il muro del luogo dove si è ristretti che esercita la funzione opposta, non permettendo a chi è dentro quel confinamento di uscirne.
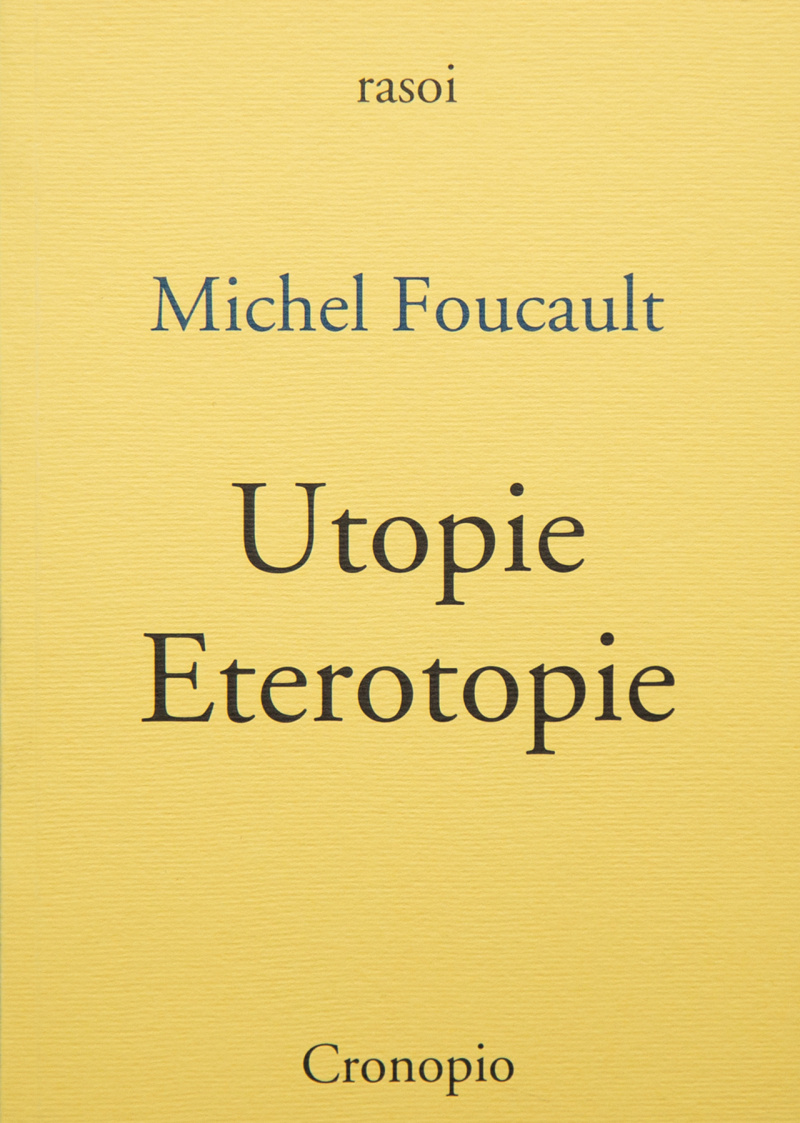
Spazi altri
Non ci sarà mai operazione estetica che possa dare a questi luoghi una funzione positivamente comunicativa, dato che sono pensati fin dal principio come eterotopie negative, non finalizzate cioè a un’ipotesi di astrazione dal contesto in funzione di recupero individuale, bensì a una definitiva esternità da esso. Per questo i Centri per il rimpatrio non hanno disegno architettonico: sono dei meri contenitori.
A volte, in alcuni esempi italiani, non hanno neppure la minima forma di possibile personalizzazione dello spazio interno da parte di coloro che vi sono trattenuti perché non vi è alcun mobilio – neppure quello inespressivo presente nelle celle di un carcere – né spazi comuni, né intimità minima. Al contrario, sono connotati dalla visibilità comune continua: a Gradisca d’Isonzo, uno dei Centri di più recente allestimento, i vari blocchi sono visibili l’un l’altro perché le pareti che delimitano gli spazi sono in duro materiale trasparente.
Un percorso simile lo hanno fatto in anni recenti anche le strutture penitenziarie. Quelle di progettazione successiva ai primi anni Settanta hanno sempre più proposto una modularità unificante che ha reso progressivamente anonimo lo spazio. D’altronde, se il tempo da trascorrervi perde di significato e diviene soltanto un ciclico scorrere, controllato da una sorta di metronomo che nulla concede al variare, anche lo spazio non ha ragione di dialogare con una internità temporale assolutamente uniforme. Il parallelepipedo ripetuto è il massimo della progettualità.
Resta nell’uno e nell’altro caso – nei Centri per migranti e negli Istituti penitenziari – il muro come elemento distinguente la sola funzione riconosciuta in ogni periodo, quella di rendere visibile l’atto stesso della separazione e invisibile chi viene separato, indipendentemente dal fatto che li si concepisca come luoghi dove scontare una segregazione o dove ricostruire una connessione. Per la prima impostazione, la separazione deve essere anche totalmente vissuta. Per la seconda, deve essere gradualmente diminuita, ma «alla sera si rientra nel recinto».
È cosa nota, del resto, che l’organizzazione spaziale di un luogo sempre riflette una visione delle attività che in esso si intende svolgere e di fatto ne determina la realizzabilità, così come definisce e determina lo schema delle relazioni che in tale luogo si tessono. Questa considerazione è ancora più vera quando si tratti di un luogo destinato a essere uno spazio istituzionale ove si realizza, quindi, una funzione socialmente predeterminata e in cui si opera attuando un mandato affidato dalla comunità esterna. Le relazioni che in tale spazio si stabiliscono si muovono all’interno di una funzione collettiva definita, programmata e corrispondente alla finalità a esso attribuita. È uno spazio definito anche ideologicamente. L’ideologia più volte affermata, anche da chi ha responsabilità istituzionale, della pena come mera custodia e del trattenimento dei migranti irregolari come necessaria attesa di un ritorno indietro, definisce anche la configurazione spaziale.
Il muro è il confine di questa definizione ideologica. Indica non soltanto separazione, ma appunto e soprattutto alterità.
Impacchettare i muri
Le nuove «eterotopie di deviazione» a cui si riferiva Foucault hanno bisogno di visibilità e il solo modo per il loro superamento è forse inserirle in un contesto differente, che faccia percepire l’unitarietà della loro funzione in rapporto con la quotidianità esterna ad esse. Rendere il muro un ‘oggetto’ – forse necessario sulla base di una specifica funzione – e non un ‘segnale’ di alterità o più spesso di uno stigma è un passo necessario perché l’eterotopia di deviazione interroghi anche chi di essa non è parte.
Avvolgerlo in teli di connessione con l’esterno è la necessità per interrogare l’esterno stesso perché solo così le eterotopie possono inquietare e mettere in crisi quella sintassi «meno manifesta che fa ‘tenere insieme’ (a fianco e di fronte le une alle altre) le parole e le cose». Perché le eterotopie sono luoghi che si oppongono a tutti gli altri spazi, che rendono assoluta la differenza tra interno ed esterno e proprio per questo, possono interrogare il loro esterno se soltanto ne viene colta la positività interrogante che tale loro diversità pone. Come scrive Antonella Moscati nel chiosare Foucault: «gli spazi altri restano luoghi di resistenza – non per quelli che vi stanno dentro, ma forse per alcuni di quelli che stanno fuori –– anche quando diventano, come nel caso di molte delle eterotopie contemporanee, spazi di reclusione. Perché prigioni, manicomi, ospizi per anziani, ma forse anche campi di vario genere – di cui peraltro Foucault non parla mai in questo contesto – insinuano comunque un dubbio nei confronti del nostro incosciente e autarchico benessere».
Avvolgere, impacchettare le mura non sarebbe perciò operazione di rimozione, ma di interrogazione: verso noi stessi e la nostra rimozione di quel mondo da cui non permettiamo uscita, se non per respingere ulteriormente o per permettere una vita sotto il continuo controllo. Servirebbe per capire come l’esterno a quelle mura possa interrogarsi, pensare in altro modo a chi è al di là di quel muro avvolto mentalmente in tela e costruire un suo possibile ritorno.
Perché l’esterno è anch’esso parte di quella separazione. Ne è costruttore continuo nelle forme di ri-accoglimento che porge a chi da quel muro può uscire. Non è una connessione caratterizzata dalla possibile autonomia del proprio percorso, bensì disegnata attorno a stereotipi che dovrebbero garantire la normalità di quell’uscita.
Eterotopia e utopia
Se nella descrizione del rapporto tra struttura detentiva e organizzazione sociale le parole chiave – che anche qui ho utilizzato e non certo come sinonimi – sono separazione e distanziamento, nella descrizione dell’esterno possibile posto a chi viene, temporaneamente o definitivamente, per un permesso, una licenza o per una definitiva uscita, dall’interno della cinta muraria, le parole sono obbedienza e familizzazione. Queste parole rischiano di costruire una nuova cinta muraria, non avvolgibile da alcuna tela. La prima – obbedienza – indica troppo spesso il pre-requisito perché si ottenga un permesso, perché si possa dimostrare di essere adeguati a ciò che è concesso, al beneficio – anche qui le parole contano – sulla base di un comportamento ritenuto meritevole di riconoscimento. È un’asimmetria implicita nello stesso linguaggio che circonda questo percorso trattamentale per il beneficio o comunque espiatorio che la persona compie per riavere la pienezza del suo agire. E la seconda parola – familizzazione – indica il paradigma di normalità che viene proposto alla persona una volta fuori da quella eterotopia negativa per farla così accedere a quella che era precedentemente una utopia positiva e che rischia di essere un percorso di neutralizzazione. Questo porta, per esempio, Foucault a interrogarsi sulla tendenza neutralizzante delle forme di alternativa alla detenzione, prive di una riflessione sui parametri di effettivo accesso a esse: «[…] credo anche che in questi istituti alternativi si veda in azione quello che chiamerei il principio di rifamilizzazione, ovvero il ritrovare sempre applicata con altri mezzi, ma pur sempre applicata, l’idea che la famiglia sia lo strumento essenziale della prevenzione e della correzione della criminalità. Nell’Ottocento questa idea esisteva già; adesso diremmo che per rifamilizzare il detenuto si usavano mezzi molto strani, essendo il compito sostanzialmente affidato a cappellani o a volontari delle carceri o a filantropi, a forza di sermoni, esortazioni, buon esempio ecc, […] una rifamilizzazione sostanzialmente astratta […] Ora quest’idea che la famiglia debba essere un fattore di legalità la ritrovate tale e quale, solo attuata con altri mezzi, negli istituti alternativi alla prigione».
Familizzazione e obbedienza sono due parole che si completano perché la prima implica la seconda che ne è, appunto, premessa. L’obiettivo dell’istituzione, con il suo muro è sempre quello dell’«autopunizione come principio della correzione». Da qui l’importanza dell’obbedienza e questa si basa su «la famiglia come agente di correzione e agente di legalità». A questi si aggiunge spesso il lavoro come strumento «essenziale di penalità» nella tradizione punitiva e come elemento unico del ritorno positivo nell’impostazione attuale frequente.
Qui il rifiuto della penalità punitiva si salda necessariamente a quello di una privazione della libertà – laddove strettamente inevitabile – esplicitamente dialogante con la collettività esterna e interrogante nei suoi confronti perché soltanto in questo modo i due mondi al di qua e al di là del muro che li divide si riconoscono. Un riconoscimento a cui contribuisce la capacità di rendere il muro ‘oggetto’, occasione di riflessione, forse anche elemento di espressione: da cui l’ipotesi di avvolgerlo come Christo Javachev fece con le Mura Aureliane a Roma.
Un panorama in cui proprio l’eterotopia diviene riflessione per la presunta utopia. Un panorama ben lontano dal presente che ancora pone all’esterno, con le sue diverse e omologanti parole, un muro di consuetudine neutralizzante. Per questo, ci sono molti muri da avvolgere.
Leggi anche:
Elettra Stimilli | Lessico Foucault. Spiritualità politica
Stefano Catucci | Lessico Foucault. Interstizio
Andrea Cavalletti | Lessico Foucault. Ubuesco







