Milo De Angelis. Millimetri
Sono passati trent’anni dalla pubblicazione di Millimetri, il secondo libro di Milo De Angelis, nella collana di poesia dell’Einaudi. Una nuova edizione celebra degnamente l’anniversario arricchendo quel capolavoro, esile e definitivo, con la riproduzione di alcuni dattiloscritti originali e una postfazione firmata a quattro mani da Giuseppe Genna e Aldo Nove (Il Saggiatore).
All’epoca, i due scrittori milanesi avevano più meno sedici anni, e leggevano Millimetri sull’autobus che li portava a scuola. Era ancora un tempo, quello, nel quale chissà come, chissà perché, i libri di poesia trovavano il modo di finire nelle mani dei lettori più intensi, inaffidabili, e difficili da conquistare: ragazzini di periferia insaccati nei loro giubbotti, con tutti i desideri affilati come lame, a scintillare nell’anomimato dell’inverno.

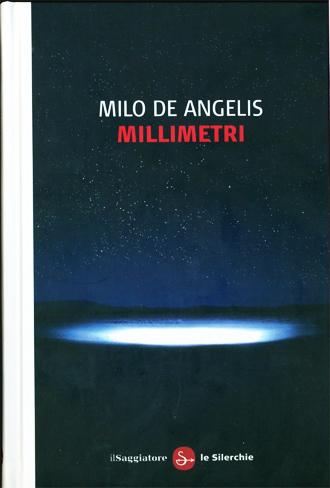
Genna e Nove in fondo scrivono una variazione sul famoso tema di Stendhal: «Ariosto ha formato il mio carattere». Con la differenza che qui siamo in pieno Novecento, si potrebbe dire che il secolo trasuda ancora da tutte le cose. E i caratteri si formano in modo molto meno armonioso di come potevano fare ai bei tempi, ascoltando le leggiadre lezioni dell’Ariosto. Millimetri è una scuola dura, di quelle che esigono di trovare da sé la propria postura, come hanno fatto, nel corso del secolo, i libri di Mandel’stam, di Celan, di Sylvia Plath. Non c’è mai stata un’epoca umana in cui l’individuo, per amore o per forza, è stato così vincolato, inchiodato alla sua storicità, alla grande anagrafe del divenire.
E i libri di poesia davvero importanti, che raramente evocano fatti e circostanze determinate, a saperli leggere sono la più compiuta testimonianza di questo vincolo insostenibile dell’essere e del tempo. Per questo motivo le date esatte dei libri sono molto più importanti che nei secoli precedenti, quando un’opera in genere poteva essere composta vent’anni prima o vent’anni dopo. Il 1983 è un anno tra tanti, coi suoi vincitori e i suoi vinti. L’apocalisse perpetua ha i suoi momenti di bassa tensione. Finisce l’orrida dittatura militare in Argentina, un camion carico di tritolo uccide 241 marines americani in una caserma accanto all’aereoporto di Beirut. Con un famoso discorso al Congresso, Ronald Reagan lancia il demente progetto dello Scudo Spaziale. Per rendere giustizia al più fido compagno della brutalità, che è sempre il sentimentalismo, potremmo aggiungere che nel 1983 uscì il primo disco di Madonna. Forse la cosa più bella che si possa dire di un anno, alla fine dei conti, è che gli siamo sopravvissuti.
Cosa sono, d’altra parte, trent’anni ? E soprattutto: cosa significa riprendere adesso in mano Millimetri, che ne è stato nel frattempo della sua leggibilità? Sono consapevole di essermi preso una delle peggiori gatte da pelare che possano toccare in sorte a un critico. E resisto alla tentazione di riprendere in mano, come un affidabile soccorso, Patto giurato, il bellissimo saggio che nel 1996 Eraldo Affinati ha dedicato alla poesia di De Angelis. Voglio sbattere a modo mio su questo muro - che forse è l’unico modo per sbucare dall’altra parte. Comincerei con l’evidenziare quello che mi sembra il cuore stesso della vertiginosa energia metaforica che anima da un capo all’altro le poesie di Millimetri.

Questo nucleo centrale riguarda il tempo, materia prima di un’arcana cosmologia enunciata fin dalla chiusa della prima poesia, I bastoni: «Chi genera il tempo/ha il volto arato e con pazienza ripete/che noi ubbidiamo». Sembra di capire che De Angelis, come un neoplatonico, considera il tempo una specie di illusione, un pericoloso surrogato dell’eternità. Ma un’illusione non è solo qualcosa di cui è possibile liberarsi, come lacerando un velo. In genere, tendiamo a dimenticare che una delle prerogative principali dell’illusione è la potenza: incomparabilmente maggiore di quella che possiede la cosiddetta verità.
Ed è per questo che le misteriose figure che generano il tempo, simili a demiurghi gnostici o a sculture di Henry Moore, non possono che ripeterci «che noi ubbidiamo», costretti fra le mura di questo carcere in perenne movimento, che ci trascina via con lui. E’ pure vero d’altra parte che, se noi non possiamo evadere dall’illusione, possiamo arrestarla nel momento in cui veniamo attraversati dal ricordo di una realtà ulteriore, primigenia. La forza di questo ricordo consiste nell’essere indipendente dal tempo.
Si configura infatti come un’illuminazione momentanea e imprevedibile, una specie di puntura di spillo gnoseologica capace di inceppare il meccanismo, come viene descritto in questi versi di Nati sulla terra: «Ecco la pagina di quarzo/nell’agenda, quando/ogni uomo viene raso al suolo/e ricorda». Si potrebbe dire che la poesia, per De Angelis, è la lingua di questo ricordo, il discorso che si può scrivere solo quando tra le pagine dell’agenda, nel loro implacabile susseguirsi, irrompe la pagina di quarzo, quella che non proviene da una data precedente e non conduce a una data successiva. Ciò che rimane di un uomo «raso al suolo» non è dunque la capacità di accedere a dimensioni inaudite della conoscenza, ma di orientarsi verso un’origine imperitura, che soggiace a tutte le menzogne del divenire. E’ questo il punto fondamentale, l’intuizione capace di bruciare tutte le scorie prodotte dall’errore e dalla dimenticanza di noi stessi.
Da questo punto di vista, ritengo ancora molto giustificato quel ricorso alla nozione di orfismo che spesso si è accompagnata alla poesia di De Angelis, ma in modo così approssimativo da finire per diventare una specie di assurda etichetta collettiva e in molti casi un insulto bello e buono. Anche per colpa delle troppe incrostazioni semantiche improprie che hanno afflitto concetti come «orfismo» e anche «ermetismo», una volta degradati a strumenti critici utili a definire un’idea di “stile” o ancora peggio stabilire l’esistenza di qualche conventicola letteraria.
De Angelis è completamente estraneo all’influsso di queste pacchiane metafore classicheggianti. Nemmeno l’«uomo orfico» di Rilke e le straordinarie variazioni sul tema di Blanchot sembrano averlo toccato in profondo. Semmai, gli si può attribuire lo stesso rigore filologico, e la stessa precisione semantica, che vanno riconosciuti a Thomas Mann quando definisce «romanzo ermetico» la vicenda iniziatica della Montagna incantata. Come l’ermetismo di Mann, l’orfismo di De Angelis non è una citazione colta né una metafora imprecisa. Il confronto della poesia di Millimetri con le più originarie ed autentiche fonti greche di fatto risulta illuminante. Non si conosce mai esattamente la dinamica di queste riemersioni dell’antico nell’opera di un moderno. Mi chiedo però quanto abbia contato, per De Angelis e non solo per lui, un’opera come La sapienza greca di Giorgio Colli, il cui primo volume, uscito nel 1977, aveva una grossa sezione dedicata a testimonianze e frammenti sull’orfismo.

Osservando la riproduzione dei dattiloscritti di Millimetri, pezzetti di carta piegati come se il poeta avesse l’abitudine di portarsi a lungo in tasca i suoi versi, mi sono venute in mente le cosiddette laminette orfiche pubblicate da Colli: i piccoli rettangoli d’oro con le istruzioni per l’ingresso nell’Ade che nella Magna Grecia e in altre zone periferiche i devoti mettevano in bocca ai loro morti. Nel suo nucleo essenziale, la dottrina orfica era una via di salvezza basata sulla liberazione dalle illusioni, sul ricordo della propria vera natura. E’ un ritorno alla verità concepito come un ritorno all’origine. E’ la stessa promessa che risuona, con un timbro quasi liturgico, nei versi più famosi e citati di Millimetri, e dell’intera poesia di De Angelis: «nei pazzi giungerà l’universo,/quel silenzio frontale dove erano/già stati» (Questi succhi). Formula che ancora non lo convince pienamente e che in una successiva poesia (La goccia pronta per il mappamondo) viene trasformata in senso più corale, acquistando in suggestione e limpidezza: «In noi giungerà l’universo,/quel silenzio frontale dove eravamo/già stati». Ma quel «noi» a pensarci bene, non è che un altro modo di dire «pazzi», ovvero uomini rasi al suolo, sospinti dal movimento del ricordo «all’alba/delle cose, tra le sei meno venti/e la buona fortuna».
Non perché sia “difficile” o “oscura” la poesia di De Angelis respinge ogni parafrasi, ogni addomesticamento razionale. Al contrario, noi facciamo l’esperienza di un dettato poetico animato da una tale necessità che tutto, alla fine, viene accettato come inevitabile. Quando leggiamo, per fare un esempio memorabile fra tanti, che «la mela/è morta» noi non sappiamo da dove viene questa mela, e nemmeno di cosa è morta, ma il dettato poetico, con tutta la forza di quell’a capo che scandisce la sentenza rendendola assoluta e irrevocabile, ci convince che qualcosa di vero è accaduto, che una verità è stata enunciata. Basta mettersi sulla lunghezza d’onda giusta, che non è quella del linguaggio ordinario, naturalmente, ma non è nemmeno quella del linguaggio poetico inteso in senso classico come rapporto instabile e sorprendente fra denotazione e connotazione. De Angelis procede come se il primo termine della coppia semplicemente non esistesse. O come se deliberatamente avesse bruciato i ponti, non permettendo più né a se stesso né ai suoi lettori un comodo andirivieni tra i limiti raggiunti dall’espressione e la riserva dei significati “normali” delle parole.
Per dirla brutalmente, la poesia non è più un modo per dire in una certa maniera eccentrica e rivelatrice qualcosa che potrebbe pur sempre essere detto con una parafrasi o un riassunto puramente referenziali. Nessuna poesia di De Angelis possiede questo rassicurante fantasma. Se la mela è morta, ciò significa che la mela è morta. La stessa metafora ha il ruolo di elemento ulteriormente propulsivo di un discorso che non si guarda mai alle spalle, e procede generandosi da se stesso e generando da se stesso tutte le sue possibilità di significato. Sembra quasi una minuscola ars poetica quella contenuta in questi versi: «La saliva risucchia/se stessa e beve». Volendo usare un’immagine puramente suggestiva, è come se le scarpe del famoso quadro di Van Gogh iniziassero a camminare senza nessun piede che le calzi.
E se è vero che tutti i grandi libri sono anche, in parte, dei cattivi maestri, bisogna aggiungere alla testimonianza di Genna e Nove anche il fatto che abbiamo provato in tantissimi ad imitarla, quella poesia che ci aveva conquistato come nessun’altra.
Cercavamo la nostra mela morta, ci andavamo vicino, ma potevamo devastare un intero frutteto, e non arrivavamo al punto. Tornavamo a leggere, a sottolineare: «questa/pioggia bucaniera nasce/e appena nasce/scardina la sua stessa figlia». Sembra facile, ed è impossibile. Nemmeno Milo De Angelis sarebbe stato in grado di imitare se stesso, come ha dimostrato fino ad oggi la sua eccezionale carriera. Si può imitare uno stile, si può imitare un qualche tipo di gergo letterario, ma non si può imitare la vita altrui.
E Millimetri è proprio questo, una scheggia di vita in forma di libro, qualcosa di solitario e irripetibile come sono gli esseri umani, non importa se pensiamo che sia il caso a farli così oppure il destino. Alla fine, abbiamo capito che l’unica forma di imitazione utile di Millimetri era cercare di vivere la nostra, di vita, qualunque fosse. E festeggiando i trent’anni di questo libro indimenticabile, lo ammettiamo senza tante storie: l’unico capace di ammazzarle, le mele, è sempre stato Milo De Angelis. Sono sue, e ci fa quello che vuole.
Questo articolo è apparso precedentemente su il manifesto







