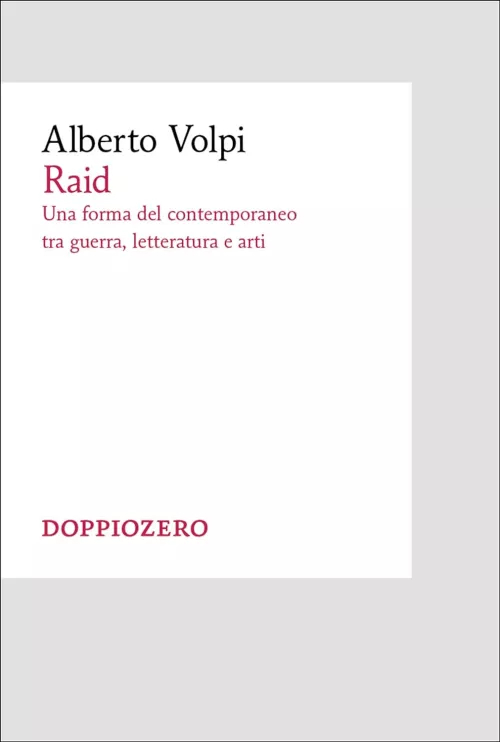Speciale
Raid / Prefazione di Antonio Scurati
Pare sia rimasta soltanto la cronaca a fare la storia. La cronaca con la sua accidentalità irredimibile, con la sua incidentalità sistematica, con la sua violenza mordi e fuggi. È di qualche tempo fa la notizia del raid a colpi di spranga contro tre inermi immigrati romeni nel quartiere torinese di Madonna di Campagna. Non è stato il primo raid scaturito dall'odio contro gli stranieri e di certo non sarà l'ultimo. Fin troppo facile biasimare l'intolleranza razziale, sempre più diffusa nelle nostre società multietniche. Più interessante, forse, notare che a legare questi episodi non è tanto il contenuto di supposto odio razziale ma la forma. Ossia il raid. Vale a dire che il raid si va imponendo come una delle forme principali della conflittualità - fisicamente o solo simbolicamente violenta - del mondo contemporaneo.
Il raid indica un'incursione, un'improvvisa andata e un veloce ritorno in territorio nemico. Chi compie un raid lo può fare con l'intenzione di razziare, saccheggiare, rapinare, oppure la scorreria può anche limitarsi all'unico obiettivo di portare distruzione e morte nel campo avverso senza alcuna immediata contropartita che non sia il danneggiamento non definitivo e non risolutivo della vittima-bersaglio. Si può scatenare un raid a scopo di intimidazione, di indebolimento, di punizione - talvolta, raramente, lo si può programmare con l'obiettivo di portare in salvo qualcuno - ma ciò che distingue essenzialmente il raid dal blitz krieg di tipo militare classico è che il primo non si propone una avanzata di massa avente come scopo la conquista territoriale. No, il raid colpisce duramente nel cuore del campo avverso per poi però subito ritirarsene. La caratteristica essenziale del raid è che chi lo compie si muove in territorio nemico ma non mira a farne terreno proprio. Anzi, il nichilismo esorbitante insito nella forma del raid finisce con il trasformare in territorio nemico anche il proprio territorio.
La violenza del raid alimenta un'inimicizia assoluta e infinita, estranea anche alla più remota speranza di porre fine, fosse anche grazie a un colpo micidiale. Il raid è, perciò, una manifestazione di tatticismo esasperato che si sa condannato a doversi muovere sempre nel territorio dell'altro senza mai poter incontrare l'avversario se non come cadavere, è la forma disperata di una violenza estrema ma mai ultimativa, è la guerra andata in cancrena, ma in modo endemico, cronicizzato, una cancrena senza promessa di mortalità risolutrice. Nel raid il conflitto estremo non è più nemmeno una forma paradossale di relazione all'altro. In esso la violenza non ha nulla in comune con il nemico contro cui è rivolta, nemmeno il terreno di scontro.
Quando si entra nella logica abissale del raid, ci si destina a rimanere per sempre stranieri, anche in Patria; per sempre soli, anche in presenza del nemico.
Facile allora accorgersi di come gli ultimi decenni della nostra storia planetaria ci abbiano consegnato a un'agghiacciante proliferazione del raid, a una sequela ininterrotta e interminabile di incursioni in territorio nemico, ma anche di eguali e simmetriche rappresaglie. La logica aberrante del raid sembra, infatti, imporre che le si possa rispondere soltanto con un controraid. Gli attentati dell'11 settembre, riletti da questa prospettiva, appaiono come un momento apicale, non certo isolato, di una lunga serie storica di rapide, devastanti incursioni in un mondo trasformato in un immenso territorio di scorrerie multiple per commando omicidi. A leggere la Breve storia dell’autobomba di Mike Davis (Einaudi) sembra anzi che il secolo scorso - un secolo che non trascorre - dall'attentato di Wall Strett del 1920 dell'anarchico Mario Buda, passando per la Palestina del 1947, per l'Indocina, per l'Algeria dell'Oas, per il Libano, l'Afghanistan, l'Iraq, fino a tornare ancora alla Palestina dei giorni nostri e di sempre, sia stato interamente attraversato dalla linea di febbre omicida del raid. Con l'eccezione macroscopica - si dirà - dell'occupazione di Iraq e Afghanistan e dei «Territori» da parte di Israele dopo la “Guerra dei Sei giorni”. Ma anche in questi casi, purtroppo, l'occupazione militare non ha fatto altro che spostare di qualche chilometro quei confini continuamente attraversati da incursioni in territorio nemico, quelle esili linee di inimicizia continuamente insanguinate dallo stillicidio di raid e controraid.
Ma c'è di più. Come argomenta con ampiezza di documentazione Alberto Volpi in questo saggio, la logica del raid si estende ben oltre l'ambito della conflittualità para-militare, tanto da diventare una forma del contemporaneo anche in arte e in letteratura (si pensi all'artista come guastatore, agli ininterrotti sconfinamenti delle molte avanguardie novecentesche). E soprattutto, aggiungeremo noi, il raid s'impone come forma del contemporaneo nel campo della comunicazione di massa. Cos'è stata la polemica scoppiata attorno all'invito a Israele da parte della “Fiera del Libro” l’altro anno, se non il frutto avvelenato di un subdolo raid informativo attuato da Tariq Ramadan, il sinistro portavoce colto dell'islamismo radicale, nel territorio «nemico» dei media italiani? Ramadan ha pilotato le dissenzienti opinioni civili di un'ala minoritaria della sinistra piemontese fino a farle esplodere sulle pagine dei principali quotidiani nazionali. E cos'è stata la lista di professori italiani di religione ebraica pubblicata da un abietto ignoto su Internet se non un raid informatico? Ma, a volerla dire tutta, anche la controffensiva mediatica sparata su tutti i media, con volume di fuoco enormemente superiore, contro i supposti nemici del popolo d'Israele e dei sacri valori democratici rischia di finire risucchiata nella logica del contro-raid se lascerà dietro di sé soltanto rovine fumanti in territorio nemico.
Per saperne di più e rifletterci sopra non ci resta che leggere questo saggio di Volpi, un lavoro interdisciplinare su una delle forme del contemporaneo.