Rivoluzioni Twitter, miti 2.0 per il postconflitto
Si cominciò a parlare diffusamente di rivoluzioni 2.0 e di rivoluzioni Twitter, quando nel 2009 milioni di iraniani scesero per le strade di Teheran per protestare contro i brogli elettorali che scipparono la vittoria a Moussavi. Grido di battaglia di quella rivolta era un tweet dell’esponente politico iraniano, oppositore del presidente Ahmadinejad.

Erano passati pochi mesi dall’insediamento di Barack Obama e pochi giorni dal suo storico discorso al Cairo intitolato “A new beginning” (Un nuovo inizio), con il quale il nuovo presidente auspicava la chiusura della stagione di conflitti aperti dagli attentati dell’11 settembre. Un discorso che era, nel titolo e nelle argomentazioni, una espansione di quello rivolto da Obama al popolo iraniano il 19 marzo 2009 e affidato a una piattaforma 2.0: YouTube.
In quelle settimane di scontri, l’informazione fu assicurata da alcuni coraggiosi ed esperti utenti Twitter che, come Persiankiwi, raccontavano la rivolta e garantivano con i retweet la circolazione di immagini e notizie, riuscendo ad aggirare i blocchi imposti alla Rete dal governo iraniano. Solo così abbiamo potuto vedere le drammatiche immagini della morte di Neda, e ascoltare le voci della protesta attraversare le notti di Teheran.
Intanto sulla stampa e sui blog occidentali – il più noto in quei giorni era quello di Andrew Sullivan – venivano raccolti e pubblicati i tweet provenienti dall’Iran, alimentando l’idea che fossero gli strumenti del web 2.0, Twitter e Facebook in testa, a permettere agli iraniani di organizzare e diffondere la rivolta. Si cominciava così a parlare di “Rivoluzione Twitter”, espressione coniata appena qualche mese prima in occasione di alcune proteste esplose in Moldavia.
Quest’idea assunse in quei giorni delle precise forme visuali. Una ricorrenza tematica molto significativa è rappresentata dalle fotografie che ritraggono in primo piano i dispositivi tecnologici. In queste immagini è la tecnologia a ricoprire il ruolo di soggetto rivoluzionario, mentre le persone si riducono a contorni sfumati. Quasi in una rivisitazione del mito rivoluzionario alla Delacroix, ora è uno smartphone a guidare il popolo e a sostituire la bandiera e le pistole del dipinto ottocentesco.
 Amir Sadeghi, Teheran 2009
Amir Sadeghi, Teheran 2009
Compaiono sul web pugni chiusi composti da hashtags, fumetti che rivisitano in versione 2.0 il Persepolis di Marjane Satrapi, caricature del presidente Ahmadinejad atterrito dai dispositivi tecnologici e vignette che riadattano le icone e gli immaginari rivoluzionari ottocenteschi e novecenteschi, come le famose immagini di piazza Tienanmen, al mito della nuova tecnologia della liberazione: il web 2.0.

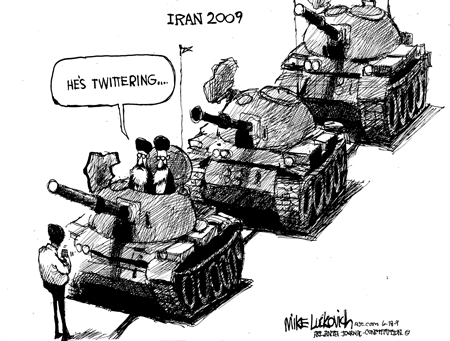
L’immaginario della rivoluzione 2.0 ritorna prepotentemente alla ribalta tra 2010 e 2011 con la cosiddetta Primavera Araba. Vengono riutilizzate, con alcune modifiche, le vignette pubblicate nel giugno 2009 e i fotografi ripropongono uno stilema ormai ben riconoscibile e consolidato: il dispositivo tecnologico, in primo piano, e l’“Arabo”.
 Fotografia di Moises Saman, Siria 2011
Fotografia di Moises Saman, Siria 2011
Studiosi come Mark LeVine si spingono a parlare dell’aura di Apple che, dopo aver “irradiato” artisti, designer e creativi della Silicon Valley, ora investe l’“Arabo”, trasformandolo in un rivoluzionario. Come suggeriscono alcune foto pubblicate nel 2011 dal New York Times nella consueta galleria di fine anno, l’aura emessa dai dispositivi tecnologici occidentali è capace di illuminare e restituire una individualità anche alle donne rese tutte uguali dal velo, come avviene nelle foto di una manifestazione in Qatar.


Le foto rappresentano una nuova prossimità degli opposti, una sorta di alleanza tra la Mela e la Mezzaluna: dopo più di dieci anni di “guerra al terrore”, i simboli dell’Islam e quelli dell’Occidente – i marchi delle sue multinazionali dell’IT – entrano in una relazione di amicizia in un complessivo processo di branding dei movimenti di rivolta. Un’idea che per il giornale newyorchese si estende indistintamente, e a volte incongruamente, a tutto il mondo musulmano, anche quello non interessato dalle rivolte, come nel caso afgano.
 Fotografia di Keith Berkoben/Fab Folk
Fotografia di Keith Berkoben/Fab Folk
 Fotografia di Hameed Tasa/Fab Folk
Fotografia di Hameed Tasa/Fab Folk
Il punto più alto di questa nuova retorica, politica e visuale, arriva con il caso di Wael Ghonim, il trentenne e coraggioso responsabile dell’area marketing di Google per il Medio-Oriente e il Nord Africa che, arrestato all’inizio del 2011 dal regime di Mubarak, viene liberato su pressione delle istituzioni internazionali e salutato dalla stampa come l’eroe che salverà l’Egitto e caccerà il tiranno. Time lo nomina, due mesi dopo la caduta del rais egiziano, uomo dell’anno e lo ritrae nel ruolo dell’Eroe in una posa che ne sanziona la vittoria: Ghonim, “il dipendente di Google” siede al centro di quello che sembra il teatro dello scontro, su un improvvisato trono, tenendo alla sua destra l’arma della battaglia, un Macbook.
 Fotografia di Martin Shoeller per Time
Fotografia di Martin Shoeller per Time
Il mito delle rivoluzioni 2.0 nei paesi a maggioranza musulmana, così come raccontato su buona parte della stampa occidentale, ha svolto in realtà una duplice funzione. Prima di tutto si è costituito come una narrazione postconflittuale capace di ricollocare l’Islam, o meglio l’immagine che ne abbiamo in Europa e Stati Uniti, da una posizione di ostilità – quella che ha segnato gli anni successivi all’11 settembre – a quella di amicizia. Si tratta forse di una caratteristica degli anni della presidenza Obama, tesa a spostare l’asse della politica estera dall’hard power delle armi al soft power della persuasione e dei simboli culturali americani. Nell’epoca del capitalismo globale e delle multinazionali è l’immagine di un brand tecnologico occidentale in mano al “soggetto islamico” ad aver funzionato da narrazione riconciliativa o, per dirla con Obama, a rendere visibile un promesso “nuovo inizio”.
La seconda funzione è quella invece di riporre la figura del “rivoluzionario arabo” nuovamente sotto il dominio occidentale: è comunque la tecnologia “donata” dall’Occidente a essere, nelle rappresentazioni che abbiamo visto, il vero soggetto della rivoluzione; ed è il dispositivo tecnologico occidentale che, nell’idea di rivoluzione 2.0, permette all’“Arabo” di ribellarsi ed emanciparsi. La focalizzazione sul dispositivo tecnologico in queste rappresentazioni riduce l’importanza dell’azione politica collettiva delle popolazioni arabe e degli iraniani: un’idea che i marxisti d’antan avrebbero definito imperialista e che Edward Said definisce nelle sue opere – tra le quali ricordiamo soprattutto Covering Islam, finalmente disponibile anche per il lettore italiano grazie a Transeuropa – un tentativo di ridisegnare il “campo orientalista”.
Dire che le rivoluzioni 2.0 sono un mito che ha funzionato come un tentativo di narrazione postconflittuale vuol forse dire che esse sono una totale invenzione? Probabilmente internet e le nuove tecnologie sono servite soprattutto a noi, da questa parte del mondo, a capire cosa stava succedendo in quei paesi. In parte però distorcendo, nel senso che ho qui indicato, la prospettiva sugli eventi. Ritorniamo per un attimo al messaggio di Moussavi, quello da molti indicato come il big one delle Rivoluzioni Twitter: voi usereste internet per comunicare ai vostri connazionali che internet non funziona, usando anche una lingua straniera?









