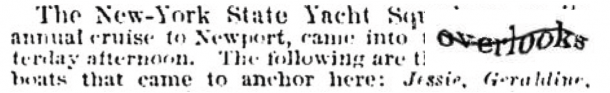Captcha: queste strane parole
Ogni tanto succede, girando per la rete, di imbattersi in delle strane lettere aberrate da distorsioni, colori e disturbi vari. Ti chiedono di leggere e compilare. Si sbaglia (sempre), ci si arrabbia (sempre) e si tira avanti senza farsi tante domande (quasi sempre).
In realtà quelle curiose e anomale figure si chiamano Captcha, e la verità (per chi non lo sapesse) è che ci hanno messo anni, nelle pause pranzo da Starbucks nella Silicon Valley, per capire come risolvere il problema numero uno: la sicurezza. Come evitare che un computer riesca ad interagire con un server senza che effettivamente ci sia un essere umano a volerlo.

E già questo è interessante come questione sostanziale: l’idea, non banale, è che la vista (la capacità interpretativa del vedere) non sia replicabile da una macchina. La grafica, quella strana invenzione con cui gli umani interpretano informazioni attraverso grafie, spaziature, simboli e segni, per un calcolatore è terreno accidentato. E così, una decina di anni fa, per proteggere i loro server (e quindi le nostre vite), hanno messo a punto un sistema basato su immagini.
Niente password, impronte digitali, criptature o alchimie di codice: semplici immagini, a confermare la presenza umana. Che è come dire che, nella grande partita a scacchi fra l’uomo e la macchina, la grafica si connota come pedina vincente, facendo assurgere l’immagine a connotatrice di senso e la lettura della stessa a inconfutabile prova di intelligenza naturale.
L’altro dato interessante è squisitamente grafico. Non credo, anche se qui urgerebbe un esperto, siano molte le esperienze grafiche generate con sistemi di progettazione automatizzata e casuale. I Captcha non sono figli della fantasia deformata di un creativo, ma l’imponderata risultante di infinite variabili volute, di ragionatissime alchimie software. Sono la cristallizzazione di una struttura mentale prima che visiva. Lettering pensato, prima che disegnato.

L’altro punto, anche se qui è terreno scivoloso, è la strana sensazione che queste immagini potrebbero essere, tout court, nei corridoi della Tate. D’altronde, se l’arte ha ancora un nesso con l’estetica (la conoscenza del sensibile, diceva Baumgarten), i Captcha sono un capolavoro, in quanto fascinose alterazioni di percezione. Il famoso specchio rotto dell’estetica di Adorno.
E a ben pensarci, alla questione del metodo come inderogabile necessità visiva, del pensiero logico come variabile strutturale dell’estetica, del concetto come operazione preliminare all’elaborazione di un’immagine, sostanzialmente l’arte contemporanea, durante il novecento, non ha fatto altro. È inutile stilare la lista, ma un artista come Boetti, per esempio, di una cosa del genere sarebbe profondamente innamorato.
Piccola nota: Google (che al solito è il gigante buono) ha comprato una delle società di gestione e creazione dei Captcha e ha usato come parole da deformare le parole dei testi antichi che i computer non sono riusciti a scansionare. Quando ognuno di noi le compila, in realtà sta involontariamente aiutando i computer a compilare e completare la digitalizzazione di quei testi, spesso scritti male e con grafie incomprensibili alle macchine. Realizzando così una meravigliosa, utopica e inconsapevole cooperazione mondiale alla diffusione gratuita della cultura.