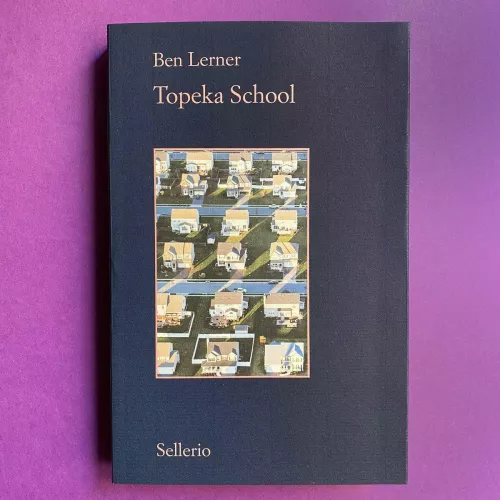Solo il tempo dirà se il tempo dirà / Ben Lerner, Topeka School
«Quando cade la prima neve a Topeka, a Berlino, a Brooklyn, dando al mondo esterno la sensazione di un vasto interno, bisogna avere una mente da inverno, voltare la testa verso i fiocchi che si accumulano sul davanzale – Adam obbedì, e vide un passero che saltellava fra i ramoscelli – e tornare alla scena primaria della propria infanzia.»
Tra gli scrittori della sua generazione (è nato nel 1979) Ben Lerner è uno dei più interessanti, uno dei più bravi. Poeta, narratore, saggista, dotato di grande capacità retorica e di gestione del linguaggio, gli è stata data più volte l’etichetta di scrittore del futuro. Più precisamente, si è detto che la letteratura di Lerner pare venire dal futuro. Ma che significa scrivere dal futuro? Probabilmente nulla. Di certo Ben Lerner è uno scrittore innovativo, capace di usare tutta la tradizione poetica e narrativa, che conosce a menadito, reinventandola, inserendola nel nostro tempo, attraverso il superamento della trama rendendola secondaria rispetto al linguaggio, alla capacità dialettica dei personaggi, ai dialoghi potentissimi, colti, lunghi ma mai dispersivi. Lerner secondo me è uno scrittore del presente, la sua è la letteratura del nostro tempo. Sembra che arrivi dal futuro perché meglio di altri riesce a intercettare di questi anni tutta la complessità. Sono scrittori di questo tipo Don DeLillo e David Foster Wallace, giusto per fare due nomi, perché hanno saputo spostare – tra le altre cose – più in là gli orizzonti della narrativa, quando il racconto semplice (tra molte virgolette) sembrava non bastare più.
«Insieme al puro terrore di essere finito nella casa sbagliata, insieme al riconoscimento delle differenze, ebbe la sensazione di trovarsi, uguali com’erano, in tutte le case attorno al lago nello stesso tempo: il sublime ripetersi di uno schema sempre identico. In ogni casa c’era lei o una persona come lei nel suo letto, addormentata o a far finta di dormire: i legali responsabili erano in fondo al corridoio, gli uomini di grossa corporatura russavano, le facce e le pose nelle foto di famiglia sulla mensola potevano cambiare, ma appartenevano tutte alla stessa grammatica di facce e di pose.»
Il romanzo più recente di Ben Lerner è Topeka School (Sellerio, 2020, traduzione di Martina Testa) è uscito in Italia qualche settimana fa. Si tratta di un libro raffinato ed eterogeneo, che si sviluppa su più piani. Siamo negli anni novanta a Topeka, in Kansas, luogo in cui è nato lo stesso Lerner, la storia si dipanerà su due città, oltre a Topeka non può mancare New York che dello scrittore americano è la città d’adozione. È il racconto di una famiglia ma anche la narrazione di un particolare decennio degli Usa, gli anni novanta appunto, quella terra di mezzo che abbiamo attraversato per toglierci di dosso le scorie degli anni ottanta e per andare a vedere dal duemila in avanti cosa sarebbe successo.
Il protagonista si chiama Adam, all’inizio del libro ha 17 anni e partecipa a campionati scolastici di retorica, di cui è un fuoriclasse. Ragazzini che dibattono sull’Iraq, sull’economia globale, sulle conseguenze della caduta del muro di Berlino, sulla crisi petrolifera, sulla situazione in Kashmir. Il primo punto di interesse del libro viene proprio da questi match. Lerner dipinge queste dispute come appuntamenti che si reggono sull’abilità retorica, sulla velocità con cui il concorrente è in grado di adoperare il linguaggio. Quasi sempre è la forma a prevalere sul ragionamento. Adam è figlio di due psichiatri di successo, Jane e Jonathan. Jane si occupa del ruolo della donna nel mondo dominato dagli Uomini (li definisce così con la maiuscola) e scrive libri di successo, tiene conferenze. Jonathan è esperto di disagio giovanile. I due sono di New York, sono illuminati e brillanti, sanno gestire il conflitto, dialogano e discutono su ogni cosa. Analizzano per lavoro, ma sono capaci di farlo anche a cena o davanti a un quadro.

«Sia ai genitori che ai pazienti sembrava che tutto succedesse all’improvviso: un giorno sei sulla monovolume di famiglia, diretto in gelateria dopo gli allenamenti di baseball, e canti a squarciagola We Are the Champions insieme all’autoradio, e il giorno dopo sei davanti a un giudice che ti spiega che Jacob può scegliere fra un certo periodo di detenzione in un carcere minorile e le cure psichiatriche.»
Lerner guida il romanzo attraverso i punti di vista dei tre protagonisti. I capitoli si intitolano semplicemente con i loro nomi. Ognuno racconta (o il narratore racconta per loro) un momento del 1997, il punto in cui è la loro vita adesso e, – in particolare – Jane e Jonathan, da dove è arrivato, cosa è accaduto prima. Il loro prima è per Adam il dopo, sogna di fare il poeta, sogna i reading, la New York da dove i genitori sono partiti. Si nota il suo senso di giustizia, l’idea di uguaglianza che lo proietterà in quello che diventerà nel futuro, nell’ultima parte del libro. Intanto Adam è un ragazzo, ci sono la musica rap, il sesso, le ubriacature. Ci sono i racconti dei genitori, c’è l’America che cambia, e che cambierà.
L’operazione di Lerner è particolare, però, la storia qui serve al linguaggio per dominare e proiettarsi nel futuro (questo sì). L’abilità dialettica dei tre e di altri personaggi centrali come Sima, amica di Jane e poi amante di Jonathan, li portano a fare discorsi di una precisione linguistica degna dei funamboli della grammatica. Sono profondi e attraverso l’ampia struttura dei loro ragionamenti mostrano le mille sfaccettature che si nascondono dietro la serenità familiare, le vite borghesi, un paese che non completa mai la realizzazione della sua utopia ma che non sta mai fermo. Lerner è scientifico e lirico, non dimentica mai di essere un poeta e, tra i tanti momenti in cui le parole suonano, ci regala omaggi e citazioni come quella al suo amato John Ashbery.
«Immaginateci illuminati per un attimo dai fari di un camion di passaggio mentre gira sulla rotonda di Greenwood Avenue: uno psicologo trentatreenne di New York che una volta si era fumato una sigaretta con Bob Dylan su Clinton Street e un occhialuto psicanalista europeo ultrasettantenne di un metro e novanta che era stato in rapporti cordiali con Einstein. Passeggiavamo.»
Il linguaggio perciò ci sfida, bisogna misurarsi non solo come fa Adam nelle gare di retorica, ma misurarsi con la lingua ogni giorno, perché meglio parliamo, più accuratamente diciamo, tanto meglio saremo in grado di argomentare, ragionare, vedere quello che il mondo ci riserva, quello che ci nasconde. Lerner adopera questa chiave per fare a pezzi il classismo, mostrare tutte le debolezze della borghesia, il razzismo di cui l’America non è capace di disfarsi, il bullismo, la misoginia, i fallimenti dei matrimoni, i tradimenti inevitabili. Lerner alza la posta ancora di più rispetto al bellissimo Nel mondo a venire (Sellerio, 2015 trad. M. Testa). In quel caso si trattava di un memoir molto sperimentale, di storie dentro la storia, ad esempio il narratore riceveva la notizia che un suo racconto sarebbe stato pubblicato sul New Yorker e ce lo piazzava dentro nel capitolo successivo, la grande mela era sulla soglia di una piccola catastrofe, il protagonista era un professore con un problema all’aorta, c’erano i musei, la poesia e un bambino d’aiutare. Lerner parlava di propriocezione e ci conduceva in un mondo pieno di elettricità e di tempo sospeso, in cui perfino la pioggia sembrava fermarsi un attimo in più tra i grattacieli prima di cadere.
«Klaus scherzava sempre, Klaus non scherzava mai: sotto la sua ironia c’era il senso dell’assurdità dell’essere sopravvissuto, o l’assurda ipotesi che qualcuno possa mai sopravvivere, pur continuando a respirare, o l’assurda idea che dopo il pollaio, dopo i lager, il linguaggio possa essere qualcosa di più che puro rumore.»
In Topeka School, apparentemente, Lerner mette da parte il memoir e scrive un romanzo che – in superficie – non è nient’altro che un romanzo: incipit, sviluppo e finale. In realtà, Lerner mettendo il linguaggio al di sopra di tutto, anche di sé stesso, rende superfluo il genere (in fondo Adam chi è se non lui?) e alza la posta. Ti mostro le nostre miserie, sembra dire, le nostre sconfitte, ma anche le nostre speranze, attraverso l’uso di parole migliori, di articolazioni più dense, di pensieri stratificati. In questo è parecchio simile a David Foster Wallace, anche se non è così divertente, ma raggiunge comunque lo scopo.
In una poesia del bellissimo Le figure di Lichtenberg (Tlon 2017, traduzione Moira Egan e Damiano Abeni), Lerner scrive: «Solo il tempo dirà / se la mia opera è figurativa / solo il tempo dirà se il tempo dirà».
Il tempo ci sta dicendo che l’opera di Lerner è in continua trasformazione, ha la capacità di alternare commozione a ragionamento multiforme, scrive in divenire, cercando di cambiare le strutture esistenti con altre non meno lineari ma più varie, meglio scandite, diversamente pronunciate. Così come la propriocezione, che usava nel libro precedente, indica la capacità di percepire la posizione del proprio corpo nello spazio senza il supporto della vista, il linguaggio – in Topeka School – invita a riconoscere di cosa sono capaci questi giorni, e a percepire con le parole e la logica (anche dei sentimenti) i mutamenti del tempo.