Cannes 77/3. Quando il cinema guarda se stesso
Le palpebre di una persona adulta sbattono sull’occhio tra le 15 e le 20 volte al minuto, che vuol dire circa 15-20mila volte in un giorno. Se non lo facessimo, i nostri occhi si seccherebbero e alla lunga diventeremmo ciechi. Per vedere insomma, dobbiamo chiudere gli occhi. Per riuscire davvero a guardare, abbiamo bisogno ogni tanto anche del buio, anche dell’assenza di immagini. Oggi, ci dice Leos Carax nel suo bellissimo video-saggio C’est pas moi presentato a Cannes Première nei giorni scorsi, sembra che il flusso di immagini sia tale che questo atto minimo di presa di distanza sia diventato impossibile: il risultato è che vediamo sempre di più, ma riusciamo a guardare sempre meno.
Ci viene in mente una frase di Paolo Cherchi Usai in The Death of Cinema (ed. it. L'ultimo spettatore, 1999), secondo cui una società che è sempre più schiava dell’incubo di una memoria visuale assoluta – di una registrazione totale degli eventi, come avviene nelle fotografie e nei video dei nostri cellulari – non ha più bisogno del cinema. Perché il cinema non è solo l’arte della persistenza dei fantasmi del passato nel presente, della loro vita al di là della vita. È anche una pratica di distruzione delle immagini (che ogni volta che vengono messe nel proiettore fanno un passo in più verso la loro scomparsa). È anche una pratica di presa di coscienza della natura effimera e fragile delle immagini, che prese nel tempo meccanico della proiezione tendono via via a scomparire: e poi, dopo un tempo variabile, a venire dimenticate. Non c’è supporto che tenga (è tutto da dimostrare che la serie di 0 e 1 del digitale garantiscano una vita più lunga del nitrato dei tempi del cinema muto). Il cinema è la continua decisione di preservare alcune immagini e non altre: di rallentare per alcune di loro il percorso verso la morte, mentre di accelerarlo per altre. È una decisione riguardo a dove andare a vedere, a dove andare a posare gli occhi. È per questo che strutturalmente il cinema ha a che fare con il desiderio: perché è l’atto con il quale si decide selettivamente che è lì che voglio andare a vedere, e non là. È in definitiva un’erotica: un atto di selezione all’interno del visivo di ciò che pensiamo che ci ri-guardi.
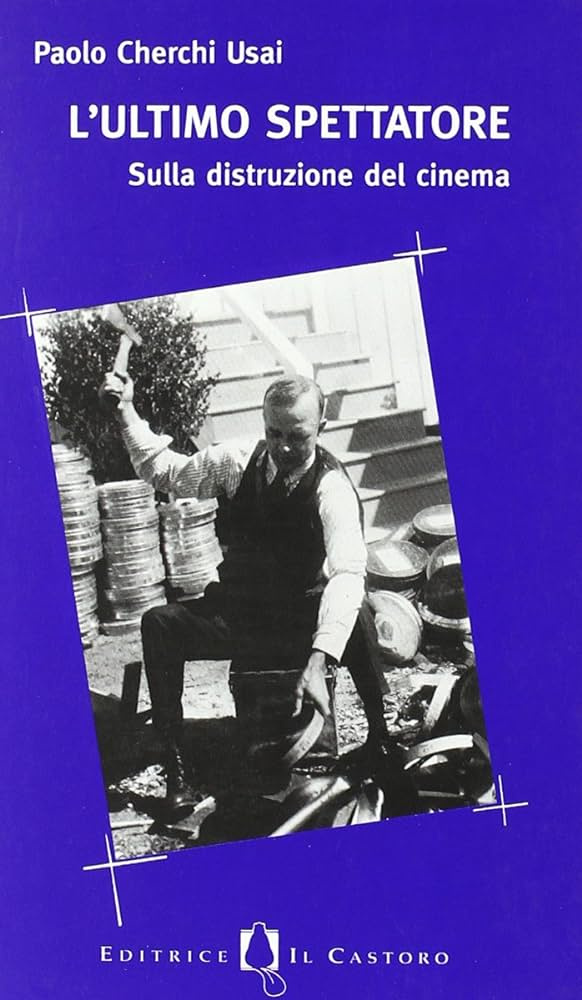
Oggi l’universo visivo del digitale ci consegna un mondo dove questa decisione è sempre meno vincolante. Diversi schermi coesistono gli uni con gli altri (si gioca al computer e nello stesso tempo si guarda un video su YouTube con l’iPad; si guarda un film, ma si controllano i social col cellulare). Che vuol dire diversi mondi, diversi canoni, diverse comunità. Si decide sempre meno in modo esclusivo e si permette che le differenze coesistano le une con le altre. Il cinema in questo senso – con la sua pratica di “selezione” desiderante, come veniva detto in uno degli inviti a spegnere i cellulari prima delle proiezioni alla Quinzaine a Cannes qualche anno fa: “uno schermo è già abbastanza!” – è necessariamente fuori da questo mondo: perché è una pratica di scelta di uno schermo a discapito degli altri. Il cinema divide: getta temporaneamente nell’oscurità gli altri schermi per concentrarsi su uno soltanto. Il digitale invece tende ad abbagliarci con tanti schermi, e troppe immagini, troppi oggetti, troppa luce. I nostri occhi non riescono più a “fare schermo” e non riescono più a “chiudersi”, come dice Carax. E costretti a non poter più scegliere, non riescono più a vedere niente.
È sullo sfondo di questa questione – una questione epocale che riguarda l’antropologia della nostra visione e con la quale nessuno che fa cinema oggi (regista, critico, programmatore, lavoratore dell’industria etc.) può evitare di confrontarsi – che in questa edizione del Festival di Cannes sapeva di testamentario The Shrouds di David Cronenberg: un film che prende quest’intuizione della visibilità assoluta del digitale e la porta alle estreme conseguenze. E si inventa una storia dove a essere portato nel visibile è uno degli ultimi punti ciechi della nostra cultura, ovvero la morte (e non deve sfuggire l’assonanza con la frase di Cherchi Usai: se il cinema è l’arte della morte delle immagini, un mondo definitivamente post-cinematografico non solo è un mondo senza tempo, ma anche senza morte).
Karsh, il protagonista del film interpretato da Vincent Cassel, è un imprenditore rimasto vedovo che inventa una app che permette di osservare in tempo reale il decomporsi all'interno delle loro bare dei defunti. Ma più ancora che nella narrazione, è nell’immagine di questo ultimo Cronenberg che risuona il visibile assoluto del digitale: iper-illuminato, piatto, e come filtrato da ogni ombra, asperità, nascondimento. Tutto è di fronte a noi. Tutto è visibile. E quando l’immagine è così accecantemente trasparente, l’unica possibile via d’uscita da questo mondo così claustrofobico dove tutto è illuminato, non può che essere la paranoia: ovvero la fantasia che qualcuno si sia nascosto e stia tirando le fila del nostro mondo anche se noi non lo vediamo. È l’ultima frontiera di resistenza in un mondo che si è così prosaicizzato da avere anche perso ogni possibile trasgressione e ogni possibile frizione. Dove anche i proverbiali corpi del cinema di Cronenberg compaiono mozzati e fatti a pezzi solo in sogno, perché nella realtà tutto è così anonimo da tramutarsi in parola (e The Shrouds è un film incredibilmente verboso, dove la parola gira in tondo su se stessa).

Ma la natura profondamente post-cinematografica del visibile contemporaneo si aggira in forma fantasmatica in quasi tutte le opere più interessanti viste quest’anno a Cannes. A partire da tutte quelle che a fronte della crisi del dispositivo cinematografico hanno deciso di rivolgersi su se stesse, con un cinema sempre più autoreferenziale, che parla sempre più di cinema, e che si fa sempre più spettatore di se stesso (a volte anche con risultati di straordinario interesse).
Va in questa direzione il già citato C’est pas moi di Leos Carax, esperimento di video-essay godardiano in stile Histoire(s) du cinèma, fatto di ricontestualizzazione di frammenti di film (sia suoi che presi dalla storia del cinema), una voce che commenta fuori campo, e la sovraimpressione di parole in digitale, che spesso compongono e scompongono frammenti di discorso e giochi di parole.
E un’operazione non molto diversa, anche se con uno stile meno teorico e più personale (alcuni hanno detto: meno godardiano e più truffautiano), l’ha fatta anche Arnaud Desplechin in Spectateurs !: un omaggio alla cinefilia dove si incrociano riferimenti alle origini e alla storia del cinema, aneddoti di spettatori di oggi, riflessioni estemporanee (molto belle quelle su Shoah di Claude Lanzmann) ma anche scene di finzione girate appositamente per il film, con a tema la sala cinematografica (e la proverbiale abitudine dei personaggi maschili di Desplechin di usare nevroticamente il cinema come scusa per evitare l’incontro con l’altro sesso).
Ma anche nel concorso di quest’anno c’erano diverse opere con una forte impostazione meta-cinematografica. A partire da uno dei film più interessanti (anche se, ahinoi, completamente ignorato dalla giuria, come spesso è accaduto a Cannes con questo regista): Caught by the Tides del regista cinese Jia Zhang-ke. Con questo film Jia decide di ri-utilizzare diversi spezzoni di alcuni suoi film del passato (in particolare Unknown Pleasures del 2002, Still Life del 2006, Il tocco del peccato del 2013 e I figli del fiume giallo del 2018), mischiandoli con degli outtakes girati lungo gli anni e con alcune scene girate in Cina durante la pandemia.
Il film tratteggia per sommi capi un mélo in cui due innamorati di una città della provincia della Cina (siamo nello Shanxi, la regione del Nord della Cina dove si svolge la maggior parte dei suoi film) si separano perché lui vuole andare a cercare fortuna emigrando in una grande città: lei in seguito lo andrà a cercare senza successo e quando si reincontreranno molti anni dopo sarà troppo tardi. Ma se questo canovaccio narrativo è così elementare da sfiorare quasi la banalità, quello che rende affascinanti i film di Jia è la dialettica che viene costruita tra i personaggi e il loro contesto storico, o se vogliamo tra il primo piano e lo sfondo. Nel primo piano vediamo le vicende quotidiane di alcuni personaggi e sullo sfondo la storia cinese degli ultimi trent’anni (oltre che l’economia e il mondo della produzione).

In questo ri-utilizzo e ri-mediazione di immagini girate da Jia negli ultimi trent’anni si intravede la maturata consapevolezza che il materiale pro-filmico dei suoi film è in realtà già un’impronta lasciata dalla modernizzazione cinese sulla pellicola: è in un certo senso testimonianza di quello che poi l’intreccio è andato a tradurre sul piano simbolico. Caught by the Tides, nell’andare a riprendere i frammenti di vecchie immagini dei primi anni Duemila o della metà degli anni Duemila, non sta solo facendo una riflessione su come lo sviluppo cinese abbia trasformato (e per certi versi devastato) il proprio ambiente circostante, ma sta anche invertendo il rapporto tra primo piano e sfondo, dove i dettagli che nei suoi film erano rimasti sullo sfondo, vengono questa volta portati al centro del quadro, invertendo i rapporti interni che componevano il fotogramma.
Se in passato i film di Jia avevano al centro una storia particolare, e il contesto storico-politico universale in secondo piano, ora è come se la nostra posizione soggettiva e il nostro sguardo fossero cambiati. Quello che ora siamo portati a guardare è la storia cinese, e soprattutto come a partire dall’ingresso della Cina del WTO, fino al progetto della diga delle Tre Gole, alle olimpiadi di Pechino e poi al mondo contemporaneo fatto di sorveglianza (e solitudine) e Intelligenza Artificiale, fosse stata tradita una certa idea di futuro, che aveva portato la generazione dei primi anni Duemila a credere a come lo sviluppo industriale cinese avrebbe portato emancipazione e ricchezza. È come se Jia con questo film ci dicesse: guardate che quello che i miei film hanno sempre fatto vedere non è la narrazione, ma la storia che era sullo sfondo. Bisognava solo occupare la posizione giusta per mettersi a guardarla.
Ma c’è molto meta-cinema ovviamente anche nel bellissimo film di Christophe Honoré Marcello Mio (uscito in sala in Italia in questi giorni): un film pieno di star del cinema francese che interpretano se stesse. La protagonista è Chiara Mastroianni, a cui all’inizio del film, su un set della regista Nicole Garcia viene chiesto di essere meno “Deneuve” (la madre Catherine) e più "Mastroianni" (il padre Marcello). Lei prende alla lettera il consiglio e inizia una sorta di ricostruzione della propria identità a partire dal padre: da quel momento lei diventerà Marcello Mastroianni. Si vestirà come lui, parlerà come lui, si comporterà come lui. Il tutto ovviamente aiutato dalla straordinaria somiglianza della figlia nei confronti del padre. Marcello mio si sviluppa quindi apparentemente sul registro di una farsa, a metà tra Pirandello e Freud, dove a essere messo a tema è il paradosso dell’identità e la dimensione performativa della propria auto-rappresentazione.

E tuttavia man mano che il film va avanti, e vediamo questa assurda pretesa di Chiara Mastroianni di andare in giro facendo finta di essere suo padre presa sempre più sul serio, che un filo di angoscia inizia ad abitare il film. Perché oltre a essere la storia di uno scherzo preso troppo sul serio, il film è anche costruito seguendo il canovaccio di diversi film di Mastroianni in un susseguirsi di citazioni che più che essere dei leggeri divertissement diventano col passare del tempo sempre più claustrofobiche. Come a dire che in un mondo fatto di cinema non ci sono soltanto strizzate d’occhio allo spettatore e riferimenti giocosi alla storia del cinema, ma anche una sorta di mondo alla Escher dove realtà e finzione finiscono per scambiarsi di posto in un teatro dell’assurdo che rischia costantemente di passare nel registro dell’incubo senza soluzione di continuità.
Ma il citazionismo meta-cinematografico si è visto anche in The Substance di Coralie Fargeat, uno dei film più divisivi e polarizzanti visti quest’anno sulla Croisette (e che ha vinto il premio come migliore Sceneggiatura), che, sulla scia di Titane di Julia Ducournau (Palma d’oro del 2021), prova a sovvertire con un detournement femminista il cinema di alcuni grandi maestri del passato (De Palma, Cronenberg, Carpenter, Peter Jackson, ma anche Society di Brian Yuzna), facendo di una riflessione sull’invecchiamento del corpo femminile (il film è una sorta di Ritratto di Dorian Gray femminile contemporaneo), un giochino inoffensivo di rimandi e citazioni. Ma film che hanno messo al centro delle più o meno esplicite riflessioni sul dispositivo cinematografico sono stati anche Oh Canada di Paul Schrader, Emilia Pérez di Jacques Audiard, oltre che Megalopolis di Francis Ford Coppola. Solo per rimanere al concorso.

Forse è per questo che alla fine la giuria presieduta da Greta Gerwig ha deciso di premiare dei film così classicamente narrativi, ancorché splendidamente fatti, come Anora di Sean Baker (di cui sentiremo parlare ancora per molto tempo) o The Seed of the Sacred Fig di Mohammad Rasoulof (che dalla sua aveva anche l’urgenza delle proteste iraniane degli ultimi anni e la fuga dal paese del regista dopo la condanna a 8 anni di reclusione per la sua opposizione al regime), in luogo invece di operazioni più teoriche e meno accessibili (ma forse anche meno riuscite, dato che navigano strutturalmente nel buio di una forma indefinita), come quelle di Jia Zhang-ke, di Coppola o di Cronenberg; o come, in altre sezioni del festival, quelle di Caroline Poggi e Jonathan Vinel nella Quinzaine des cinéastes o di Truong Minh Quy in Un Certain Regard.
Si tratta di un tentativo – cosciente o inconscio – di trovare una via oltre a questa crisi della forma cinematografica, le cui ragioni tuttavia sono così storiche e così radicate in un nuovo regime dell’immagine digitale, che ci pare di poter dire che questo interregno di profonda incertezza non sia destinato a finire tanto presto. E che continuerà a ritornare come un problema irrisolto anche nelle prossime edizioni del festival, così come in tutti quei luoghi dove si prova a riflettere sulla forma storica dell’immagine contemporanea.
Leggi anche:
Cannes 77/1. Bentornati nel deserto del reale | Pietro Bianchi
Cannes 77/2. Coppola e il crollo dell'impero | Pietro Bianchi







