Le cinque (o sei) sfide cui fare fronte / A cosa serve l'Università?
A cosa serve l’università? Nella sua semplicità, la domanda sembra perfino banale. Invece non lo è affatto: anzi, è una domanda che molti – troppi – evitano con cura di porsi, specialmente se proprio nell’università lavorano. Ciò è dovuto in parte a pigrizia, in parte a inerzia, in parte a un meccanismo più o meno consapevole di autodifesa. Scomodo è infatti mettere in discussione il proprio ruolo: specie quando ci si renda conto che, per parte loro, le istituzioni (i governi, i Parlamenti che si sono succeduti negli ultimi lustri, i vari titolari del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) a quella domanda hanno risposto in maniera precisa, e alquanto discutibile. D’altro canto, è fin troppo evidente che ostinarsi a eludere il problema mette a repentaglio il futuro: il futuro dell’intero Paese, non solo dell’università. Ma bisognerebbe aggiungere una postilla: a interessarsi di università, purtroppo, sono quasi solo gli universitari. In genere l’opinione pubblica è poco informata, malinformata, e interessata pochissimo.
A dispetto di una copertina che – lo dico con rammarico – assomiglia alla pubblicità di un collirio, Università futura. Tra democrazia e bit (Codice 2017) offre un’occasione preziosa per informarsi e ragionare. L’autore è Juan Carlos de Martin, docente di ingegneria dell’informazione al Politecnico di Torino, noto come editorialista ai lettori della «Stampa» e di «Repubblica», da tempo attivo nello studio delle ripercussioni delle nuove tecnologie in ambito giuridico, economico e sociale. Il suo obiettivo è di fornire una visione d’insieme dei problemi del sistema universitario: e quindi, assai giustamente, comincia interrogandosi sul ruolo sociale dell’università. A cosa serve, appunto, l’università? La risposta prende le mosse da un documento che meriterebbe di essere più diffuso, l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile Trasformare il mondo, varata nel settembre 2015. Ad esso de Martin attinge per individuare le cinque principali «sfide» cui l’università deve contribuire a far fronte: la sfida democratica, la sfida ambientale, la sfida tecnologica, la sfida economica. Una sesta sfida riguarda poi la declinazione italiana delle questioni globali, e su questa principalmente mi soffermerò.

Vale la pena di notare, per inciso, la differenza d’impianto rispetto a un altro istruttivo contributo di riflessione sull’università, il volume di Federico Bertoni Universitaly (Laterza 2016), che avrò occasione di richiamare anche più avanti. Bertoni, comparatista, docente all’Università di Bologna, tra i più brillanti studiosi di letteratura oggi in circolazione, imposta il discorso in chiave autobiografica, cita molti episodi particolari, alterna i registri dell’indignazione, dello sconcerto, dello scoramento, della satira: e di passaggio richiama luminosi riferimenti letterari, da Stendhal a Primo Levi, da Luigi Meneghello a Philip Roth. Pur non concordando con ogni singola affermazione, ho letto questo libro – inevitabilmente, forse – con intensa empatia. Però Universitaly propone un punto di vista più interno al mondo universitario (sintomatico il «decalogo» di atteggiamenti da opporre alla logica dominante), e quindi meno idoneo a catturare l’attenzione del pubblico extra-accademico: ammesso e non concesso, s’intende, che questo non sia obiettivo del tutto illusorio.
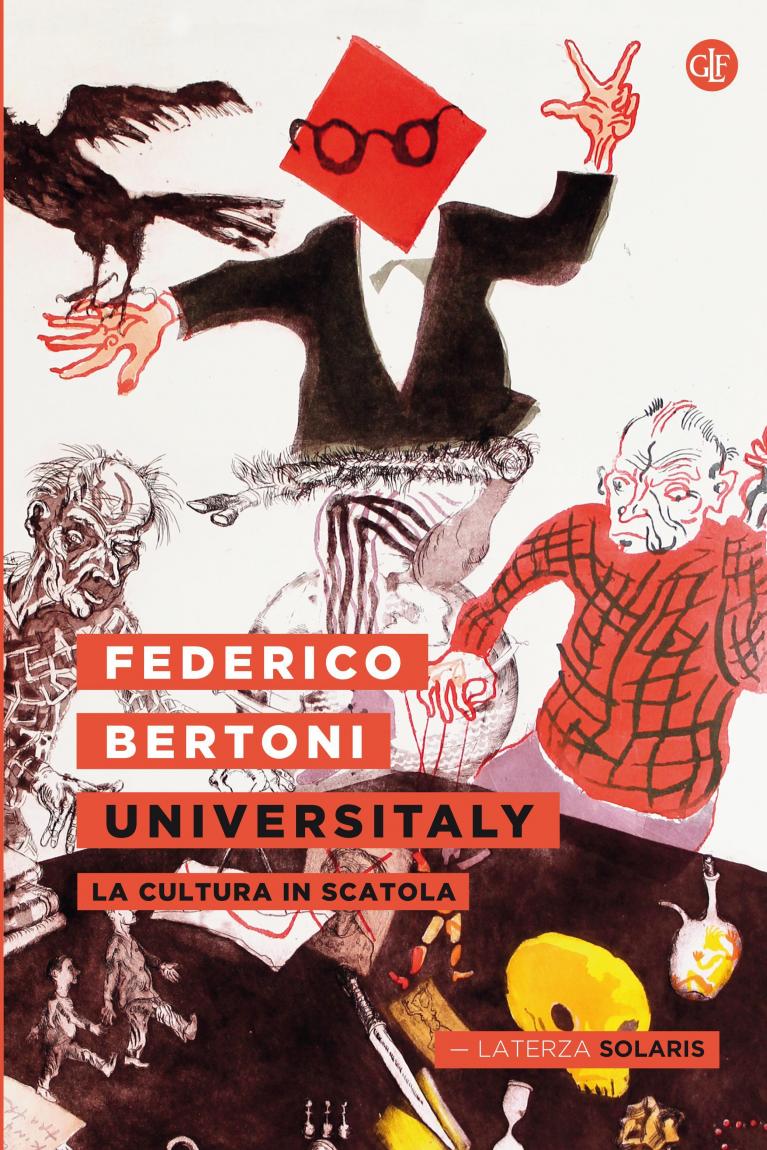
Una premessa indispensabile è la confutazione dei luoghi comuni sull’università italiana, tanto tenaci quanto infondati. Come ricorda de Martin, non è affatto vero che in Italia ci siano troppe sedi: per milione di abitanti, l’Italia ne ha 1,6, contro 2,3 del Regno Unito, 3,4 dell’Olanda, 3,9 della Germania, 8,4 della Francia, 8,8 degli USA. Non è vero che in Italia ci siano troppi professori: nel rapporto docenti/studenti l’Italia si situa al trentesimo posto fra i 34 paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. E non è nemmeno vero che le tasse universitarie siano basse: ormai in Europa ci superano solo Regno Unito e Olanda. Vero è invece – e non lo si ripeterà mai abbastanza – che il sistema universitario italiano è sotto-finanziato. Le spese operative di Harvard equivalgono a quasi metà del finanziamento ordinario dell’intera università italiana. Nel 2015 l’Italia ha investito nell’università un quarto delle risorse impegnate dalla Germania: 6,5 miliardi di euro contro 26. Sempre nel 2015, le spese operative dei Politecnici di Torino e Milano sono state rispettivamente di 208 e 422 milioni, contro 883 del Politecnico di Losanna (EPFL) e 1464 di quello di Zurigo (ETH). E converrà non dimenticarsi che a partire dal 2008, in flagrante controtendenza rispetto a quanto avveniva negli altri Paesi dell’Occidente avanzato, in Italia le politiche dei tagli ai fondi per l’università hanno ridotto del 20% il numero dei docenti e degli studenti, e praticamente dimezzato quello dei dottorandi di ricerca.
E tuttavia, con queste limitate risorse, l’università italiana ottiene risultati di tutto rispetto, cui l’informazione giornalistica di solito non rende ragione. Certo, nelle classifiche delle migliori università del mondo non si trova mai una sede italiana ai primi posti. Ma questi dati – anche senza mettere in discussione i parametri scelti per il confronto – sono ingannevoli. Primo, perché paragonano le singole università e non i sistemi universitari nel loro complesso; secondo, perché i piazzamenti assoluti dicono solo una parte della verità. L’Italia ha, storicamente, un sistema universitario più simile a quello tedesco (sedi piuttosto omogenee fra loro, sparse su tutto il territorio nazionale) che non a quello anglosassone (che privilegia le punte di diamante, Oxbridge, Ivy League, MIT, California). Ora, se si considera la qualità della ricerca, il sistema universitario italiano preso nell’insieme si colloca tra i primi 10 posti; e le 21 migliori università italiane sono fra le prime 500 al mondo, cioè nel 3% più alto del totale. Non male, considerando che, quanto a finanziamenti pubblici, l’Italia è al penultimo posto tra i paesi OCSE (di cui fanno parte, ricordo, anche Turchia, Messico, Cile e Corea del Sud).
Tutto bene, dunque? No, niente affatto. Anche se l’università italiana non merita il discredito in cui è generalmente tenuta, non naviga affatto in buone acque. Soprattutto, rileva de Martin, perché ha accettato supinamente una trasformazione che negli ultimi anni ne sta modificando (e anzi ne ha già in gran parte modificato) la natura. In buona sostanza, il ruolo dell’università è stato appiattito sugli aspetti economici. Per riprendere una formula introdotta vent’anni fa da Bill Readings in un libro a suo modo pionieristico, che anche Federico Bertoni cita a più riprese (The University in Ruins, Harvard U.P. 1996), l’università tende a porsi come consumer oriented corporation: come erogatrice di servizi, che equipara gli studenti a clienti.
Questa concezione dell’università, argomenta de Martin, è fortemente riduttiva e distorsiva. L’università non è un’azienda: è (o dovrebbe essere) un’istituzione che opera a vantaggio delle persone, dei cittadini, del sapere, della democrazia. Anche gli aspetti economici contano, senza dubbio: chi si iscrive all’università si aspetta di trarne benefici per la propria futura carriera, è giusto e inevitabile che sia così. Altra cosa è però pensare che valga la pena di studiare all’università solo nella misura in cui «conviene». Analogamente, è ovvio che l’università ha anche una missione economica; questo però non implica che la si debba concepire come un’impresa la cui efficienza viene misurata quantitativamente, in termini di produttività immediata. Si pensi ad esempio all’idea di usare i livelli di occupazione dei laureati come criterio principe di valutazione della didattica; o al finanziamento della ricerca sulla sola base di bandi competitivi, che inevitabilmente privilegiano i progetti in grado di sbandierare ricadute pratiche; o ancora, all’idea di università come detentrice e commerciante di brevetti, come «incubatrice di spinoff e di startup», in contrasto con l’ethos scientifico della condivisione del sapere; allo stesso principio, infine, della concorrenza tra le sedi (una sorta di applicazione dell’ideologia neoliberista al campo della pubblica amministrazione).
Anche in termini di contributo allo sviluppo dell’economia, l’ossessione economicista è limitativa, anzi, controproducente. La miope concezione utilitaristica che pone come obiettivo dei corsi di laurea la formazione di specifiche figure professionali non rende un buon servizio al sistema economico, perché il mondo del lavoro si evolve in fretta; gli stessi datori di lavoro non sono in grado di dire quali competenze occorreranno loro di qui a pochi anni. Meglio quindi avere una solida preparazione di base, meglio acquisire competenze trasversali, meglio maturare una capacità di apprendere spendibile nei decenni futuri in qualunque contesto, che non accumulare un pacchetto preconfezionato di apprendimenti mirati e tarati sull’oggi. Un focus eccessivo sulla formazione lavorativa produce lavoratori meno flessibili, meno creativi: quindi, in ultima analisi, anche meno produttivi. Prevedibile, ma non per questo meno pregnante, il richiamo alla massima di Montaigne cara a Edgard Morin: «Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine» (meglio una testa ben fatta che una testa ben piena).
Discorso analogo si può fare per la ricerca. Un’enfasi eccessiva sulla quantità dei «prodotti» espone al rischio – che è già realtà in alcuni ambiti scientifici – di trasformare lo strumento di misurazione di un’attività nell’obiettivo principale di quella attività («legge di Goodhart, 1975: “Quando una misura diventa un obiettivo, essa cessa di essere una buona misura”»). Il motto «pubblica o muori» (publish or perish) ha come immediato corrispettivo il cosiddetto salami slicing: il contenuto di un articolo importante può essere affettato in tre articoli brevi, che rendono (valgono) più di uno. E a quale scopo impegnarsi in progetti di lungo respiro, che richiedono anni e anni di lavoro prima che ne emergano risultati decentemente pubblicabili? Ha ragione Bertoni:«la ricerca è fatta anche di spreco, intuizioni casuali, punti morti, false piste e sentieri interrotti, e soprattutto della curiosità con cui ci si mette in viaggio senza intravvedere chiaramente la meta finale». Per questo è deleterio ridurre o azzerare i finanziamenti strutturali alla ricerca. In prospettiva, è più lungimirante sciogliere la ricerca da vincoli e pastoie, tutelare (come dice de Martin) la «ecodiversità della conoscenza», preservando anche la possibilità di trovare anche cose che non si stavano cercando.
A molti sfugge che una visione troppo utilitaristica e produttivistica non penalizza solo il sapere umanistico egli studi storico-sociali, ma anche la ricerca di base nelle scienze cosiddette«dure». Qui non resisto alla tentazione di citare un gustoso aneddoto, sia pur dalla veridicità controversa, che ha per protagonista uno dei padri dell’elettromagnetismo, Michael Faraday (sì, quello della «gabbia» che tutti abbiamo incontrato al liceo). A un ministro delle finanze che gli chiedeva quale fosse l’utilità pratica dell’elettricità (gli studi sulla materia, allora, erano ai primordi) egli avrebbe risposto: «Non so, ma penso che fra qualche anno potrete tassarla».
Detto questo, non abbiamo però ancora messo a fuoco la peculiarità di questo libro. Il pregio maggiore di Università futura non consiste in dati largamente disponibili (se solo ci si prende la briga di cercarli), né in critiche parziali, alle quali qualcosa si potrebbe comunque controbattere: ad esempio, io credo che i processi di valutazione non siano in linea di principio da respingere, sebbene la condotta pratica dell’Anvur (l’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca), sembri avvalorare un sagace adagio di Mark Twain («Se uno ha un martello in mano, ogni cosa gli sembra un chiodo»). Il merito di de Martin consiste nel porre la questione di fondo, cioè la ragion d’essere dell’università. E la sua tesi è chiara. L’università dovrebbe recuperare le proprie radici storiche: non appiattirsi sull’esistente, bensì mirare al futuro, ponendosi obiettivi di utilità sociale più alti e più ampi di quelli contabilizzabili a breve termine. Dovrebbe, in primo luogo, riscoprire l’idea di educazione come bene pubblico. La sua funzione dovrebbe essere di educare persone che saranno cittadini consapevoli e lavoratori intelligenti (non soltanto formare lavoratori con competenze monodimensionali); favorire lo sviluppo della personalità dei giovani (secondo le recenti ricerche, il cervello evolve fino a 25-26 anni); sollecitare la capacità di costruirsi una visione autonoma delle cose; coltivare l’immaginazione e il senso del possibile; valorizzare il pensiero critico, la creatività, la capacità di innovazione. In questa prospettiva, all’università compete anche un cruciale compito politico di tutela e di sviluppo della democrazia. Le democrazie sostanziali necessitano di cittadini consapevoli, che abbiano investito sulla formazione della propria identità; si giovano della diffusione delle facoltà critiche, dell’amore per il sapere, della capacità di elaborare pensieri complessi – di contro ai dogmatismi ottusi e agli scetticismi arrendevoli, atteggiamenti entrambi sui cui le ambizioni autoritarie possono facilmente far leva.
In questa luce, de Martin non teme di rivalutare il glorioso modello humboldtiano di università (le riflessioni che presiedettero nel 1810 alla fondazione dell’Università di Berlino). Un modello fondato sulla libertà accademica, sull’autogoverno dell’università, e soprattutto sull’unità indissolubile di insegnamento e ricerca (radicalmente alternativo alla vitanda distinzione tra research universities e teaching universities). Quello che invece oggi predomina è un modello aziendale, anzi, un tipo particolare di modello aziendale, gerarchico-piramidale (altri, volendo, ce ne sarebbero): simile – se non vado errato – a quello che finisce di fatto per incatenare le politiche editoriali alle trimestrali di cassa, e che di per sé manderebbe in rovina qualunque ipotesi di editoria di cultura.
Un binomio cruciale che de Martin evoca è quello fra organizzazioni utilitaristiche e organizzazioni normative. Le prime si fondano su motivazioni estrinseche, quali retribuzione, e condizioni di lavoro, e (in negativo) multe o mancate promozioni; le seconde su motivazioni intrinseche, come interesse intrinseco, condivisione di ideali, identificazione con gli obiettivi, orgoglio di contribuire a un progetto comune, e (in negativo) riprovazione o espulsione. Ebbene, non c’è dubbio che l’università dovrebbe essere, e concepirsi, come un’organizzazione normativa (l’aggettivo va inteso in senso attivo, riguarda il darsi le proprie norme, l’avere in sé le proprie regole di funzionamento); ma che, di contro, viene trattata sempre più spesso alla stregua di un’organizzazione utilitaristica, complici anche la passiva acquiescenza o la rassegnata inerzia degli addetti.
Il libro di de Martin offre molte considerazioni e molti spunti che varrebbe la pena di riprendere. Ad esempio, l’importanza della funzione (umile ma indispensabile) di preservare il sapere: e qui si potrebbero aprire riflessioni sia sul ruolo delle biblioteche e degli archivi, cartacei e non, sia sullo statuto delle humanities, che si fondano in gran parte sulla conservazione, la trasmissione, la rielaborazione di conoscenze (a fronte della pura espansione delle conoscenze, che ha caratterizzato il cambio di paradigma della rivoluzione scientifica, ma che con il tempo ha finito per alimentare non di rado una fissazione ossessiva sulle novità, vere o presunte). Oppure sul carattere strategico della disposizione degli spazi fisici all’interno dell’università, che dovrebbe cercare di favorire la possibilità di incontri fortuiti:l’espansione e la fecondazione reciproca dei vari rami del sapere passa anche attraverso i contatti personali, e quindi i casuali contatti nelle mense, nelle biblioteche, nelle sale di lettura. O ancora, sulla valorizzazione delle ricerche interdisciplinari; sul ruolo che l’università può avere nell’innalzare il livello di istruzione degli adulti; sull’utilizzo intelligente delle risorse digitali; e potremmo proseguire. Ma soprattutto, su una questione che definirei di atmosfera, cioè sulla necessità di ripartire dalla fiducia.«Un’organizzazione normativa come l’università, che vive di principi e di idee, non può operare in maniera efficiente se è basata sulla sfiducia sistematica e strutturale verso i suoi membri. L’università, come qualunque organizzazione pubblicata e privata, ha la sua percentuale di profittatori e di disonesti, che però è una netta minoranza: non possiamo basare l’intero approccio all’università pensando a loro, perché farlo significa trattare la grande maggioranza di onesti come se non lo fossero, con effetti molto seri sul morale e quindi sulla produttività».
Una considerazione conclusiva, che riguarda la specifica realtà italiana. L’Italia deve decidere – e qui il discorso si fa squisitamente politico – quale università vuole. Una possibilità è quella di tendere a adeguare il sistema universitario al livello del sistema produttivo attuale: cioè a un’economia che funziona con un contenuto di conoscenza mediamente basso, investendo poco sul capitale umano e sulla qualità del prodotto. In questo caso ha senso tagliare i dottorati di ricerca, insistere sul carattere professionalizzante delle lauree triennali, puntare a poche «eccellenze» e deprimere il resto. Un’altra possibilità è quella di incentivare l’innalzamento tecnico-scientifico dell’industria e dei servizi puntando sulla diffusione del sapere e sul potenziamento della ricerca, lasciando alla ricerca un adeguato grado di autonomia. Si tratta di scegliere. Di scegliere fra un presente immemore del passato e un futuro dalle solide radici.







