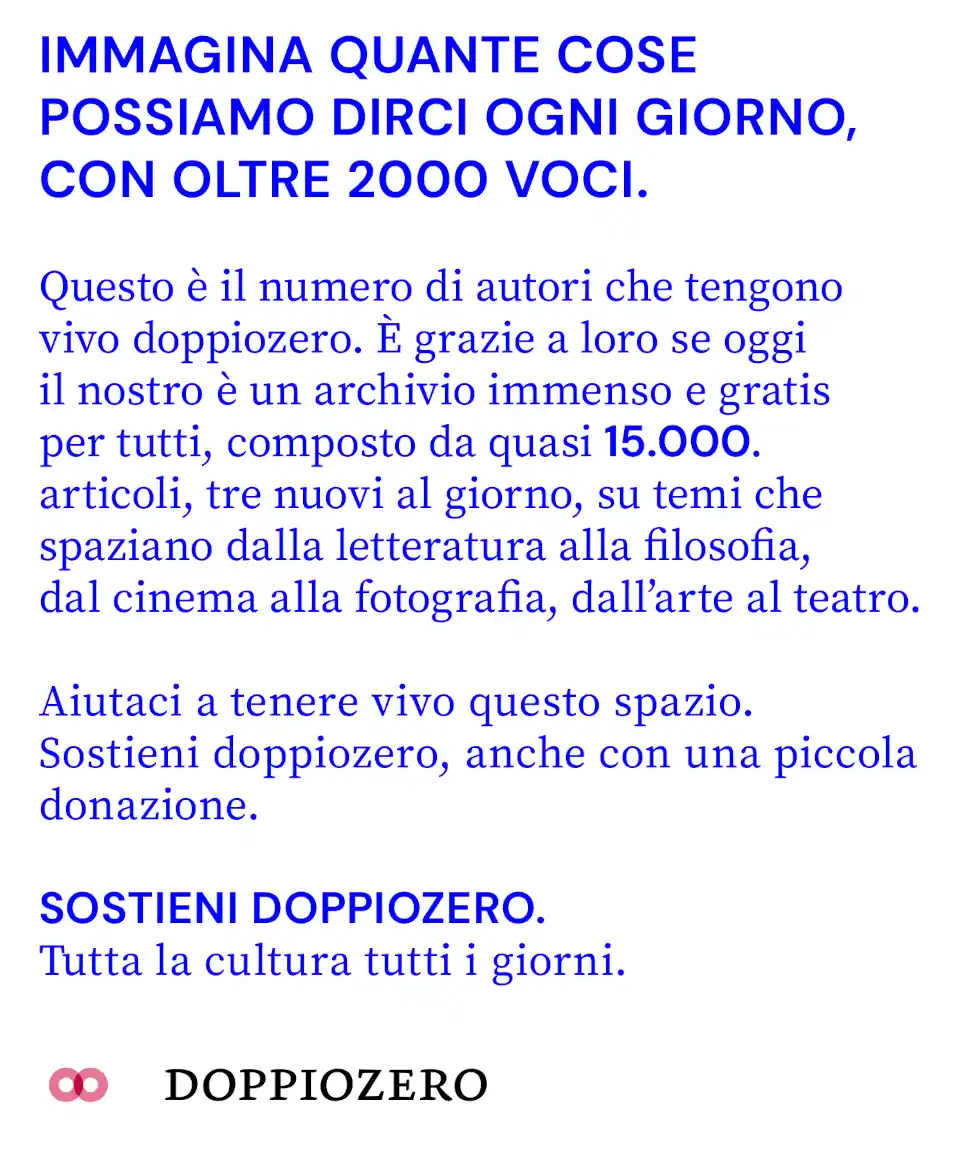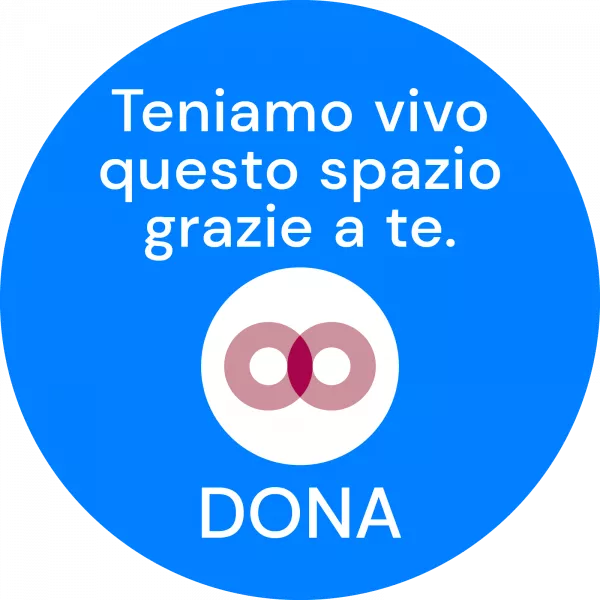Manuel Orazi, l’Io biografico e l’Io estetico
Piccola e grande forma. Alla «piccola forma» degli articoli di giornale o periodico ci accostiamo troppe volte con rapidità, persino fretta, come se alla brevità del testo e del suo tempo di pubblicazione si addica una fruizione altrettanto breve. A quelli che potremmo qui riunire sotto la formula di «scritti d’occasione» – scritti generati dalla tempistica di articoli, critiche e recensioni a libri e mostre, eventi e appuntamenti culturali, ricorrenze e necrologi – corriamo il rischio di dedicare un parallelo «ascolto d’occasione». A farci pentire del nostro sguardo spesso distratto a quelle poche pagine sopravvengono i casi in cui, a distanza di anni, gli stessi articoli o scritti dettati dalle circostanze vengano raccolti nella «grande forma» del libro. Questa diventa allora una sorta di processo, inclusa la prova del fuoco, per i brevi scritti che, accesi dal tempo altrettanto breve dell’occasione, vogliano dimostrare la propria «innocenza» affrontando senza bruciarsi con il tempo lungo che (ancora) riconosciamo al libro.
Resistenza letteraria. Responsabile di queste considerazioni è stata la lettura di Manuel Orazi, Vite stravaganti di architetti, Giometti & Antonello, Macerata 2025. Il libro, che raccoglie quarantuno «ritratti comparsi precedentemente», tra 2005 e 2022, «su libri, giornali, riviste cartacee e online», è la prova di come gli scritti d’occasione, brevi nell’estensione quanto nella durata della pubblicazione, possano sopravvivere alla nostra fruizione occasionale, temporanea, superficiale, guadagnando dignità di libro. E a mio parere, ciò accade perché nei testi ora riuniti il resoconto trascende sempre in racconto.
Sin dalla premessa, Orazi dichiara la sua «predilezione per le recensioni, ad esempio Critiche e recensioni di Walter Benjamin» o «la spassosa maestria dei racconti brevi di Robert Walser…». Questi richiami a maestri del testo breve e occasionale spiegano bene la resistenza letteraria che l’autore ha saputo imprimere ai suoi veloci ritratti, che si presentano – volendo ribadire a mia volta l’ammirazione per Robert Walser con una citazione dai suoi Ritratti di pittori, Adelphi, Milano 2011 – come «acquerelli che vanno per le spicce, dipinti per così dire con disinvoltura… e però con eloquenza».
I quarantuno ritratti di architetti e artisti e studiosi legati all’architettura si concentra sul ventesimo secolo, ma non mancano incursioni nell’indietro storico, quali «Francesco di Giorgio Martini. Macchinista»; «Giacomo Antonio Quarenghi. Neopalladiano»; «William Le Baron Jenney. Capitano»... – dove i sottotitoli in corsivo (spesso di «spassosa» arguzia) che ogni volta accompagnano il nome del personaggio sono da leggere come annunciatori dell’andamento narrativo che condurrà il testo. Vediamo degli estratti che fungano da esempio.
Acquerelli. «William Le Baron Jenney era nato in Massachusetts nel 1832 e dopo una gioventù conradiana trascorsa nei Mari del Sud aveva studiato ingegneria a Harvard e poi all’École Centrale des Arts et Manufactures di Parigi, laureandosi un anno dopo Gustave Eiffel. La sua prima prova sul campo non fu però in cantiere, ma in guerra: tornato in patria, fu arruolato nel genio pontieri… A Chicago si troverà invece a dover ricostruire la città andata in fumo e ad inventare la tipologia edilizia per eccellenza: il grattacielo…». Qui vediamo come lavorano i tocchi ad acquerello che abbozzano il ritratto. Sempre per puntuali accenni, vi si parla di origini, di esperienze di vita, di formazione culturale e professionale, e infine dello sbocco di tutto ciò nella pratica artistica, nell’opera architettonica – nel caso appena riportato, quella dell’ingegnoso ingegnere, «rude comandante grazie al quale tutta la Scuola di Chicago (Adler & Sullivan…) ha potuto apprendere l’organizzazione di un cantiere come quello di un grattacielo».
Passiamo a una figura nota più vicina a noi, affidandoci anche qui a succinte citazioni. «Carlo Mollino. Erotomane. Eccentrico, imprevedibile, erotomane. Carlo Mollino ce le aveva proprio tutte per creare imbarazzo, se non scandalo, nell’austera Torino del secolo scorso… Pur essendo figlio di un serio ingegnere… non era una personalità razionale o razionalista come i suoi contemporanei. Era al contrario un occultista, esperto di radioestesia e conoscitore della civiltà egizia… Di certo amava il tempo libero tanto quanto la sua professione, al punto che agli amici – come l’artista Carol Rama – regalava “draghi da passeggio” in carta pieghettata e decorati a mano… Le forme femminili, curve simili a quelle delle sciate, sono d’ispirazione anche al suo design: la poltrona reclinabile Gilda del 1947 si rifà al fisico vellutato di Rita Ayworth, protagonista dell’omonimo film dell’anno prima…». Nel caso di Mollino, «torinesissimo, al punto che si vantava di non aver mai dormito una sola notte a Milano», l’eccentrico caratteriale e culturale dell’architetto viene abbozzato in modo da indirizzare la stessa interpretazione di alcune sue opere.
Una vita davvero «stravagante», migratoria, errante, è invece quella che cadenza il ritratto del famoso architetto «Eric Mendelsohn. Orientale», che le sciagure politiche del Novecento portarono a «operare e vivere» tra Germania, Inghilterra, Palestina e Stati Unititi. Qui – come leggiamo nell’affettuosa pagina conclusiva del ritratto – «dal 1941 divenne l’architetto ufficiale della comunità ebraica americana, iniziando a progettare quasi esclusivamente complessi religiosi con mano sempre meno felice. Morì nel 1953 a San Francisco… assalito da uno spleen che dev’essere stato affine a quello di un’altra esule antinazista, Marlene Dietrich: tra le sue canzoni trasmesse alla radio c’era allora anche uno struggente vecchio adagio tedesco, tradotto in “I may never go home anymore”. A Mendelsohn non restò che chiedere all’amata moglie violoncellista Luise, lui che era nato lo stesso giorno di Bach, di spargere le proprie ceneri nel “mare dell’eterno errare”: in fin dei conti la sua vera e unica patria».
Approfitto di questo ritratto per aggiungervi un aneddoto che mi è caro. Prima di intraprendere la sua vita e carriera errante, Eric Mendelsohn presenziava a Berlino ai concerti domestici in casa Salomon cui interveniva anche la moglie violoncellista Luise. In tali occasioni, tra gli uditori c’era la ragazzina Charlotte Salomon, artista da me venerata, che nei due anni precedenti la straziante morte ad Auschwitz nell’ottobre 1943, profuga nel Sud della Francia, dipingerà il «libro» capolavoro Vita? o Teatro? (Castelvecchi ne ha pubblicato nel 2019 la versione integrale), dove compaiono anche tempere che rievocano i «piccoli concerti» tenuti nell’appartamento berlinese al n. 15 di Wielandstraße.
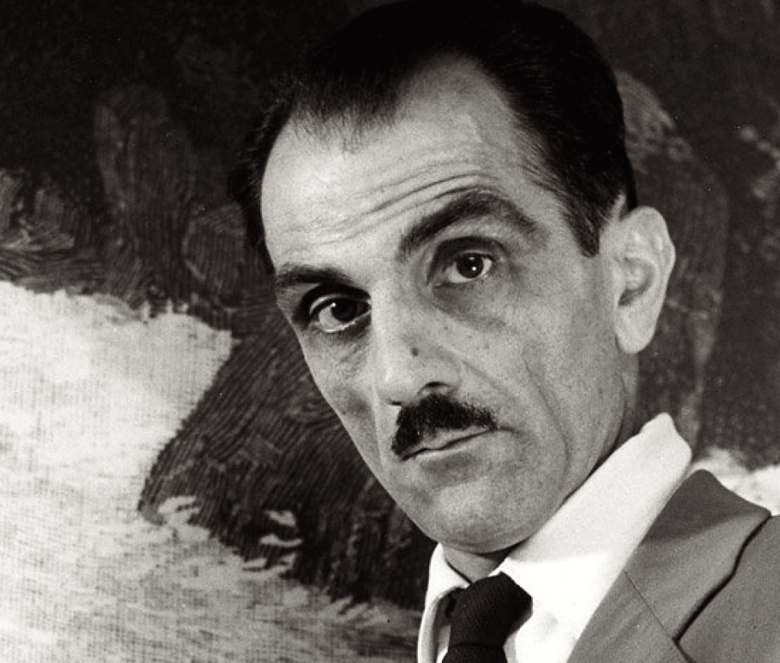
Io biografico e Io estetico. Adolf Loos. Snob; Philip Johnson. Gagà; Reynar Bahnam. Irsuto; Yona Friedman. Seminatore; Daniele Calabi. Architetto dei due mondi; Riccardo Dalisi. Bricoleur; Cristiano Toraldo di Francia e Adolfo Natalini. Vite parallele; Jane Jacobs. Attivista; Denise Scott Brown. Pop-femminista… In tutti i ritratti, dedicati all’élite architettonica ma non solo a quella consolidata, secondo andamenti e dosaggi diversi, a emergere dal racconto sono di continuo i «complicati rapporti esistenti tra il soggetto estetico di opere… e la persona empirica dell’autore» – per usare le parole contenute nelle pagine di Opera e biografia del magistrale musicologo e storico della musica Carl Dahlhaus (in Beethoven e il suo tempo, EDT, Torino 1990). A sua volta storico dell’architettura, Orazi sa come evitare le trappole del «rispecchiamento organico» tra biografia e opere, e tuttavia sa anche – sempre in sintonia con Dahlhaus – che «oggetto della biografia non è solo la persona empirica». Per questo le sue Vite stravaganti di architetti, con la discrezione necessaria richiesta da un tale campo minato, incorporano di volta in volta nella «persona empirica» anche taluni caratteri della «biografia interiore», l’unica infine titolata a gettare dei ponti tra Io biografico e Io estetico, tra storia degli architetti e storia dell’architettura, senza cadere nel mito del «rispecchiamento organico» ma neppure sopprimendo il biografismo in quanto «mito nemico della storia» – per usare una formula di Manfredo Tafuri ripresa da Orazi nel Prologo autobiografico.
I «complicati rapporti» tra Io biografico e Io estetico ho potuto naturalmente coglierli meglio nei ritratti di coloro che ho conosciuto e frequentato. È il caso dell’amico «Jean-Louis Cohen. Ebreo errante», la cui morte «è stata un fulmine a ciel sereno. Una banale puntura di vespa ha messo fine alla vita di uno dei massimi professori di storia dell’architettura e della città». Ebreo errante come pochi, Cohen «era poliglotta, anche grazie al fatto che il padre Francis, ex partigiano e direttore della “Nouvelle Critique” del Partito comunista francese, lo mandò fin da ragazzo in Unione Sovietica a imparare le lingue slave nei campi estivi», tanto che da allora i suoi studi si incentreranno spesso sulle migrazioni della cultura architettonica, come confermano anche quelli più recenti sui «rapporti intertestuali fra le città» – studi, anche qui, condotti da un Io estetico in cui riecheggiano origini, esperienze empiriche, sviluppi formativi e indirizzi culturali dell’Io biografico.
Mi piace concludere questa piccola selezione tra i quarantuno ritratti del libro con «Pierluigi Cerri. Grafico». Ricordo bene quanto mi disse, fingendo un’impassibile serietà, a una riunione di redazione della rivista «Casabella» della stagione gregottiana per un aggiornamento della grafica, di cui era responsabile: Mi disse: «Se vuoi, allungo il titolo in Rivista internazionale di architettura… e filosofia. Ma dovrò diminuire il corpo dei caratteri per farlo rientrare in copertina». Di Cerri, Orazi ci ricorda essere «nato nell’Isola di San Giulio sul lago d’Orta, in provincia di Novara: nello stesso comune hanno avuto i primi ricordi d’infanzia anche Gregotti, Leonardo Benevolo e Italo Rota, un fucina dunque per la disciplina». A seguire ci vengono segnalate le sue frequentazioni con «artisti scapestrati» del noto Bar Jamaica a Milano, che Cerri, campione di ironia algida, definiva ritrovo di un «esistenzialismo in ciabatte»; ma subito dopo viene sottolineato che fu assistente di Umberto Eco al serissimo corso di Semiotica dell’architettura, fatto che spiega come la sua intelligenza sia stata presto notata dal famoso semiologo intellettuale e scrittore: l’intelligenza di un architetto designer e grafico che negli anni a venire avrebbe vinto tre Compassi d’Oro grazie alla sua maestria «insofferente al postmoderno, che liquidava come una pulsione “dal rizoma al perizoma”».
Opere bio. Lo stesso sestante della «biografia interiore» che indirizza le Vite stravaganti di architetti lo ritroviamo, in modo più approfondito, nella produzione storiografica vera e propria di Orazi, come nel recente saggio Gio Ponti, un chierico che non ha tradito, in Manfredo di Robilant e Manuel Orazi (a cura di), Officina Gio Ponti, Quodlibet, Macerata 2023. Anche qui il racconto viene affrancato dalla «tirannia dell’opera» che solitamente governa nella storiografia disciplinare. L’opera non scompare, è ovvio: piuttosto, viene rivisitata, riletta anche nella trasmutazione che ha subito via via nella modernità, mondo nel quale – come Orazi spiega citando gentilmente nel libro dei ritratti alcune mie considerazioni – «il laboratorio delle vite, anche nelle sue zone d’ombra private, va avanzando sempre più crediti nei confronti delle opere finali».
Immagino come avrebbe potuto commentare questa revisione del concetto di opera Pierluigi Cerri con uno dei suoi motti di spirito: «Anche le opere sono diventate bio».