Speciale
Dal Sahara Occidentale o di un gesto inaudito
Chi un giorno si trovasse a scrivere una storia delle rivolte, non potrà passare sotto silenzio un fatto sorprendente occorso nell’anno 2010. Nell’ottobre di quell’anno, a ondate successive, la popolazione sahrawi di El Ayun – una città di quasi 200.000 abitanti situata nel Sahara Occidentale e occupata illegalmente dal Marocco, come lo sono tutti i Territori sahrawi – lascia le sue case per trasferirsi nel deserto, in un luogo chiamato Gdeim Izik. Vanno ad abitare in un accampamento approntato per l’occasione. Dalle poche centinaia dei primi giorni, nel giro di poche settimane le tende diventano diverse migliaia.
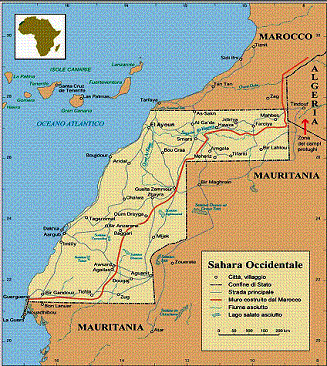
Ci sono rivolte che nascono così, con uno sparuto gruppo di tende piantate nel deserto. Del resto una rivolta ha forse luogo proprio quand’è in grado di inventare se stessa, i suoi mezzi, i suoi spazi. Raramente, però, si è assistito a un gesto così sorprendente come quello dei sahrawi a Gdeim Izik. Si sarà trattato solo di questo, dunque: di lasciare le case per andare nel deserto. Qui la rivolta è tutta contenuta in questo gesto e nella sua precisione magistrale. Un gesto così è già di per sé una dichiarazione: la potenza del suo messaggio non sta nella presa di una città, nell’occupazione delle sue strade e piazze, ma al contrario nell’abbandono della città.

Gdeim Izik Camp, Photo Antonio Velazquez
Disertando la città – volendola rendere letteralmente deserta – in fondo i sahrawi non fanno che rendere manifesta la conseguenza principale dell’occupazione illegale delle loro capitale: l’occupazione rende inabitabile le città e i territori che violenta, rende insopportabili le vite di chi è mantenuto al suo interno, come di chi vi è espulso nell’esilio. La sollevazione popolare denuncia chiaramente come l’occupazione abbia reso invivibili i suoi luoghi. Il suo gesto restituisce alla lettera – e così alla leggibilità – tutto il carattere insopportabile di un’occupazione, altrimenti così difficile da vedere, fatta com’è di soprusi quotidiani e di quotidiani rifiuti, di privazioni imposte, spesso inapparenti e celate dalla censura, di prepotenze e di maltrattamenti. E come farlo, come rendere visibile tutto questo da parte di chi non ha altri mezzi, se non abbandonando le proprie case, i luoghi degli affetti e dell’intimità, del commercio e delle relazioni?
Che il gesto avesse una potenza politica e simbolica inaudita l’ha capito sin da subito anche quel regno del Marocco che gestisce l’occupazione illegale da più di quarant’anni, e con essa torture, prigioni segrete, fosse comuni, colossali muri che attraversano il deserto. Le ingenti forze militari e la terribile polizia segreta messe in campo per fronteggiare una protesta di per sé inerme era una dichiarazione di paura e di sconfitta del potere occupante di fronte alla verità di quella richiesta di giustizia che veniva da donne e uomini di tutte le generazioni. Una richiesta tanto più pressante e più luminosa quanto più era in grado di far valere sul terreno un’istanza di democrazia che le abituali condizioni delle vite sotto l’occupazione, sia dentro che fuori i territori occupati, si industriano altrimenti a negare. In questo senso il gesto di abbandono dei centri abitati sottrae il confronto politico al luogo in cui esso è nato, la città. Un movimento di questo tipo appare qui però, allo stesso tempo, come un gesto di memoria nei confronti di tutti quei sahrawi che alle loro case sono stati costretti a rinunciare, nell’esilio o nella vita dei campi profughi in Algeria.

Gdeim Izik è stata così innanzitutto un’occasione di continuare a lottare contro lo stato di terrore a cui è sottoposta la popolazione civile. Una rivolta così è però un’invenzione tanto più potente quanto più necessaria per uscire dalle modalità consolidate di opposizione al potere, per inventare nuove pratiche di resistenza. Si è trattato là non solo di un gesto contro gli occupanti, ma dell’invenzione di un’altra politica, fatta di relazioni di vicinato, per mezzo di uno spostamento semplice ma potente da un punto di vista simbolico. Si è trattato dunque di una sperimentazione coraggiosa rispetto alla miseria simbolica alla quale l’occupazione vorrebbe ridurre le loro vite.

Incorrerebbe tuttavia in un fatale fraintendimento chi riducesse questa rivolta popolare a un gesto puramente simbolico, di natura comunicativa. Alla rivolta di Gdeim Izik sono bastate delle tende e dei corpi in movimento, dei corpi presi dall’esodo a cui l’occupazione li costringe. Ma né queste tende né questi corpi sono solo un segno. Sono piuttosto qualcosa di molto di più e di molto diverso: essi disegnano una pratica, disegnano lo spazio politico come un insieme di pratiche che restano sempre da inventare nelle condizioni date. In questo caso, si è trattato di condurre la quotidianità di uomini e donne in altri luoghi. Si è trattato di un dislocamento che non è solo spaziale, ma è piuttosto un differimento in cui la distinzione stessa di spazio pubblico e spazio privato viene rimessa in gioco. Spostamenti di questo tipo portano con sé cambiamenti sottili, nello scorrere del tempo sotto la protezione delle forze occupanti.

Per impercettibile che sia, uno spostamento così cambia tutto: gli stessi gesti, condotti fuori città, paiono parlare ora un’altra lingua, una lingua che per il solo fatto di essere non cessa di mettere in questione i rapporti di forza esistenti e di interpellare la nostra attenzione sulla sua invenzione. Come infatti spesso accade nelle pratiche sahrawi di opposizione al regime marocchino, i gesti non sono qui né fine a se stessi, né finalizzati al raggiungimento di un obiettivo immediato. Essi piuttosto si rivolgono all’attenzione altrui, si appellano a una comune volontà di giustizia, ne domandano la partecipazione.

Saharawi demonstration 2010, Photo Antonio Velazquez
Così in seguito la rivolta pacifica, soffocata dall’intervento brutale delle forze di sicurezza marocchine che l’8 novembre smantellava il campo, ha costituito l’origine di altre rivolte che si sono sviluppate nelle strade delle principali città sahrawi e poi in tutto il mondo arabo. È stato per primo Noam Chomsky a proporre la tesi – per lo più ignorata dai giornali europei, così amici del Marocco, presunta barriera “democratica” contro l’avanzata di Al Qaeda nei territori del Maghreb – che all’origine di quella stagione che abbiamo imparato a chiamare “Primavera araba” stia proprio questa singolare invenzione politica che ha preso forma nei Territori sahrawi.

Del resto, che si sia trattato di raccogliere le fotografie sui corpi dei soldati marocchini, morti o prigionieri, perché qualcuno ne custodisse la memoria (e se non era lo stato che li mandava a morire nel deserto, chi se non i loro “nemici” poteva occuparsene?) o di mandare le fotografie dei propri corpi feriti, prese con i cellulari e mandate oltre la ferrea cortina che la monarchia marocchina ha costruito intorno a loro, i sahrawi hanno saputo spesso inventare forme inedite e sorprendenti con cui rispondere a un'aggressione i cui mezzi a disposizione sono di gran lunga superiori, ma che non può trovare la sua legittimazione se non nel permanere di un’ingiustizia.







