Un saggio di Peppino Ortoleva / In un mare di viltà
Esiste una zona d’ombra dove lo sguardo raramente si arrischia, anche per non fare strani incontri. Si tratta di una regione protetta da una certa discrezione, perché non si guarda volentieri in direzione della viltà. Tutt’al più la si giudica come una debolezza di carattere oppure se ne fa uno scivolone, tanto rovinoso quanto occasionale. Ma più in generale se ne tace.
La viltà permane come una sorta di resto rispetto all’immagine dell’umanità a cui più spesso e volentieri tendiamo a dare credito. Si tratta di un resto non interrogato, di un avanzo, negletto e possibilmente dimenticato, di quelle che vengono pilatescamente definite le “pagine vergognose” della nostra storia personale e del genere umano. Notoriamente i resti sono difficili da vedere, occorre allenare la vista a guardare tra gli interstizi delle grandi questioni.
Uno come Balzac l’aveva magistralmente intuito: i moralisti si occupano sempre di quegli orrori che – “belli grossi e ben visibili” – attirano la loro attenzione e sono facili da mettere a fuoco. Guardando alla società, si dedicano alla figura dei carnivori, ma “trascurano i rettili”. Sono, cioè, attirati dal carattere vistoso delle grandi mostruosità, che mai mancano, ma cadono nell’errore grossolano di trascurare i dettagli inapparenti, le sfumature striscianti, dentro le quali la viltà spesso si annida. Imparare l’arte delle sfumature, dei dettagli, delle tracce, questo occorrerebbe fare per vedere nel fondo oscuro della propria epoca. (Insegnare nella scuola come all’università ad amare le sfumature, a distinguere e a osservare il mondo nel dettaglio in cui si fa, sarebbe un primo, semplice modo per prepararsi alla sfida di una viltà che non è più eccezione ma diventa comodità diffusa. Significherebbe riuscire a ragionare sui tanti modi possibili per sottrarsi alla viltà, e di inventare nuovi modi di resistenza.)
Occorre una particolare attenzione per snidare la vigliaccheria. Se è difficile da vedere, è perché mantiene un tratto ondivago: emerge per un istante, sia pure dotata dell’evidenza bruciante che solo le sconfitte e le delusioni sanno avere, per poi rituffarsi in profondità ignote al nostro sguardo. La sua è una realtà indubbia, ma insieme dai confini incerti, difficile da inquadrare. Segue una linea tratteggiata e sinuosa: compare senza farsi acciuffare, è evidente senza smettere per questo di essere inafferrabile. Del resto la viltà è sempre rappresentata nell’atto di ripiegare, di fuggire a una situazione giudicata troppo rischiosa. Così ogni sua istantanea ha qualcosa di mosso che rende difficile vederne i contorni. Però forse ha anche qualcosa di quell’Abgrund, di quell’abisso che per molti pensatori occidentali è sempre stato il tratto costitutivo di quanto definiamo realtà. Non solo è una realtà abissale e abominevole, è anche qualcosa come una caduta rovinosa: non solo si precipita nel suo abisso, ma siamo in fondo sempre sull’orlo del suo baratro. In questo consiste il tracollo di una viltà che non è solo personale, di chi se ne macchia, ma un po’ di tutti, nella misura in cui mina il sentimento di una comune appartenenza all’umanità, qualsiasi cosa questa sia.
Così una definizione di viltà un po’ più sostanziale di quella che abitualmente si trova sui dizionari è resa difficile proprio dal fatto che la viltà appare come un venir meno ai principi o ai valori condivisi, è un sottrarsi agli impegni assunti. È un meno che tuttavia scava una voragine dentro le relazioni umane, rendendo fragile la fiducia che avevamo affidato loro. Come si cerca qualcosa come un resto, che non è più, ma che al tempo stesso è ancora? Come si cerca una cosa che è solo un venir meno? Qualcosa che è meno – e insieme più – di una cosa?
Ma forse la domanda più giusta è: non è l’umano quel vivente la cui verità gli si sottrae, che, cioè, è esperita per lo più nel venir meno, nella sottrazione? Forse è proprio qui che andrebbe ricercata l’origine della viltà nell’uomo, in qualcosa di essenziale all’umanità in quanto tale, alla sua costituzione ontologica, al di qua di ogni spiegazione psicologica.
Si arrischia ora in questa incerta direzione il libro dello storico Peppino Ortoleva, Sulla viltà. Anatomia e storia di un male comune (Einaudi), osando accostarsi a questo tema. Se la filosofia ci ha dato riflessioni preziose su tante “passioni tristi” in cui l’umanità è solita precipitare – dalla chiacchiera alla vergogna, dal tradimento alla paura, dall’invidia alla stessa stupidità – pare tuttavia che abbia quasi temuto di avvicinarsi alla viltà. Quasi che il disprezzo e la riprovazione di cui è fatta oggetto potessero arrivare a toccarla. Lo stesso Aristotele, quando ne tratta, è però più interessato a delineare la figura del coraggioso, posto nel giusto mezzo tra gli eccessi del vile e quelli del temerario, che non ad avventurarsi nella disamina dei casi di vigliaccheria.
La domanda che attraversa il libro – e rispetto alla quale proverò un libero attraversamento – è, in fondo, quella di pensare l’umanità insieme a quanto ne mina l’aspirazione a una dignità. È, potremmo dire, la contraddizione costitutiva dell’umano che come tale non è mai messo in questione. Ma forse l’esperienza della viltà è crudele proprio perché ferisce un’incrollabile credenza nell’umanità, cioè colpisce non solo la situazione singolare che ci troviamo a vivere, ma anche l’universale credenza nell’umanità.
Più utile pare insistere sulla connessione tra questa zona d’ombra e l’esistenza. Ovvero insistere sul fatto che in quella macchia cieca che è la viltà incontriamo la nostra stessa contraddizione costitutiva, su cui ogni trama d’esistenza si intreccia. È inutile opporre il coraggio a questa regione dai bordi incerti, che si restringono e si dilatano. Potremmo anzi dire che, se questa sua zona incerta si colloca da qualche parte, dovrà essere proprio all’interno del coraggio, non solo come un suo cedimento, ma come una sua possibilità immanente. Viltà e coraggio non sono semplicemente contrari, ma l’una rappresenta l’eventuale inclinazione dell’altro e quest’ultimo costituisce la possibilità stessa di limitare una viltà che altrimenti si espanderebbe sotto la pressione sociale o a causa della sola considerazione del proprio tornaconto, anche violando la propria dignità.
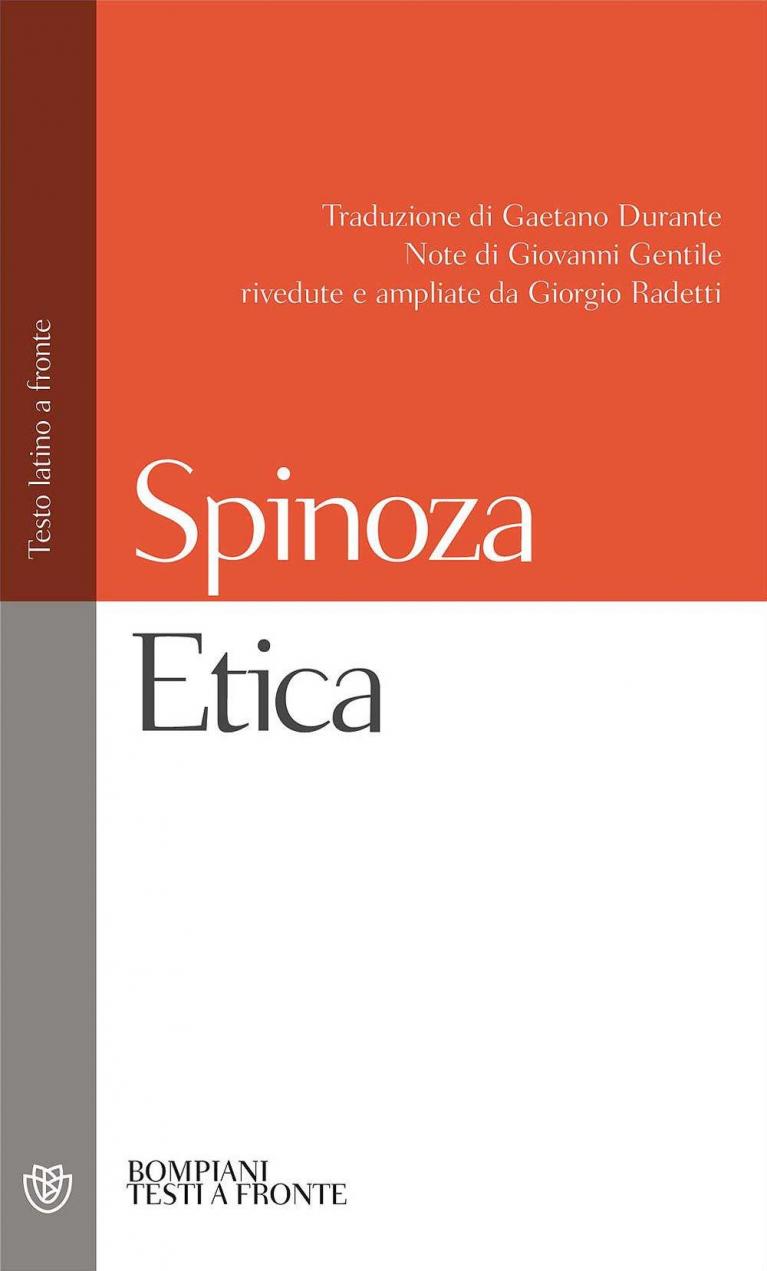
Al di là di tutte le spiegazioni che se ne possono dare – la paura in primis e poi la pigrizia, la debolezza, le piccole astuzie… – nessuna sequenza psicologistica arriverà a scandagliare i reali motivi dell’azione vile. Soprattutto il ricorso alla paura rischia di giustificare la viltà e forse anche ci riesce, rendendone momentaneo e puntuale l’apparire. La questione, però, non è tanto quella del cedimento contingente e passeggero, quanto quella del cronicizzarsi di atteggiamenti improntati alla viltà. Questa linea ha nello Iago di Shakespeare uno dei suoi massimi rappresentanti, ma arriva alla sua massima espressione in quel terrore architettato dai totalitarismi del Novecento, ma ereditato anche dal mondo successivo. Dunque, se è vero che la nostra cultura ha in un atto di vigliaccheria uno dei suoi momenti topici – Pietro che rinnega Gesù – è però soprattutto sul divenire sistematico della vigliaccheria sotto la burocratizzazione del mondo totalitario che dobbiamo concentrarci.
Ovviamente è sin troppo facile condannare la viltà e, magari, far passare la sua condanna per coraggio o buona coscienza. Questa condanna – riprovazione o giudizio – non ci porterebbe per nulla avanti nella comprensione archeologica dei suoi meccanismi, che sono poi i nostri. Né si tratta di cavarsela con un elogio del coraggio. La viltà, stigmatizzata ma ovunque diffusa, indica piuttosto un’oscillazione – questa sì propriamente umana – tra dichiarazioni di massima e comportamenti eticamente opposti. In qualche modo unendo sempre il dramma e la farsa, il ridicolo e la tragedia, la viltà sta a significare una condizione che è perennemente in bilico tra le determinazioni differenti e opposte di uno stesso comportamento. Può essere affare di un momento, un cedimento momentaneo, o può diventare un’abitudine, un modo di vivere, neppure più avvertito come tale, ma mascherato da prudenza, razionalità, etc.
È singolare come la retorica fascista abbia potuto essere infarcita di richiami al coraggio come virtù virile e di fatto galleggiare dentro un mare di viltà. Abbia saputo, cioè, nascondere la tendenza alla vigliaccheria di massa dei regimi autoritari dentro una facciata di eroismi pubblicitari. Si sbandiera lo spirito del sacrificio, ma nascosta sotto questa ostentazione c’è la codardia del disprezzo dell’altro, specie quando questo altro è in una posizione di fragilità, di cui si approfitta. Questo doppio atteggiamento di viltà agisce da un lato come un’anestesia, d’altro lato funge da chiave per il riconoscimento sociale. Cancellando sotto l’ossessivo richiamo all’ordine l’esistenza stessa di altre possibilità di vita, conduce a un esasperante conformismo. Così, come Spinoza aveva lucidamente colto nella sua Etica, la vigliaccheria è sempre relativa a ciò che è socialmente approvato e a ciò che non lo è. Le scelte “dei nostri simili” forniscono la misura del comportamento.
Ragionando in maniera storicamente diacronica, potremmo allora dire che tutto questo non è che un esempio di quella che Maupassant avrebbe bollato come “viltà borghese”: lo sfruttamento contro i soggetti più deboli di una posizione dominante, incapace di vedere al di là dei propri pregiudizi e dei propri ristretti interessi, indifferente alla possibilità di staccarsi dalle convenzioni e dagli stereotipi. Essa lavora, come sappiamo, per la propria estinzione. Che oggi è diventata l’estinzione del genere umano sul pianeta.
Se il potere è in primis relazione, rete sociale di rapporti strumentalizzata per il raggiungimento di determinati obiettivi, la viltà può effettivamente diventare il collante di una società, in cui il dominio si basa sulla paura. Dentro un’organizzazione che tecnicamente struttura la vigliaccheria, quest’ultima può essere la migliore alleata delle parole d’ordine “autorità e controllo”. Diventa il luogo d’elezione del conformismo. Facendo della paura il modo stesso del dominio (come racconta Charlotte Beradt nella sua raccolta di sogni del Terzo Reich, di cui hanno parlato su doppiozero Matteo Meschiari e Luigi Zoja), si assicura al potere una gestione delle vite attraverso lo svilimento depressivo della capacità di pensare e di agire altrimenti. L’adattamento soffocante alla massa sfrutta il senso della propria fragilità individuale, che diventa vero e proprio terrore, e conduce alla rinuncia alla libertà, per non affrontare conseguenze peggiori. Il convincimento del totalitarismo trova in questa dinamica una delle sue colonne portanti. È forse questa che Ortoleva chiama “viltà allo stato puro”: quella che si sceglie per evitare conseguenze di qualsiasi tipo, evitando tutto, incluso il vivere stesso. Evitando soprattutto di venire disprezzati perché non consoni a una posizione gregaria diffusa, come capita oggi per esempio negli scambi in rete. Una condizione di viltà diffusa di questo tipo diventa non più questione individuale ma habitus di massa. Diventa, si direbbe, condizione normale del vivente, cioè normalizzazione rispetto alle differenze che ciascun vivente porta con sé.
Leggendo il libro, penso ai militari cileni intervistati da Moretti in Santiago, Italia, al loro accampare giustificazioni pretestuose del loro agire contro la popolazione civile che aveva sostenuto Allende. Si difendono come già avevano fatto un Eichmann o altri gerarchi nazisti davanti ai tribunali che li giudicavano: si erano limitati a eseguire degli ordini, dunque non erano responsabili dei crimini di cui li si accusava. Questa difesa è espressione di questa viltà giunta a sistema, ma come ha mostrato anche Fritz Lang nel suo primo film realizzato in America, Furia (Fury, 1936), nessun paese né nessuna cultura possono ritenersi esentatati da questo rischio di precipitare nella vigliaccheria che sorregge il meccanismo della giustizia sommaria e dell’esclusione sociale.
Al di là delle distinzioni storiche, importantissime ma che rischiano sempre di non cogliere quanto c’è di decisivo, si tratta forse di cogliere quella che con John Dewey il libro chiama “la malvagità delle persone perbene”. Ascoltando l’eco che in me si crea da questa semplicissima formula, verrebbe da dire che per sottrarsi alla vigliaccheria non basta più la sola onestà. È come questa fosse una condizione eticamente necessaria, ma non più auto-sufficiente, a meno di non cadere nella spirale narcisistica dell’auto-compiacimento. (Mi sembra che sia una condizione analoga al fatto che, per non fare che un semplice esempio, politicamente indignarsi.) È come se l’onestà non facesse più sufficiente tenuta rispetto alle pressioni colossali e mostruose a cui siamo sottoposti, all’erosione di ogni dignità prodotta da quella che, prima di precipitare nell’abisso del gulag stalinisti, Mandel’štam avrebbe chiamato l’epoca degli assassini. Al potere corruttivo di una certa politica avvelenata. All’immensità delle sfide che ci attendono sin da ora rispetto all’avvenire del pianeta.







