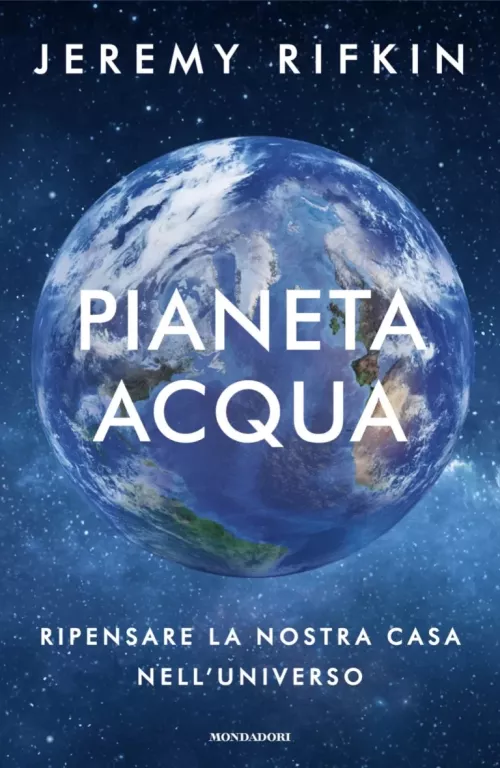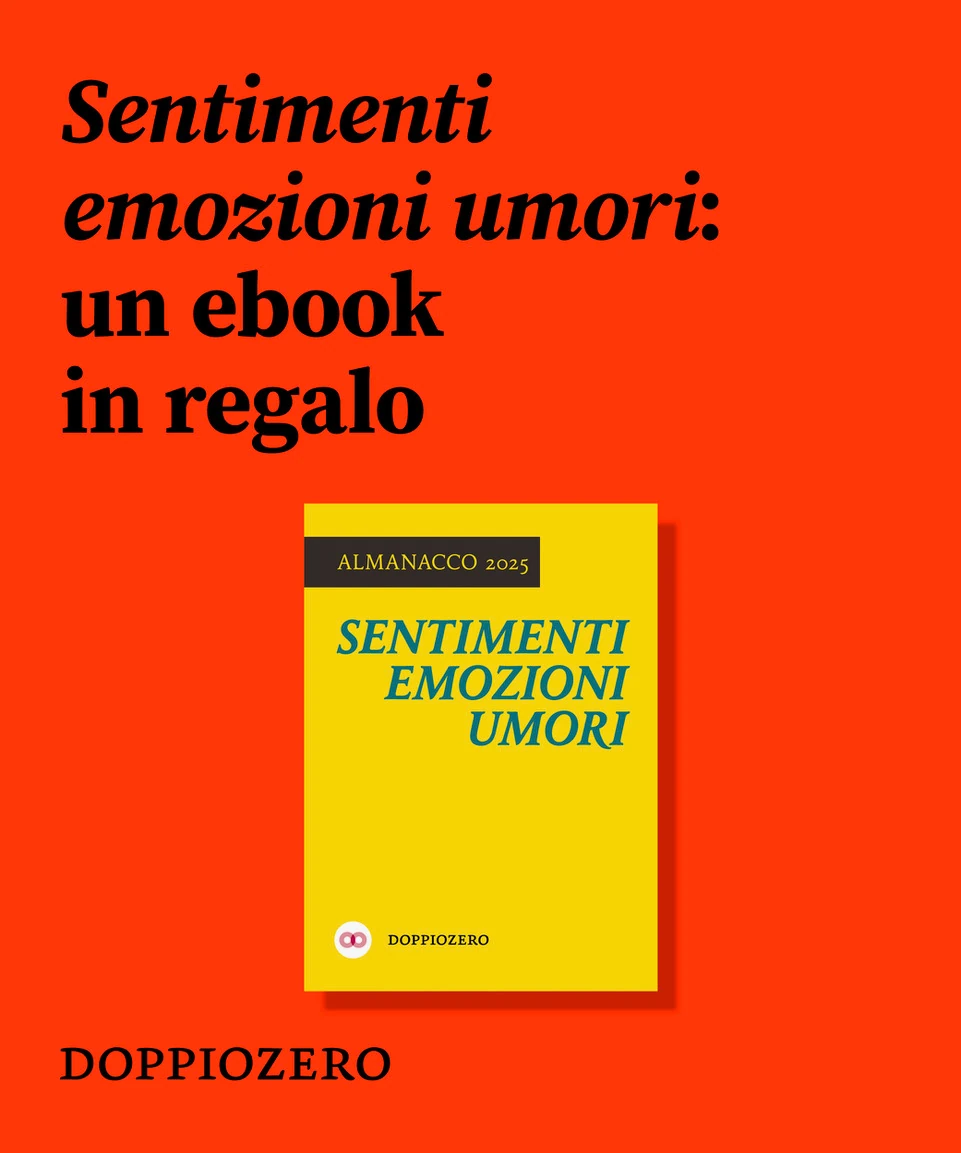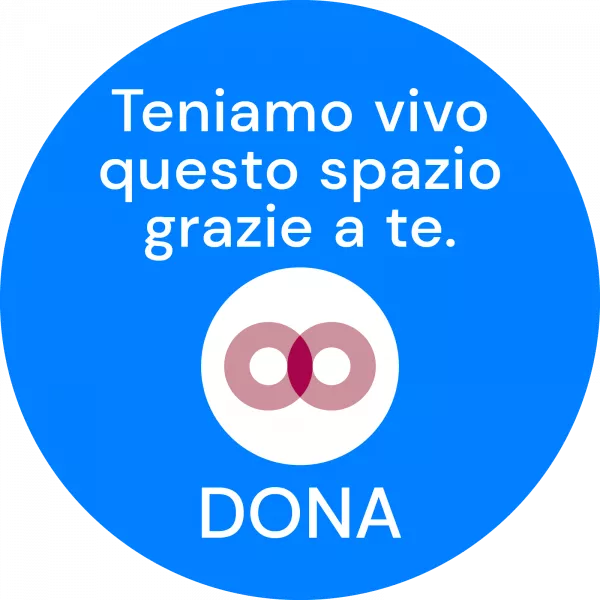Rifkin: capitalismo idrico
Immaginiamo chiunque di noi che dialoga con ChatGPT e che per un qualche motivo voglia calcolare quanta acqua sta consumando. Ogni 10 risposte se ne va mezzo litro, poi magari nel frattempo ci pigliamo un caffè: per produrlo ne servono 140 litri, e un pacchetto di patatine per sgranocchiare qualcosa: 185 litri. In meno di una mezz’oretta, senza neppure aprire il rubinetto, ne abbiamo consumato più di 325 litri. Niente male considerando che negli ultimi cinquanta anni l’acqua dolce pro capite è diminuita della metà e va detto che l’uso domestico incide per il 3,6 %, l’industria per il 4,4 mentre la produzione agricola si prende il 96%. Sarà l’IA a salvarci? Uno studio prevede che nel 2027 “il prelievo operativo totale di acqua da parte dell’IA globale raggiungerà un livello compreso fra 4,2 e 6,6 miliardi di metri cubi, ossia la metà del prelievo totale di acqua del Regno Unito.
Jeremy Rifkin nel suo Pianeta acqua, uscito per Mondadori nel 2024, rivede la storia dell’umanità dal punto di vista dell’acqua e del suo controllo, sostenendo che è stato il controllo delle acque a innescare l’inizio delle grandi civiltà, a partire dai Sumeri. In questa rilettura troviamo alcune precisazioni utili, come l’idea che non fu un aumento della produzione di cibo a portare a gerarchie complesse e Stati, ma il passaggio a un sistema che faceva affidamento sull’eccedenza dei cereali, forma di ricchezza immagazzinabile, perché facilitavano la tassazione da parte del potere. Rifkin sposta il punto di vista ma rimane sostanzialmente nella linea classica della lettura della nostra storia, quella che vuole che la civiltà sia il frutto dell’azione di élite, e nel farlo non può che criticare esplicitamente la visione diversa che si trova nell’Alba di tutto, di David Graeber e David Wengrow, che descrive una vita urbana delle origini con una governance più comunitaria (vedi la recensione qui).
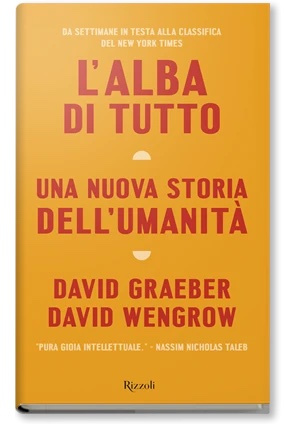
Nella sua visione “la civiltà idraulica urbana è ciò che tiene insieme il genere umano, mentre soltanto un numero minimo di membri della nostra specie vive ancora alla periferia o al di fuori della bolla. (…) Sequestrare e domesticare le acque per assicurarsi un raccolto e un surplus abbondanti sarebbe stato un piccolo passo ma con conseguenze epocali, che avrebbero alterato il rapporto della nostra specie con il mondo naturale, fino a culminare nell’infrastruttura idraulica industriale che divenne una base dell’Età del Progresso”, di cui la colonizzazione è un punto fondamentale. In ogni luogo, aggiunge Rifkin, oltre alla conquista militare dei territori vediamo una ripoliticizzazione dei nativi che assunse la forma della costruzione e gestione di gigantesche infrastrutture idrauliche. Un processo iniziato nel Neolitico e arrivato a compimento con la rivoluzione industriale. “La captazione, stabilizzazione, depurazione e distribuzione dell’acqua dolce e il riciclo dell’acqua di scarto alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX in Gran Bretagna, e in seguito nel resto del mondo, segnarono il culmine e la fase finale del sequestro e della domesticazione della nostra più preziosa forza vitale. Il sequestro dell’acqua dolce, a sua volta, divenne il nucleo centrale della rivoluzione industriale e il nesso acqua-energia-cibo la forza motrice del sistema capitalistico, sia nei paesi a economia di mercato sia in quelli socialisti.”
Da questa analisi, Rifkin propone un superamento del capitalismo a favore di ciò che chiama idroismo. “La nostra nuova concezione della forza vitale sul Pianeta Acqua ci porta dal capitalismo all’idroismo via via che ci addentriamo nel prossimo stadio dell’evoluzione della Terra. Il capitalismo sostiene la crescita, mentre l’idroismo favorisce la prosperità. Il capitalismo si prefigge la produttività, mentre l’idroismo stimola la rigeneratività. Il capitalismo considera la natura alla stregua di risorse passive, mentre l’idroismo vede la natura come fonti di vita animate. Il capitalismo genera esternalità negative, mentre l’idroismo favorisce la circolarità. (…) Il capitalismo assume un atteggiamento razionale, distaccato e utilitaristico nei confronti dell’indagine scientifica, mentre l’idroismo studia tutti i fenomeni naturali con un atteggiamento biofilico, utilizzando modelli di sistemi socio-ecologici adattivi complessi” e via di questo passo, continuando la contrapposizione.
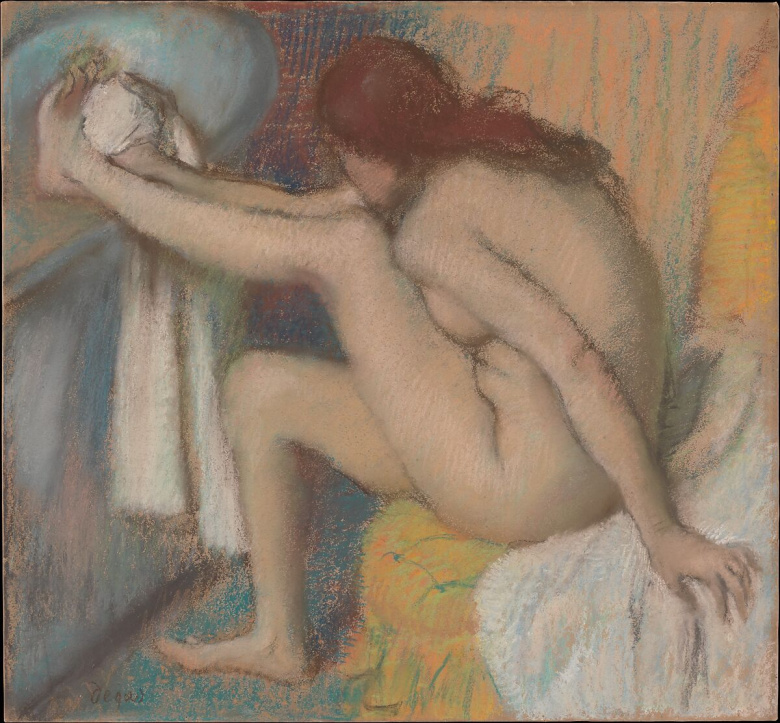
Nel libro di Rifkin troviamo una serie di informazioni che precisano il quadro generale, come il fatto che il Mediterraneo si sta scaldando del 20 per cento più rapidamente del resto del mondo, con un 40 per cento in meno di precipitazioni nella stagione invernale e conseguente diminuzione del 25 per cento dei bacini idrici entro il 2050. Ma non solo nel nostro Mediterraneo la situazione è allarmante, alcuni studi prevedono che entro il 2040 l’Eufrate potrebbe prosciugarsi, andando a chiudere simbolicamente la stagione della nostra civiltà nata proprio sulle sue rive. Dal nostro punto di vista vediamo un pianeta che sta rimanendo senza acqua dolce, mentre la realtà è che semplicemente si sta rinaturalizzando e trova un proprio equilibrio modificando l’andamento stagionale delle piogge e la loro intensità e durata. “Il problema è che la civiltà idraulica globale è ingabbiata in un ciclo idrico conseguente a un clima temperato che non esiste più. E perciò non è in grado di erogare le acque per il consumo umano”.
Sarà necessario cambiare abitudini. “Se l’olocene è stato caratterizzato da lunghi periodi di vita sedentaria e brevi periodi di vita migratoria, l’Antropocene con ogni probabilità invertirà la dinamica”. Come già altri, non molti in verità, Rifkin propone di vedere la vita sedentaria dei nostri ultimi 10.000 anni come “un breve interludio nell’esistenza della nostra specie sulla Terra”, ripensando l’attaccamento al luogo e affermando che “homo sapiens è per natura nomade, con limitati intervalli sedentari.”
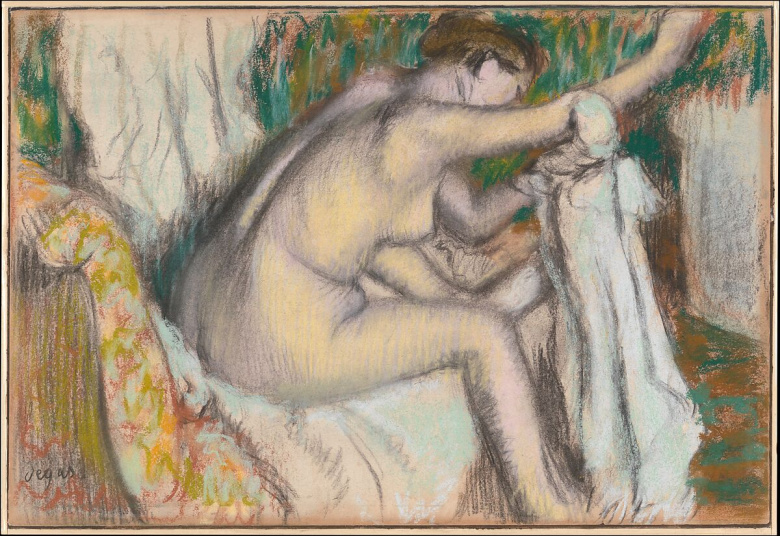
Queste idee mettono in discussione tutto l’edificio, è il caso di dirlo, della concezione architettonia e urbanistica nella quale siamo immersi, ma al di là delle varie definizioni che l’autore mette in campo, dall’architettura effimera all’urbanistica temporanea, diventa interessante il fatto che “i confini politici, le fedeltà nazionali e i documenti che attestano la cittadinanza legando la nostra specie a specifici ambiti geografici diventeranno sempre meno importanti via via che intere fasce del pianeta risulteranno inabitabili, costringendo centinaia di milioni e forse anche miliardi di esseri umani a mettersi per strada.” Trovo feconda l’idea che una direzione di lavoro per le nuove città effimere possa essere data dallo studio dai festival musicali e artistici e dai raduni religiosi tradizionali. “Questi pellegrinaggi collettivi coinvolgono centinaia di migliaia e persino milioni di persone, che costituiscono una città pienamente funzionante per un periodo effimero variabile tra alcuni giorni e qualche settimana.”
Rifkin aggiunge un tassello a quella schiera di studiosi che stanno rileggendo la nostra storia di Sapiens e lo fa partendo dal fatto oggettivo che il nostro è un pianeta d’acqua, dove le terre emerse sono una minoranza rispetto alla superficie totale. Il panorama che si sta formando è quello di una specie fatta per muoversi e stare all’aperto, dove la civiltà che conosciamo non è la sola, anzi è in termini temporali solo l’ultima fase, per di più breve se paragonata con l’estensione della nostra esistenza di specie. Abbiamo cambiato abitudini diecimila anni fa grazie a un cambiamento climatico, ora ne è in atto un altro, ci farà cambiare abitudini anche questa volta?