Le sensate esperienze della DaD / La scuola e il discorso digitale
Premessa: il diritto di lasciare le cose incompiute
C'è un apologo piuttosto noto, anche se non è chiaro chi ne sia l'autore. La storia è questa: il Direttore di una grande società, impossibilitato ad assistere a un concerto nel quale era in programma la Sinfonia N° 8 in si minore di Franz Schubert, nota come l’Incompiuta, fa dono dei biglietti al Responsabile delle risorse umane dell'azienda, un giovane laureato alla Bocconi con master in una London School, ma che non conosce la Grand Musique, nella speranza che Schubert gli apra un orizzonte. Il giorno dopo il Direttore generale gli chiede com'è stato il concerto, e si sente rispondere che riceverà una relazione; che, puntualmente, arriva a mezzogiorno, divisa in punti:
1.Durante considerevoli periodi di tempo i quattro oboe non fanno nulla: si potrebbe ridurne il numero e distribuirne il lavoro fra il resto dell’orchestra, eliminando i picchi d’impiego;
2. I dodici violini suonano la medesima nota: l’organico dei violinisti potrebbe quindi essere utilmente ridotto;
3. Gli ottoni ripetono suoni che sono già stati eseguiti dagli archi, il che appare inutilmente ridondante;
4. In conclusione: se Schubert avesse tenuto conto di queste osservazioni e avesse ottimizzato tempi e risorse, avrebbe ridotto di almeno il 25% la durata della sinfonia, e avrebbe quindi avuto il tempo di terminarla prima di morire.
La morale dell'apologo è che Schubert dovrebbe avere il diritto di fare quel che gli pare (per inciso, non è vero che l'Incompiuta è incompiuta a causa della morte dell'autore), e il pubblico di ascoltare Schubert (ma anche Otis Redding) così com'è. Nondimeno, i rilievi del giovane bocconiano sono tecnicamente esatti, presi uno per uno; quello che manca, è la comprensione del valore estetico, emotivo, artistico dell'opera di Schubert: tutti elementi che non sono suscettibili di una misurazione quantitativa.
L'ordine del discorso digitale e le sensate esperienze della DaD
Uno dei più acuti critici degli usi retorici che accompagnano e sostanziano la presunta necessità di far irrompere il digitale nel sistema educativo, Neil Selwyn, osservava nel 2013: «Public debate, commercial marketing, education policy texts and academic research are now replete with sets of phrases and slogans such as ‘twenty-first century skills’, ‘flipped classrooms’, ‘self organised learning environments’, ‘unschooling’, an ‘iPad for every child’, ‘massively online open courses’ and so on». E concludeva: «If we are to make sense of current forms of digital education, then it is necessary to consider the nature of these particular discourses». La natura scivolosa (slippery) dell'Ed-Tech Speak, secondo Selwyn, è evidente nell'operazione di re-branding con la quale vengono introdotti nel discorso educativo nuovi sintagmi che, dietro l'apparente neutralità del linguaggio tecnico, operano un vero e proprio sovvertimento delle pratiche e delle finalità scolastiche – uno per tutti, l'apprendimento (learning) in luogo dell'educazione – per cui si parla di "learnification dell'educazione"; o la ridefinizione, da parte della CRUI del compito dell'Università nello "Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente e altri portatori di interesse significativi" (p. 65). In realtà, questi nuovi sintagmi veicolano pratiche, significati e modalità di relazione fra educazione e uso della tecnologia. Nondimeno, nella maggior parte di questo rumore di fondo digitale l'innovazione viene presentata come un valore in sé – "l'innovazione per l'innovazione", come scrive Marco Meotto –, senza che sia esplicitata qual è la finalità che si attribuisce alla scuola, quali le strategie per conseguirla, e, in terzo luogo, se il digital disruption (preferisco non tradurre il termine disruption, per non privare la sua area semantica delle sue connotazioni negative) è uno strumento adeguato a conseguire queste finalità, e quali sono le evidenze che lo dimostrerebbero. Come il responsabile delle risorse umane che sforbicia l'orchestra per sfoltire l'Incompiuta di Schubert, la retorica digitale sembra non chiedersi qual è lo scopo della scuola. Ciò ha portato Selwin a sottolineare che l'Ed-Tech Speak è pieno di "stronzate" (bullshit), ovvero di sintagmi inverificabili, dei quali non è possibile accertare se siano veri o falsi. Selwin segue qui H.G. Frankfurt, che in un aureo libretto definiva "stronzata" un enunciato che non appartiene all'ordine del vero: «Uno che mente e uno che dice la verità giocano in campi opposti, per così dire, allo stesso gioco. Chi racconta stronzate ignora completamente tali esigenze».
Un'accurata decostruzione di questo ordine del discorso digitale è stata operata da Marco Gui nel suo Il digitale a scuola del 2019. In qualche modo, le sensate esperienze della didattica a distanza (DaD) hanno cambiato le cose: come lo stesso Gui ha riconosciuto in una recente intervista, «è risultata chiara la povertà comunicativa della didattica a distanza. Una volta esauritosi l’effetto novità, come dimostra la letteratura sui media, sono affiorati tutti i problemi: effetto distrattivo delle tecnologie, overload cognitivo, disuguaglianza digitale, elementi già ben descritti in letteratura ma ancora non sufficientemente noti all’opinione pubblica».
In questo senso il libro di Gui è importante anche per una ragione cronologica: la letteratura scientifica che passa in rassegna precede di un paio d'anni la DaD. Quello che, con parole semplici e in apparenza banali, hanno detto i docenti sull'esperienza della DaD coincide con quello che si scrive da anni su libri e riviste specializzate in mezzo mondo: scritture che sono a loro volta basate su prassi di digitalizzazione della didattica cominciate prima, e che proprio per questo mostrano la corda mentre da noi si inneggia all'innovazione. Con buona pace di chi ha liquidato il dibattito sulla scuola in lockdown come "enfasi della tautologia" e "filosofia alla Catalano", si è concretizzata una positiva sovrapposizione fra una prassi didattica che tutto il sistema-istruzione (docenti, discenti e famiglie) ha esperito con quello che la letteratura internazionale sull'argomento attesta da anni (bastava aver esperienza dell'una o dell'altra per accorgersene, ma che te lo dico a fare?).
Decostruire è spesso utile, quasi mai sufficiente: è necessario andare oltre, e indagare l'ordine del discorso digitale, ponendosi alcune domande: quali significati e concezioni dell'educazione sono veicolati dalle rappresentazioni del digital disruption? Fino a che punto queste enunciazioni del digital disruption sono situate all'interno di strutture dominanti di produzione e di potere? Quali libertà e restrizioni sono associate a tali enunciati? In che modo possono essere vissuti da individui e gruppi sociali diversi? Come questi discorsi inquadrano il rapporto fra l'individuo e comune, il pubblico e il privato?
Il digitale a scuola: alcune fake news che è utile conoscere
L'ordine del discorso digitale si avvale di una serie di luoghi comuni – nel doppio senso di affermazioni che vengono date per scontate in quanto condivise, senza che ne sia verificata la veridicità; e di territori nei quali bisogna esserci. Si aggiunga che in quei territori si incontrano non solo la gente che conta, ma anche i flussi di finanziamenti senza i quali la scuola dell'autonomia boccheggia. Ne elenco una sintesi dall'elenco fatto da Marco Gui nel quinto capitolo del suo Il digitale a scuola:
A. Si è invertita l'asimmetria educativa: gli studenti sanno più dei professori nel campo digitale
B. I nativi digitali hanno uno stile di apprendimento diverso, e migliore
C. I media sono neutri, tutto dipende da come li usiamo
D. La lezione frontale è un lascito del passato
E. La conoscenza è in rete, non serve più imparare nozioni
A queste cinque asserzioni si può rispondere agevolmente che:
A1. Questa affermazione è frutto di un errore percettivo: si scambia lo smanettare con una effettiva competenza digitale, e l'essere sui social con l'essere sul web. In realtà la maggior parte degli utenti dei social non esce mai dai limiti della propria infonicchia: i contenuti che condivide, le operazioni che compie (leggere un messaggio, aprire un video, ecc.) restano all'interno di questo spazio. La sensata esperienza didattica dimostra che questi apparenti smanettoni sono a volte in difficoltà nel compiere azioni elementari, come entrare nella propria casella di posta o aprire un drive, se non partono dal proprio social. Così come sanno quali tasti pigiare, ma non sanno cosa questo comporta: per citare un'esperienza personale, quando arrivo a scrivere alla lavagna col gesso in mano <a href="www.blablabla.com" /a>, per far vedere dove si arriva una volta avviata con Frege la scissione fra significato e significante, capita di rado che qualcuno sappia cosa significa questa stringa di codice html, o la sappia correlare all'immagine del pulsante con su scritto "link" o il disegno della graffetta (nondimeno, un ispettore che capitasse in quel momento potrebbe criticare il mio uso pervicace del gesso in luogo della più aggiornata LIM). In aggiunta, «molte ricerche hanno mostrato che l'abilità tecnologica e digitale dei giovani resta per lo più confinata nell'ambito delle competenze operazionale», laddove «la competenza digitale "content related", relativa cioè all'analisi dei contenuti veicolati dai media, è maggiore negli adulti che nei giovani» (p. 173): si sta parlando, per capirci, (anche) della capacità di interpretare criticamente un post, individuandone le distorsioni.
B1. Questa asserzione si basa su un doppio errore. In primo luogo, il presupposto che gli stili di apprendimento denotino due campi – per banalizzare: i docenti-boomers e i giovani-zoomers – separati da paratie stagne. L'esperienza della DaD ha invece dimostrato che i boomers sono stati in grado di convertirsi in zoomers o meeters. Questo ci porta al secondo pregiudizio: che lo stile di apprendimento caratterizzato da velocità, frammentazione, iperstimolazione e dal multitasking sia di per sé "migliore": vero è, invece, che questo stile comporta la rinuncia a importanti elementi cognitivi – approfondimento, analisi riflessiva, capacità di imparare dai propri errori, lentezza (tutti elementi che non vengono misurati dai test di verifica degli apprendimenti, per inciso). In definitiva, questo luogo comune si basa sull'assolutizzazione di uno stile cognitivo, che è però funzionale solo a poche e determinate esperienze di apprendimento.
C1. Qui si tratta di capire cosa si intende per "media": il mero accrocco, o gli ambienti mediali? Sappiamo bene che algoritmi e feedback sono progettati e programmati per veicolare certi comportamenti o pratiche, e limitarne altri. E che il loro inserimento all'interno di un contesto ne veicola la funzione: insomma, l'algoritmo sarà anche in apparenza neutro in quanto insieme di simboli/codici, ma dietro l'algoritmo c'è un programmatore umano. Anni fa, quando l'algoritmo che attribuiva le cattedre ai precari comportò una vera e propria deportazione di precari, il suo programmatore (che era stato precario anch'egli) rispose alle critiche dicendo: se la cattedra che ti spetta è a Terni, la colpa non è dell'algoritmo. Vero: la colpa era del taglio delle 100.000 cattedre operato dalla riforma Gelmini, sul quale la Buona Scuola glissava. Ma l'idea che esistesse un algoritmo imparziale impediva di vedere la foresta al di là dell'albero, e finiva col fornire una giustificazione smart all'ingiustizia.
D1. Qui si tratta in primo luogo di intendersi su cos'è una lezione frontale. Il docente in classe ha una certa varietà di modalità, che vanno dal leggere la stessa storia sullo stesso libro con le stesse parole di vendittiana memoria, fino al brainstorming, con tutte le varianti del caso: però è probabile che lo studente percepisca come frontale una lezione che il docente non considera tale. In altri termini, si tratterebbe di vedere se i presunti limiti della lezione frontale non siano in realtà limiti intrinseci a un uso parziale o limitato, come guidare un'auto senza mai ingranare le marce alte. Questo luogo comune si accompagna però a un implicito: che, essendo "vecchia" la lezione frontale, qualsiasi cosa, purché "nuova", sia di per sé migliore (per inciso: formulata così, è una fallacia logica); e dunque flipped classroom, collaborative learning, didattica per competenze: senza che di queste "novità" si dimostri la maggiore utilità.
E1. Questo luogo comune, che è stato alla base della Buona Scuola (lo stesso Matteo Renzi l'aveva in precedenza enunciato a Che tempo che fa con aria ispirata), è una modalità smart di enunciare la didattica per competenze, che si basa su un doppio fraintendimento: in primo luogo, si confondono le conoscenze con ciò che merita di essere conosciuto; in secondo, sovrappone il ruolo delle competenze con quello delle conoscenze. In rete, ma prima che la rete fosse nel mondo, c'è di tutto: il vero, il falso, l'utile e l'inutile. Non si possono mettere tutti i dati sullo stesso piano limitandosi a connetterli, senza operare una scrematura e una selezione: si formano altrimenti studenti (di nuovo, parlo per esperienza) abituati a scaricare la qualunque, e la qualunque a giustificare con affermazioni tipo "l'ho trovato in rete". Al tempo stesso, «le competenze di verifica delle informazioni non possono sostituire il confronto con una base di informazioni di cui si conoscono senza dubbio la validità e la coerenza» (p. 185): la grandinata di fake news, di negazionismi, di fallacie logiche e argomentative, di errori di traduzione, di equiparazione delle fonti che ha inquinato la discussione pubblica nei giorni del lockdown e oltre dovrebbe avercelo ultimativamente insegnato. Al fondo di questo luogo comune, in modo più evidente che negli altri, c'è la domanda su quale finalità vogliamo attribuire alla scuola. Di nuovo con le parole di Gui: «se vogliamo formare tecnici da mettere subito nel mercato del lavoro, l'idea di un utente che trova le informazioni a mano a mano che gli servono, può essere efficiente. Se, però, abbiamo in mente un cittadino autonomo, che sappia dare una lettura critica dei fatti che vive direttamente o che trova nei media, il ruolo della conoscenza pregressa e ben strutturata appare irrinunciabile» (p. 186).
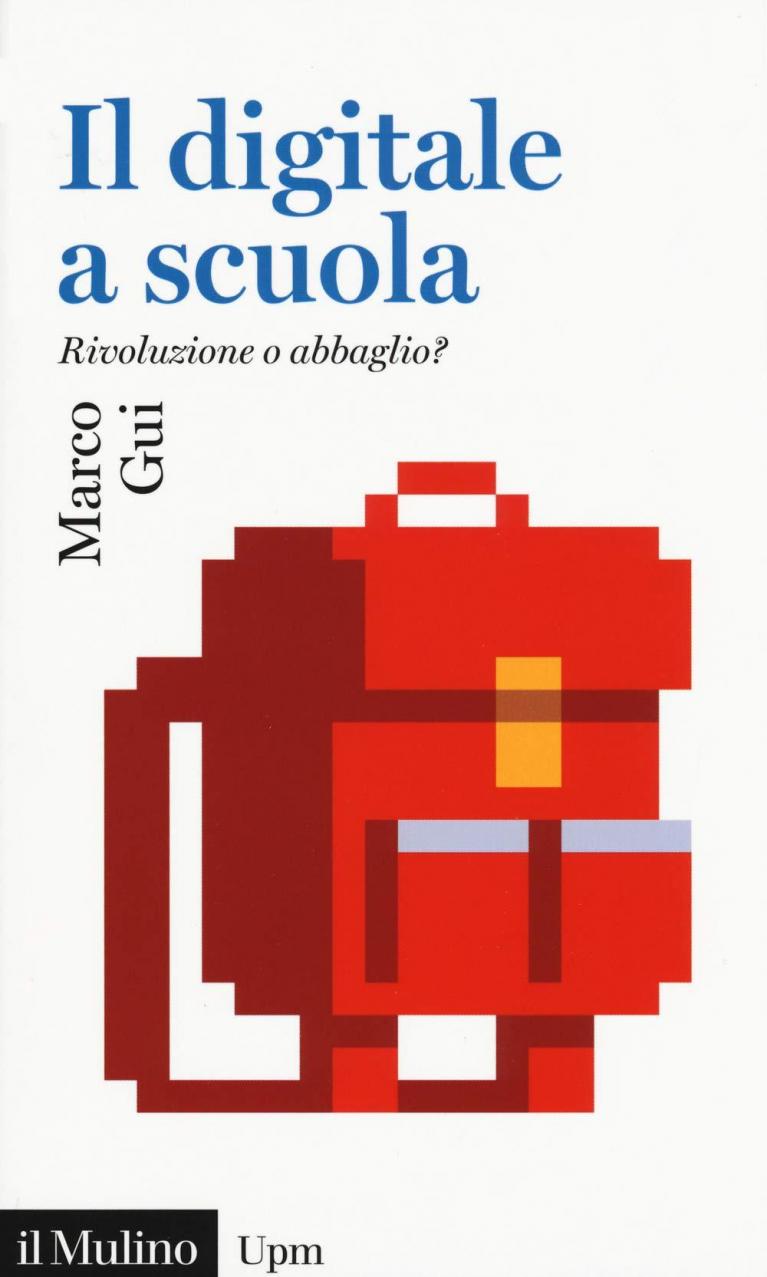
Depotenziare e semplificare: la neolingua del digital disruption
Un'altra caratteristica del digital disruption è una marcata banalizzazione del linguaggio: la valenza comunicativa e cognitiva del linguaggio complesso sembra essere sottomessa alla maggiore funzionalità alla mera trasmissione di contenuti di un linguaggio elementare. Una conseguenza che getta luce sulla portata della learnification dell'educazione, che cercherò di argomentare con alcuni casi esemplari.
Il primo riguarda l'università, nella quale i processi di digitalizzazione della didattica sono molto più avanzati che nella scuola. In un recente documento, Federico Bertoni, Davide Borrelli, Maria Chiara Pievatolo, Valeria Pinto puntano il dito sulla cosiddetta didattica blended, a partire dai documenti CRUI (la Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) che ne dettano le norme; ai docenti è chiesto di insegnare in un “blended learning environment” (un’aula predisposta per la registrazione e lo streaming):
La lezione si trasforma in un modulo riutilizzabile, fungibile, computabile. Si è arrivati a consigliare ai professori universitari di usare «parole chiave in maiuscolo» per un uso efficace delle slide», «periodi brevi, evitando quindi la narrazione prolissa», «elenchi puntati, per mettere in risalto dei concetti o chiarire argomenti complessi»; e ancora: «evitare di inserire riferimenti all’insegnamento», «evitare riferimenti temporali», «evitare di riferirsi alla numerazione delle lezioni (es. questa è la seconda parte dell’incontro)». Così, si dice esplicitamente, «le registrazioni possono essere riutilizzate per insegnamenti/corsi differenti»; si possono «riutilizzare i moduli didattici anche con un ordinamento differente»: unità di apprendimento «auto consistenti e indipendenti», ogni mattoncino «di durata compresa tra i 10 minuti e i 20 minuti max», ricombinabili secondo le esigenze del caso.
Sarà bene sottolineare che questa prassi, che trasforma gli studenti in utenti/ricettori di pillole preconfezionate recitate da «un docente che, una volta alienato il suo prodotto, non ha neppure bisogno di continuare a esistere», è alternativa a investimenti nel reclutamento dei docenti, nell’edilizia universitaria e in studentati.
Il secondo caso è un documento ministeriale, gli Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società delle competenze prodotti nel 2017 da una commissione ministeriale per adattare alla Buona Scuola l'insegnamento della filosofia, in cui si pretende di ridurre il sapere filosofico a un Sillabo di filosofia per competenze e il docente a facilitatore del processo di apprendimento», in nome di una filosofia che cede davanti al proprio desiderio e si acquatta nel ruolo di counseling filosofico: una filosofia buona per un debate, cioè per fare chiacchiere al tavolo del burraco. Il "lancio" di questo documento fu accompagnato da una improvvisa fioritura di manuali scolastici improntati alla semplificazione di linguaggio e contenuti – uno "stile limpido e lineare assistito da mappe, schemi, tabelle e disegni" –, per fare spazio a "contenuti digitali" quali booktrailer filosofici utilizzabili anche per la flipped classroom, lezioni LIM (presentazioni personalizzabili che sintetizzano i concetti chiave dei capitoli e ne riprendono schemi e cronologie), e un corredo di webinar di sconcertante banalità (ma certificabili come aggiornamento) per accompagnare il docente. Uno dei facitori di questa manualistica lo ritroviamo fra gli autori dei podcast prodotti dal MIUR per "facilitare" la preparazione degli studenti all'esame. Senza tema di sdoganare la parola "bigino" (dopo aver sdoganato "sillabo", del resto), questi podcast sono stati diffusi sul web player Spotify: una modernità che fa passare in secondo piano il classismo col quale "le dieci materie più importanti" sono state individuate nel curricolo del liceo classico. Basta aprire il primo, sulla Critica della Ragion pura di Kant (che è programma del quarto anno, ma tant'è...) e si può ascoltare un riassuntino di mezz'ora con un linguaggio che sembra presumere che le subordinate contengano olio di palma o glifosfato; in compenso, ricompare la bufala delle passeggiate di Kant sulle quali si regolavano gli orologi: che sarà un dettaglio, ma la dice lunga sulla considerazione per i contenuti sui quali si dovrebbero poi svolgere i debate – però vuoi mettere, scaricarlo da Spotify? Sopravvissuti a 6/7 cambi di ministro, gli Orientamenti ricompaiono nel Piano per la ripartenza della Regione Veneto, dove, reintroducendo dalla finestra la DaD in apparenza accompagnata alla porta, si forniscono "indicazioni metodologiche" per «una organizzazione della didattica centrata sugli apprendimenti attivi degli allievi, anche mediante la rimodulazione dei curricoli per nuclei fondanti essenziali, privilegiando lo sviluppo dei concetti chiave, delle relazioni interdisciplinari e dei metodi per costruire e organizzare gli apprendimenti»: esplicitando il fatto che la banalizzazione della filosofia ridotta a sillabo è funzionale a una lezione a distanza (si ricorderanno i moduli di 20 minuti sostitutivi di un'ora in presenza delle Linee Guida della CRUI), ovvero alla lectio brevis di un'ora ridotta a 40 minuti e in modalità blended.
L'ordine del discorso digitale e la logica del Realismo capitalista
Riprendo un passaggio dal documento CRUI CAF Università. Il modello europeo di autovalutazione delle performance per le università (p. 61):
Così come lo studente che si iscrive ad un corso di studio universitario costituisce l’input al processo formativo universitario (caratterizzato dal bagaglio di conoscenze e abilità acquisite nei processi formativi precedenti, che in tal senso costituisce a tutti gli effetti quello che potrebbe essere definito un “semilavorato pregiato in ingresso”), lo studente che si laurea costituisce l’output (il prodotto/risultato complessivo) del processo formativo universitario (caratterizzato dal bagaglio di conoscenze e abilità acquisite nel processo formativo universitario).
La fredda logica cadaverica di questo testo, nel quale la prassi educativa è neutralizzata e spogliata di ogni passione, emozione, connotazione etica, sociale e risignificata in "erogazione di servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente" procede come un manuale tecnico: il presupposto è che, seguendo la sequenza di procedure, eventualmente esemplificate in un diagramma di flusso, si ottiene il prodotto/risultato complessivo. Successo o insuccesso formativo saranno da addebitarsi alla corretta esecuzione della sequenza; in definitiva, alla individuale capacità del docente e del discente, ovvero alla loro incapacità: la struttura in sé, in quanto efficiente, è deresponsabilizzata.
È la logica di quello che Mark Fisher ha denominato "Realismo capitalista", fondato su tre enunciati fondamentali:
1. Non c’è altro modello di gestione della società possibile al di là di quello basato sulle regole del mercato: There Is No Anternative;
2. Le regole del mercato vanno estese anche a quegli ambiti della società dal quale il mercato era escluso: istruzione, sanità, pubblica amministrazione;
3. Il mercato non contempla un’entità come la società, ma singoli individui concepiti come consumatori-utenti, imprenditori di sé stessi, individualmente responsabili del proprio successo o insuccesso.
Questa logica, applicata alla sanità pubblica con esiti che hanno reso tragicamente nota la Lombardia nel mondo, è all'opera da tempo anche nel sistema-istruzione, e fonda la retorica dell'innovazione digitale.
Il primo enunciato legittima i sostenitori del digital disruption dall'esaminare le evidenze contrarie, i limiti cognitivi e sociali dell'interconnessione e dell'implementazione della tecnologia nell'educazione: se non c'è alternativa, perché occuparsene?
Il secondo enunciato, con un perverso feedback, fa retroagire l'autovalutazione positiva dell'innovazione Ed-Tech sui criteri di valutazione dell'innovazione stessa: che l'innovazione digitale sia in grado di migliorare i livelli di apprendimento in alcune materie (che per questo sono definite fondamentali, con buona pace delle intelligenze multiple e della natura poliedrica della mente umana), di sviluppare competenze digitali e di aumentare l'inclusività sociale della scuola, è una sorta di tormentone che, un po' come il "se l'amore è amore" in Notte prima degli esami, si reitera da sé indipendentemente dall'assenza di evidenze che supportino queste aspettative.
Il terzo enunciato individualizza la didattica e la responsabilità del suo successo/insuccesso: ignorando che il carattere classista della scuola e della società italiana incollano al pavimento sociale gli studenti, o bloccano con soffitti di plexiglass l'ascensore sociale. L'Italia è, nel cosiddetto mondo occidentale, seconda solo alla Gran Bretagna per rigidità sociale, con professioni che arrivano ad avere un traino familiare del 65%; dagli studi OCSE a quelli di De Mauro sulle competenze linguistiche, alle analisi della composizione sociale delle scuole italiane, possiamo definire un fatto acclarato che il destino, se non come professione quantomeno come collocazione sociale e livello di istruzione, sia in misura predominante determinato dalla famiglia d'origine. L’Italia resta un paese classista, dove il figlio del notaio studia legge come il padre, poi va a fare praticantato dai compagni di carte del sabato sera del padre, e una volta acquisita la professione aggiunge un “& figli” alla targa dell’ufficio del padre; mentre il figlio del proletario resta proletario, come il bambino povero della celebre gag di Giorgio Gaber al quale il padre, davanti a un paesaggio, diceva non: «guarda, un giorno tutto questo sarà tuo», ma soltanto: «guarda…». E mentre guarda si sente dire che se non ha saputo cogliere le opportunità che il libero mercato offre, la colpa è sua, così come se ti ammali la colpa è della tua costituzione fisica e del tuo stile di vita e non di un sistema sanitario carente e inadeguato: è il Realismo capitalista – There Is No Alternative.
Ma se la digitalizzazione dell'educazione non aggredisce la contraddizione sociale fondamentale, e men che meno la mette in discussione, non solo è impotente a modificare quegli esiti della contraddizione sociale, ma ne è di fatto complice, se non parte integrante.
The bullshit should stop here!, ovvero: cosa fare con l'Ed-Tech Speak?
I due studiosi cui ho fatto prevalentemente riferimento, Gui e Selwyn, sono più o meno concordi sul fatto che il digitale a scuola, il suo ordine del discorso e i suoi storytelling debbano essere rimessi in discussione. Selwyn propone due strategie: la più moderata consiste nel ricominciare a chiamare le cose col loro nome, al di là dell'enfasi tecno-modernista: tornare a dire "studenti" invece che "utenti" o "clienti", "lavori di gruppo" invece che "comunità di apprendimento", "problemi" piuttosto che "criticità". La seconda, «A more radical alternative», è una strategia di verità, o forse di parrhesia: «to broker deliberately ‘honest’ declarations of the likely consequences of digital technology use. Perhaps, we need a language of education and technology that unpacks more aptly the underlying functions of these technologies and exposes their political intent». In definiva, bisogna farla finire con le stronzate (The bullshit should stop here!).
Gui usa in modo consapevole la terminologia foucaultiana nel definire "discorso" un insieme di enunciati che veicola una certa idea di realtà: e il discorso sul digitale non fa certo eccezione. Ma gli enunciati, a loro volta, vanno a costituire un ordine discorsivo a partire da certe pratiche che ne costituiscono lo sfondo: e questo mette in questione l'insufficienza della pur necessaria strategia di chiarificazione delle opacità retoriche dell'Ed-Tech. Non c'è reale possibilità di mettere in discussione l'ordine del discorso digitale, senza mettere in discussione il Realismo capitalista col quale è intrecciato. Conviene allora ricordare che proprio Michel Foucault, nella sua ultima settimana di lezione tre mesi prima di morire, indicava nella filosofia cinica il modello di una militanza filosofica che ha intende la cura di sé come cura dell'altro, «la vita come una vita altra, una vita di lotta, per un mondo cambiato»; e concludeva: «non vi è instaurazione della verità senza una posizione essenziale dell'alterità; la verità non è mai il medesimo; non può esserci verità che nella forma dell'altro mondo e della vita altra».
[Nota: raccolgo in questo testo quanto ho esposto in tre appuntamenti pubblici: il workshop Diritto alla salute, vaccino del comune, riconversione ecologica, all’interno della seconda assemblea #ilmondocheverrà, 30 aprile 2020; il workshop Riapertura della scuola e scenari di innovazione: tempi, spazi e relazioni, 8 luglio 2020, Fondazione Feltrinelli Milano; la tavola rotonda Sapere per il futuro, organizzata dal Laboratorio di filosofia della tecnica "Mechane" dell'Università Federico II di Napoli, 9 luglio 2020]







