Economia digitale / Il capitalismo immateriale è molto materiale
“Nel secolo XVII una libbra di pepe poteva essere comprata a Giacarta per una sterlina e rivenduta a Londra per 100. La differenza, tolti i costi di trasporto, andava tutta a chi aveva il controllo del mare” (p. 178).
Arrivato quasi alla fine del libro di Stefano Quintarelli Capitalismo immateriale (Bollati Boringhieri, 2019, p. 198), ho trovato questa frase che ne riassumeva tutto il senso. Il libro di Quintarelli è il libro di un economista che da questa prospettiva riflette sui gatekeepers, su chi esercita un potere di controllo sulla circolazione di un bene, una merce, un servizio. Nel 1600, chi controllava il mare, chi faceva da medium tra le colonie e l’impero britannico, si garantiva grandi margini di guadagno, più alti di chi produceva il pepe a Giacarta. Oggi, Apple, Google, Facebook, Amazon, Uber, Airbnb hanno sostituito la Compagnia delle Indie nella lista degli intermediari più potenti. Non smerciano più spezie da Giacarta ma commerciano in altri beni preziosi immateriali.
Il libro di Quintarelli è un libro su questi nuovi capitalisti dell’immateriale e su quanto questa nuova forma di creazione di valore economico determini economia e società.
Il libro è un riassunto notevole, per lucidità e ampiezza di vedute, di tutti i temi e le parole chiave connesse all’economia digitale: rapporto capitale/lavoro, finanza, cripto-valute, informazione, giornalismo, algoritmi, guida automatica, automazione del lavoro, comunicazione politica, filter bubble, singolarità, monopoli digitali. Per chi volesse avvicinarsi a questi temi e uscirne con la sensazione di saperne di più di prima, è un libro utile e chiaro. Una grande visione di insieme, che socializza il lettore al vocabolario delle parole chiave del dibattito sul digitale, ma non è un libro di ricerca. Non c’è nel libro una tesi forte, se non l’insistenza sulla dimensione immateriale di questo tipo di capitalismo e, nelle conclusioni, un’interessante proposta politica.
Credo però che l’insistenza sulla dimensione immateriale di questo capitalismo, opposta e riproposta in maniera dualista per tutta la durata del libro, sia la sua maggiore debolezza.
Provo qui a leggere questo libro da un’altra prospettiva, rispetto a quella economicista dell’autore: quella dei media studies contemporanei, a cavallo tra sociologia, economia politica dei media e cultural studies. In questo campo, il dibattito sull’ascesa del capitalismo immateriale è in corso da tempo, ma il linguaggio è un po’ diverso. Le parole sono importanti. Nel nostro campo si parla oggi soprattutto di capitalismo digitale e ultimamente di “platform capitalism” (Nick Srnicek, tradotto in italiano in Capitalismo Digitale, Luiss 2017) e di “platform society” (Van Dijck et al. 2018).
Ma non si usa mai, o non più, la parola immateriale.
Immateriale vs. Materiale: la svolta materialista
La tesi di Quintarelli non è nuova, si inserisce in un filone che a partire dagli anni sessanta, ha cominciato ad intravedere la rilevanza crescente dell’informazione e della conoscenza nei processi di produzione industriale. Dai primi teorici della società dell’informazione e dell’economia della conoscenza, si è passati a parlare di capitalismo informazionale (Castells 1999) e di capitalismo cognitivo (Paulré 1999). Nel 2003 usciva un libro importantissimo di André Gorz, l’Immateriale. Conoscenza, valore e capitale. Qui Gorz indagava la transizione del capitalismo moderno, centrato sulla valorizzazione di grandi masse di capitale fisso materiale, verso un capitalismo post-moderno centrato sulla valorizzazione di capitale immateriale. Questo capitale immateriale per Gorz è il capitale “umano”, messo al lavoro in maniera invisibile, fuori dai tradizionali luoghi di produzione di valore. La differenza tra Gorz e Quintarelli però sta nella diversa prospettiva di analisi della componente immateriale: Gorz era un umanista post-marxista, e la sua teoria del bio-capitalismo lo ha portato a sostenere la necessità di un reddito di esistenza, per “sottrarre la vita all’immaginario mercantile e alla messa al lavoro totale” (p. 22). Quintarelli è un liberale, che, come vedremo alla fine, alle sfide di questo capitalismo digitale dà una risposta da economista liberale.
Per Gorz il capitalismo si stava sì trasformando in senso immateriale, ma questa immaterialità non era una caratteristica specifica dell’economia digitale, veniva piuttosto da lontano. Inoltre Gorz si concentrava sulla componente immateriale del valore di una merce o servizio, ovvero il “brand”, quell’insieme di valori simbolici associati ad una particolare merce, frutto della messa a valore del lavoro cognitivo e creativo di pubblicitari e designer. Le riflessioni di Gorz e dei pensatori simili a lui (per esempio, Adam Arvidsson, Brand. Meaning and value in media culture, 2005) hanno contribuito a mettere in rilievo le caratteristiche emergenti del capitalismo post-fordista, fondate sull’estrazione di valore dalle relazioni sociali, dalla creatività umana, dal linguaggio. Il dibattito sull’ascesa delle componenti immateriali del capitalismo è stato molto utile, molto prima dell’ascesa del web 2.0 e dei nuovi capitalisti digitali, ma nel tempo, altri studiosi hanno cominciato a esaminare anche le componenti materiali di questo capitalismo immateriale fondato sulla commercializzazione del cyberspazio. L'idea che Internet fosse un 'cyberspazio' immateriale, un mondo virtuale, separato dal resto del mondo materiale, è stata dominante nella prima ondata di studi da parte delle scienze sociali (Miller e Slater, The Internet: An Ethnographic Approach, 2000), ma è stata, almeno nei media studies, via via abbandonata per un ritorno del materialismo.
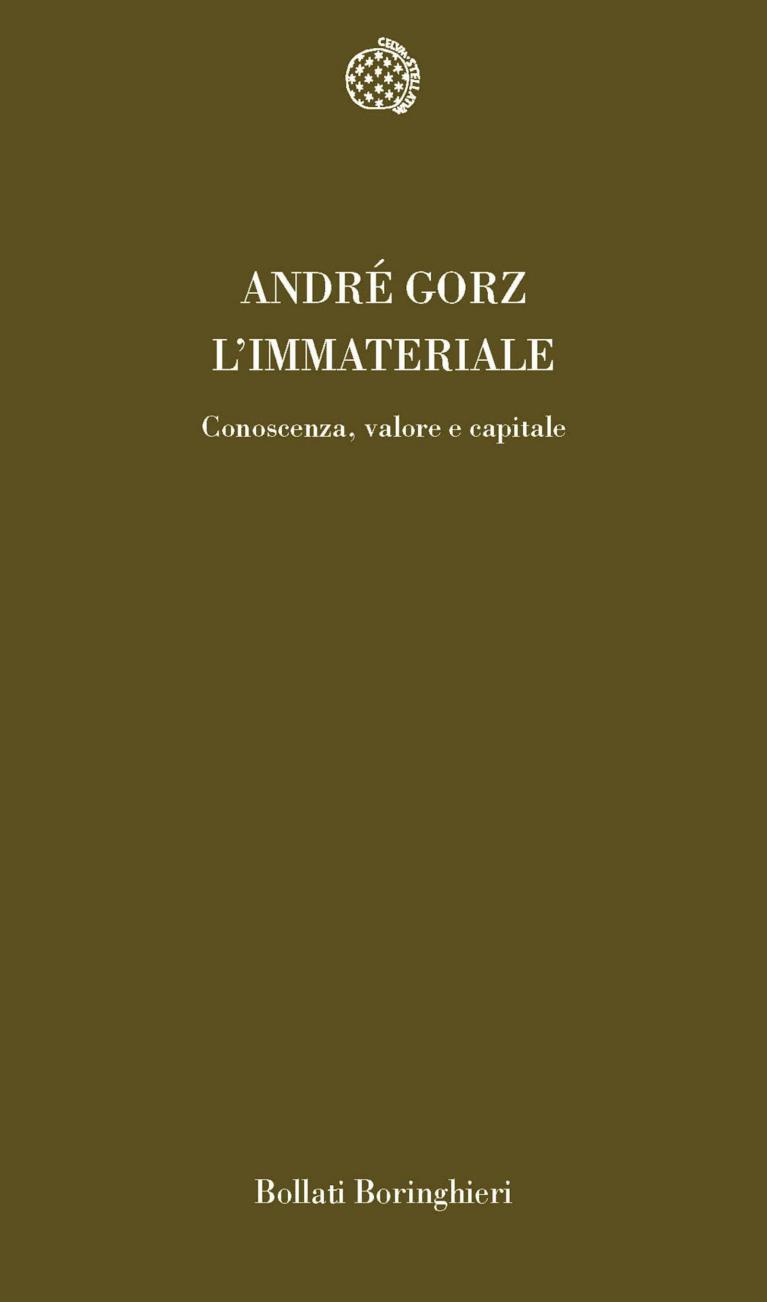
Il materialismo come paradigma teorico presuppone che tutte le cose del mondo, comprese le cose digitali, siano legate (e in alcuni casi determinate da) processi fisici e materiali.
Nel 2018, alla conferenza internazionale dell’Aoir, la più importante associazione internazionale di studiosi di media in Internet Research, il tema era “materialità transnazionali” e la parola chiave è stata “material turn”, cioè la svolta “materialista” negli studi sui media digitali.
Per svolta “materialista” si intende l’ascesa di una nuova prospettiva che guarda ad Internet come un assemblaggio socio-tecnico fortemente radicato nel mondo fisico e nelle componenti materiali della comunicazione. Questa “svolta” metodologica cerca di ancorare l'analisi critica dei media digitali alle molteplici fisicità e corporeità incarnate e generate all'interno di tali tecnologie in rete (per approfondire: leggetevi questo articolo, Digital Materialisms: Six Frameworks for Digital Media Studies, di Nathalie Casemajor, 2015). Tutti i dati digitali sono costituiti da iscrizioni fisiche. I dati codificati in bit sono memorizzati sotto forma di polarità magnetiche su dischi rigidi, cariche elettriche su schede di memoria flash o microscopici solchi sulla superficie dei dischi ottici. Tutta roba microscopica, ma molto materiale.
Guardare a questo capitalismo come una forma di creazione di valore fondata su infrastrutture tecnologiche estremamente fisiche e dotate di una complessa materialità, invece che, come fa l’autore, come una forma di creazione di valore invisibile, leggera, intangibile, permette di valutarne meglio l’impatto e comprenderne meglio i contorni e forse reagire meglio al suo governo.
Il capitalismo apparentemente immateriale descritto da Quintarelli si fonda su una solida infrastruttura di cavi transoceanici dello spessore di alcuni centimetri, che sono tanto materiali quanto lo erano i cavi del telegrafo posati per la prima volta nel 1854. Il capitalismo “immateriale” è iniziato con la rivoluzione elettronica, ma non ha mai smesso di essere materiale. Vedere internet come una rete di lunghissimi cavi transoceanici pesanti tonnellate, invece che vederlo come una nuvola immateriale, ci riporta a questioni più terrene, come la geopolitica dei cavi sottomarini, il controllo politico-economico di questa infrastruttura, il suo impatto ambientale (internet per funzionare ha bisogno di una quantità di energia enorme e la blockchain che dovrebbe rappresentare la sua evoluzione avrà un impatto esponenziale sull’ambiente).
Nathalie Casemajor sostiene che “La seconda questione politica che sta acquisendo sempre maggiore attenzione negli studi sui media digitali riguarda il degrado degli ambienti naturali nell'era dell'Antropocene. Una nuova generazione di studiosi ha evidenziato la connessione tra le questioni ambientali e l'economia politica dei media digitali (Parikka, 2011; Maxwell e Miller, 2012). Le questioni vanno dall'inquinamento dei fiumi e dei terreni agricoli dovuto alle industrie legate alle ICT, al consumo energetico e alla produzione di CO2 nelle server farm, al green computing, all'obsolescenza intrinseca della cultura materiale digitale, ai rifiuti elettronici”.
Il mito di un'economia della conoscenza "smaterializzata" e "senza peso" tende ad oscurare il fatto che i computer consumano grandi quantità di energia e che molti beni fisici devono essere trasportati e venduti perché questa economia funzioni. La masterizzazione di musica digitale su compact disc e DVD, la produzione/pubblicazione/distribuzione di articoli e libri digitali, ecc. necessita di nuovi consumi di materiale ed energia. Per scaricare un album da iTunes o ascoltare in streaming un disco da Spotify consumiamo 2,5 volte più energia di quella necessaria per acquistare un vinile in un negozio di musica.
Il capitalismo “immateriale” che valorizza i dati prodotti dagli utenti tramite l’uso delle app, non sarebbe possibile senza l’attività di minatori congolesi che estraggono coltan, “materie” prime necessarie per la realizzazione dell’iphone, che viene disegnato da materialissimi uffici di designer e developer nella Silicon Valley e assemblato in materialissime catene di montaggio fordiste e post/fordiste asiatiche, per poi viaggiare attraverso materialissimi container. Questo è quello che intendiamo per Internet come apparato socio-tecnico: l’insieme di tutte le interazioni sociali e tecnologiche necessarie alla produzione, mantenimento e funzionamento dell’infrastruttura che, come un harware, permette al software del capitalismo digitale di installarsi. È questa struttura “invisibile” ad essere oggi al centro degli studi sui media che si situano all’interno del “material turn”.
Quintarelli a pag. 15 illustra le proprietà della dimensione materiale, in opposizione a quella immateriale. Sostiene che nella dimensione materiale del mondo, produrre costa, perché abbiamo bisogno di materie prime, energia, lavoro e capitali. Vero, eppure Apple – una delle cinque aziende globali più importanti del capitalismo “immateriale” – per produrre l’iphone, il device più efficiente e più utilizzato per alimentare questo tipo di capitalismo, ha bisogno di materie prime, energia, lavoro e capitali. Apple è un’azienda capitalista che appartiene alla dimensione materiale del mondo, tanto quanto Exxon.
Altro punto della dimensione materiale: archiviare costa. È vero, con il digitale archiviare costa meno. Si riducono gli spazi necessari ad archiviare dati digitalizzati. Ma torniamo alle server farm dove sono conservati i nostri dati: quanto costa mantenerle? Quali sono i costi (finora non calcolati) ambientali?
Nella dimensione materiale trasferire costa, sostiene l’autore. Per trasferire il petrolio ci sono gli oleodotti, per trasferire informazione ci sono i cavi e i satelliti, ma non sono “immateriali”, hanno una dimensione fisica e geopolitica tanto quanto gli oleodotti.
Quintarelli sostiene anche che nella dimensione materiale ci sono i turni di lavoro (ma perché chi lavora per Amazon non ha i turni di lavoro? Chi fa i lavoretti della gig economy non ha turni?). La differenza tra il lavoro nelle vecchie e nelle nuove economie non sta nel diverso tipo di tecnologia utilizzata, ma nel diverso tipo di conflitto tra capitale e lavoro: all’inizio del capitalismo industriale anche il lavoro materiale degli operai non era sottoposto a turni rigidi e ferie. Oggi il lavoro nella gig economy o nel giornalismo digitale è meno regolato non per colpa delle tecnologie immateriali, ma per colpa di una mancanza di conflitto sociale.
Esistono delle differenze certo, tra economia industriale e digitale, ma non ci conviene opporle in maniera netta, come se la seconda segnasse una discontinuità netta rispetto alla prima, come se gli attori fossero diversi e in fondo, i capitalisti dell’era precedente, fossero migliori. Innanzitutto, molti dei vecchi capitalisti oggi siedono nei consigli di amministrazione delle nuove aziende digitali. In mezzo a queste due forme di creazione di valore, già dagli anni sessanta, si parlava di economia dell’informazione e società della conoscenza. Questo capitalismo digitale è l’evoluzione del capitalismo precedente, tracciare una linea netta tra capitalismo materiale e immateriale è più facile a parole che nei fatti. Già la radio e la televisione commerciali nell’epoca della società di massa creavano valore estraendolo da una materia intangibile e immateriale: l’attenzione di masse di spettatori. Aveva iniziato la penny press nel 1839, a dire il vero. Radio e tv commerciali del novecento rappresentavano già una forma di capitalismo “immateriale”. In realtà André Gorz fa risalire la capitalizzazione della conoscenza, cioè l’inizio dell’economia “immateriale”, verso il 1880, quando Carl Duisberg industrializza, presso la Bayer, il lavoro di ricerca nell’industria chimica. Quindi la metafora del capitalismo immateriale viene da lontano e non è una caratteristica intrinseca del capitalismo digitale: non è la dimensione immateriale a distinguere l’economia digitale dalla precedente. Insomma, non serve opporre materiale a immateriale per capire la svolta contemporanea, iniziata con l’elettrificazione del mondo (telegrafo) più che con il digitale. La risposta non sta nella dicotomia materiale/immateriale, ma nei differenti apparati socio-tecnici che hanno dominato il novecento e questi primi anni del XXI secolo. Quest’ultimo apparato socio-tecnico fondato su un’infrastruttura che valorizza sempre di più i dati digitali ha preso la forma di un monopolio che sta diventando sempre più potente.
L’ascesa dei nuovi gatekeepers del digitale
Su questo, l’analisi di Quintarelli torna di nuovo utile e centrata: che questo capitalismo sia il frutto di nuove configurazioni di produzione materiale o che sia “immateriale”, il risultato è che ha comunque prodotto dei nuovi monopoli. La caratteristica di questo capitalismo digitale è la tendenza al monopolio, alla concentrazione di potere computazionale, che l’autore chiama “info-plutocrazia” e che altri autori come Van Dijck chiamano più semplicemente “platform society”.
Il libro torna utile nel finale, quando si pone domande sulle questioni politiche sollevate da questo assetto monopolistico e predatorio di questo nuovo capitalismo “friction-less”, senza le tradizionali frizioni tra capitale e lavoro. Quintarelli ha colto la caratteristica fondamentale di questo passaggio, la re-intermediazione di nuovi gatekeeper che si sostituiscono ai vecchi. Internet ha disintermediato all’inizio, quando ha ri-aperto mercati chiusi. Ora che però non esiste più internet, ma solo ecosistemi chiusi, piattaforme proprietarie oligopolistiche, i nuovi padroni della rete hanno re-intermediato gli utenti fuggiti dagli intermediari precedenti e piano piano ci siamo resi conto che i nuovi capitalisti non sono migliori dei precedenti. È un ciclo classico, che secondo Tim Wu (The Master Switch, 2011) si ripete periodicamente nella storia degli imperi della comunicazione: un nuovo mezzo di comunicazione viene appropriato per fini sociali dalle persone, poi qualcuno lo trasforma in un mercato, poi il mercato si satura e nessuno può più entrare finché non arriva una nuova tecnologia e apre un altro mercato.
Come ri-aprire questo ecosistema chiuso in cui siamo caduti ed evitare che abbia impatti troppo devastanti sulla democrazia e il welfare?
La risposta di Quintarelli è di ripensare una nuova politica per l’immateriale, ispirata dai principi delle democrazie liberali europee: una via che si allontani sia dall’anarco-capitalismo della Silicon Valley sia dal modello dirigista cinese. Mentre in questi giorni negli Stati Uniti Elizabeth Warren propone di “rompere Facebook” e di tornare ad applicare severe norme di Anti-Trust, Quintarelli non crede in opzioni così drastiche, ma è per soluzioni tipicamente mercantiliste: più mercato, più competitività, minore concentrazione dell’informazione. Auspica un pacchetto complessivo di provvedimenti da parte delle istituzioni europee: nuove forme di fiscalità, innovazioni nel welfare, nei diritti dei lavoratori e dei prestatori professionali, controlli pubblici di garanzia per i consumatori, aumento della concorrenza, interoperabilità dei servizi. Effettivamente la proposta dell’interoperabilità dei servizi, che risolverebbe il problema del “lock-in” ampiamente descritto nel libro, rappresenta una soluzione probabilmente efficace contro i monopoli digitali.
Ma se anche si rompesse il monopolio di Facebook e avessimo più opportunità di scelta nei servizi digitali, basterebbe questo per rendere migliori le nostre democrazie? Può essere utile provare a rendere i mercati più democratici, competitivi e meno concentrati ma la salute di una democrazia non si può misurare solo dalla salute dei suoi mercati. Servono regole non solo per governare Facebook (come l’ultima direttiva EU sul copyright) ma anche per permettere che emerga un ecosistema di piattaforme non orientate al profitto, di natura pubblica o civica, che costruiscano beni comuni digitali e trasferiscano più potere ai cittadini. Inoltre, bisogna valutare l’impatto di queste infrastrutture. Che siano di natura pubblica o privata, queste infrastrutture non sono immateriali, come abbiamo visto sopra. Pensarle immateriali ci solleva dal valutarne l’impatto su ambiente, lavoro e capitale. Se invece pensiamo questo capitalismo digitale, comprese le sue possibili alternative non capitaliste, come materiale, allora dobbiamo porci nuove domande su come ridurne l’impatto ambientale, sulla necessità o meno di utilizzare tutta questa energia, sul tipo di lavoro necessario per mantenerlo.
P.s.: un paio di refusi: Engelbart non è l’inventore degli ipertesti. L’ipertesto è stato inventato da Ted Nelson nel 1965. Inoltre, la ricerca ossessiva di evidenze che possano provare l’ascesa di questa apparentemente nuova dimensione immateriale del capitalismo contemporaneo, porta l’autore, a pag. 20, a sostenere che “esistevano riproduttori digitali di musica anche prima del 2001, ma erano di uso complesso e scarsamente diffusi”. È vero che oggi abbiamo gettato i compact-disc nell’immondizia, ma bisogna ricordare che il CD ha avuto una discreta fortuna, fino ai primi anni duemila. Viene sperimentato nel 1975 e messo in commercio nel 1982, due anni dopo la marcia dei quarantamila di Torino: l’inizio dell’inversione di tendenza nei rapporti tra capitale e lavoro parte da lontano, quindi.







