Asterischi e schwa
Se devo scrivere un’email al “gruppo di persone che si laurea con me” posso iniziarla in vari modi. Per esempio “Cari tutti”, usando il cosiddetto maschile sovraesteso, che però non mi piace, soprattutto se nel gruppo prevalgono le studentesse. Oppure “Care studentesse e cari studenti”, che mi sembra un po’ lungo però rispettoso della presenza di ragazze che altrimenti rimarrebbero nascoste in quel maschile dato per scontato. Fin qui siamo nel mondo cisgender. “Care studentesse e cari studenti”, per fortuna, va bene anche nel mondo transgender, per lo meno quando è binario. Capita però di avere qualche tesista (rara avis, “tesista” è una parola italiana buona per tutti i generi!) che si definisce enby (cioè non-binary) o genderqueer o che comunque in questo momento della sua vita non vuole rispondere a un genere e quindi mi chiede, almeno nel ricevere una lettera, una libertà dall’obbligo definitorio dei pronomi.
La presenza di persone che non si riconoscono in identità binarie chiede alla lingua la tensione di segni grafici nuovi (schwa) o usati in modo nuovo (asterischi). Così, consapevole di fare un torto alla nostra lingua, più binaria di altre e priva del neutro, mi capita di optare per il famigerato “Car* tutt*”. Lo faccio dopo aver preso in considerazione il “Carə tuttə”, preferendo poi il piccolo sole infantile dell’asterisco alla e capovolta dello schwa. Confesso però che sto maturando la convinzione che “cara e caro” potrebbe essere sufficiente: non per ribadire il binarismo di genere, ma contenere, con un po’ di fantasia, tutte le possibilità che abitano, nell’arco teso tra la a e la o, lo spazio tra i due generi.
Tornando allo schwa, impronunciabile per impronunciabile, l’asterisco è un segno grafico più familiare (oddio, quindi forse più “rassicurante”, e questo va bene?). Poi: lo schwa o la schwa? Insomma non se ne esce, troppo zelo rischia di paralizzare la lingua. E se un po’ della mia simpatia per l’asterisco venisse da una barzelletta che mi ha fatto ridere? Gli asterischi organizzano una festa per soli asterischi. Nel bel mezzo del party, mentre tutti gli asterischi ballano, suonano alla porta. L’asterisco padrone di casa va ad aprire e si trova davanti un punto. “E tu cosa ci fai qui? Questa è una festa per asterischi, non puoi entrare!”. “Ma scemo non mi riconosci? Sono Pino, ho messo il gel!”. Accidenti, il mio Super-io politicamente corretto mi segnala che è una barzelletta non inclusiva (come spesso sono le barzellette); di questi tempi sarebbe preferibile un asterisco (un* asterisc*?) che dice: “accomodati e divertiti con noi, qui c’è posto anche per i punti”.
Il dibattito in corso rivela molte sfumature del nostro rapporto con la lingua e la comunità. C’è chi vede flessibilità innovative e chi storpiature finto-inclusive. C’è anche chi, Tiziano Scarpa per esempio (ho ascoltato una sua intervista sulla Radio Svizzera Italiana), è proprio contrario, con argomenti nobili e pur riconoscendo le inevitabili duttilità e gli aggiornamenti della lingua, all’idea che questa debba essere inclusiva, che le parole possano rappresentarci. La lingua, dice, non è mai all’altezza del mondo, è sempre inadeguata. È la posizione di uno scrittore, la capisco: la lingua è una convenzione da piegare alla propria verità, al proprio stile. Come tale ci esclude sempre, e Scarpa dice che quasi invidia chi dalla lingua non è rappresentato. Capisco il discorso, ma è un po’ come chi, potendosi sposare, dice che il matrimonio è una trappola e invidia quelli a cui la legge non lo consente.
Mentre cerchiamo una soluzione tensioni opposte ci attraversano. Per esempio, io vorrei rispettare tutte, tutti, tuttə, tutt*, ma senza compromettere la scorrevolezza della lettura né trasformare una conferenza in una mitragliata di vocaboli capitozzati. Penso che la lingua sia un laboratorio di vita e dunque non mi scandalizzo per le innovazioni, ma confesso di patire la poca agilità espressiva che l’ipersoggettivazione inclusiva richiede. Quando sono tra schwaisti accaniti mi capita di difendere la tradizione e quando sono tra puristi “pro lingua nostra” mi trovo a difendere la vitalità cangiante del linguaggio. Di una cosa sono certo: dico rettrice, dottoressa e ministra e fatico a capire le donne che applicano a sé sostantivi maschili.
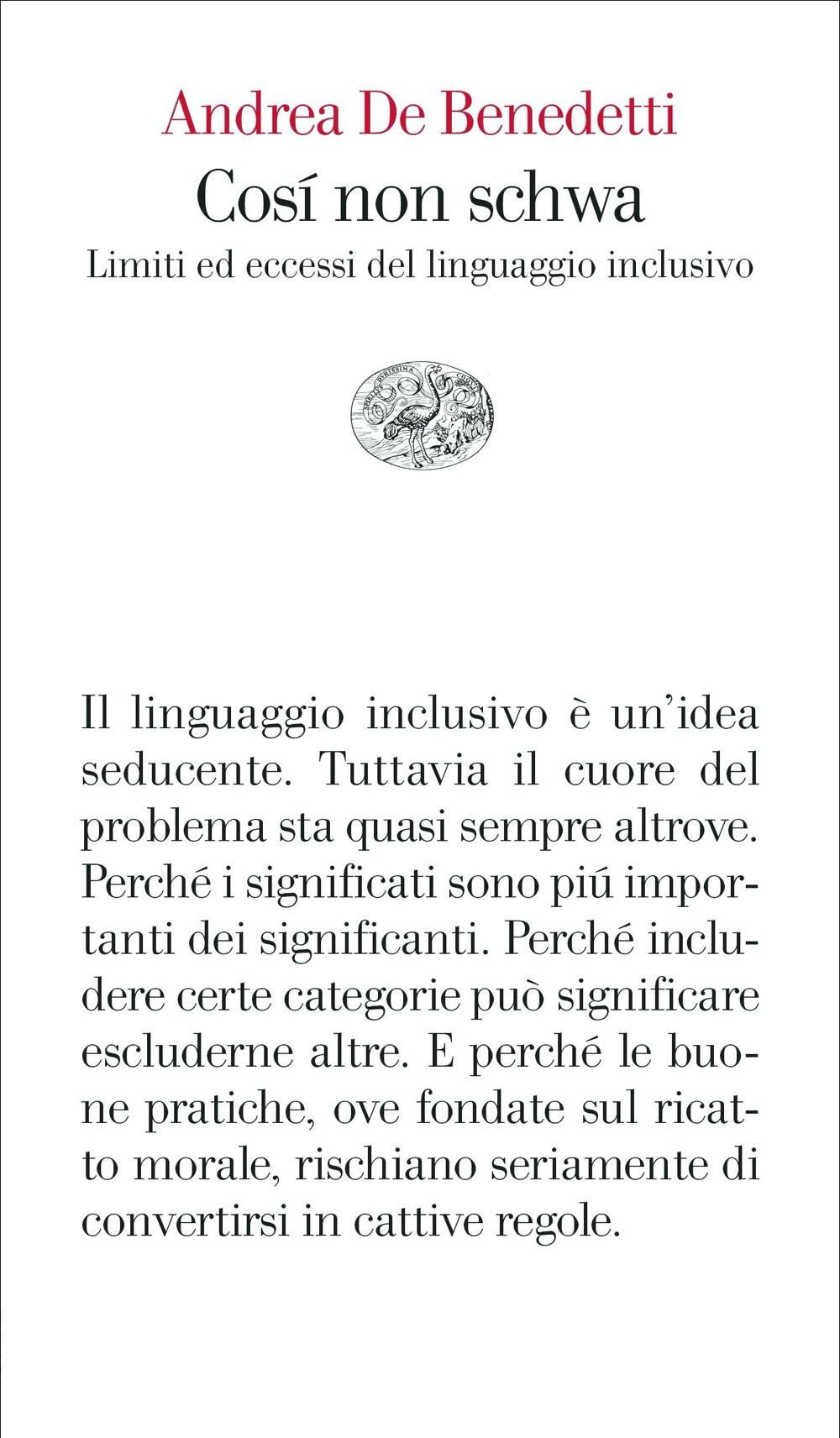
In un saggio dal titolo inequivocabile, Così non schwa, Andrea De Benedetti considera giusta «la battaglia sui femminili dei nomi di professione», e dunque anche lui dice sindaca, ministra e deputata, sostiene però con forza l’uso del “maschile non marcato” o “sovraesteso”, cioè la regola che impone l’uso del maschile plurale per gruppi misti (uomini, donne e enby). Non lo considera una sedimentazione linguistica del patriarcato e sostanzialmente adduce motivazioni pratiche. È una convenzione, dice, un dispositivo morfologico quasi del tutto desemantizzato che aiuta a parlare in maniera snella ed efficace, «senza cancellare le donne dal discorso (al massimo “nascondendole” un po’)» e soprattutto «senza generare disparità di trattamento tangibili (né dimostrabili) nella vita reale». Su questo mi sembra ottimista: «il fatto che anche nei bandi di concorso compaia il maschile non marcato», dice, «non significa che gli uomini abbiano un qualche vantaggio competitivo rispetto alle donne». La tradizione accademica, soprattutto nei posti apicali, è invece piuttosto maschiocentrica, e direi che il maschile non marcato storicamente ha “marcato” molto.
Mi sembra il classico caso in cui linguaggio e società si autoconfermano riflettendosi. Tanto che oggi nelle commissioni dei concorsi devono essere rappresentati entrambi i generi. Persino la Chiesa, credo nel 2020, ha sostituito nella messa la parola fratelli con la formula fratelli e sorelle. Inutile negarlo, da più parti si avverte la necessità di adeguare la lingua a una società più attenta alle sue componenti, una società che non può essere riducibile a un tutto maschile, anche se, come dice De Benedetti, il morfologico non è il sociale. Basandosi sulla distinzione tra dissimmetrie semantiche e dissimmetrie grammaticali, De Benedetti sottolinea che l’uso del maschile non marcato attiene alla seconda categoria e dunque ha valore prettamente formale.
La questione di fondo, per lui, è che è moralista oltre che velleitario pensare di ripulire il linguaggio, anzi può essere un’ipocrita opzione di comodo per lasciare tutto com’è. In sintesi: «il cuore del problema sta quasi sempre altrove», «è molto più facile agire sul lessico che su altri ambiti della lingua», «i significati sono tendenzialmente molto più importanti dei significanti», «includere certe categorie può significare escluderne delle altre», «le buone pratiche, ove fondate su un nemmeno troppo implicito ricatto morale, rischiano seriamente di convertirsi in cattive regole». Non mi illudo che ripensare la lingua sia sufficiente per abolire le ingiustizie e le discriminazioni, ma non ignoro il potere performativo del linguaggio e il suo ruolo nell’influenzare le nostre rappresentazioni mentali.
Quanto ai limiti dello schwa, pur condividendo alcune critiche sollevate da De Benedetti, per rivolgersi alle persone non binarie auspico una soluzione certo difficile da trovare (ribadisco: farle sentire comprese nell’arco M/F però debinarizzandolo nel continuum della sua dimensionalità?) ma che tenga in considerazione le richieste di riconoscimento delle persone direttamente interessate. Non sono invece d’accordo con coloro che criticano chi critica alcuni vocaboli che risultano offensivi, comunque non graditi e senz’altro tristemente connotati. Dice che non è questione di significante ma di significato, non di termine ma di contesto. È vero, ma penso che liberarsi di parole che ledono la dignità altrui sia un passo di civiltà. Possiamo sentirci a nostro agio dicendo “negro”, “giudeo”, “invertito”, “sodomita”? Sono parole, usate fino a ieri, che portano su di sé eredità ingombranti e violente. Siccome le parole producono azioni (dall’hate speech all’hate crime), so bene che non basta proibire un braccio alzato per impedire alle idee naziste di proliferare. Ma quindi se uno vuole entrare in ufficio dicendo Sieg Heil deve poterlo fare?
Chi crede nelle parole sa che il pensiero è fatto anche di parole (dico “anche” perché, Jung e Hillman insegnano, immagini e suoni non sono certo estranei alla costruzione del pensiero). Un’attenzione contemporanea al vocabolario deve essere accompagnata da un lavoro quotidiano nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle case e nei media, perché queste si alleggeriscano del peso del pregiudizio, dell’odio e della paura dell’alterità, della novità, della varietà. Senza invocare una sterilizzazione del linguaggio e consapevole che l’ipersoggettivazione inclusiva rischia di creare proliferazioni espressive infinite, oggi abbiamo il compito di “dialogare con il linguaggio” aiutandolo a evitare parole espulsive che costruiscono capri espiatori oppure che svalutano o ignorano categorie specifiche già messe a dura prova dalla storia. Ha ragione De Benedetti quando ci invita a negoziare «di volta in volta i codici e ruoli tra liberi individui, considerando sempre, insieme ai significanti […], i significati, i contesti, le intenzioni». La sfida, senza perdere di vista contesti e intenzioni, è stare a guardare quali mutamenti reggono nel tempo e quali no, quali entrano nell’uso e quali no. Dobbiamo imparare a stare, senza fanatismi ma anche senza fantasmi, nell’inevitabile sostanza magica e vitale della lingua, nella sua intrinseca alterità, varietà e limiti compresi. Nel frattempo, lei batte dove il dente duole.
Questo articolo è uscito in una versione ridotta su “la Repubblica”, che ringraziamo.







