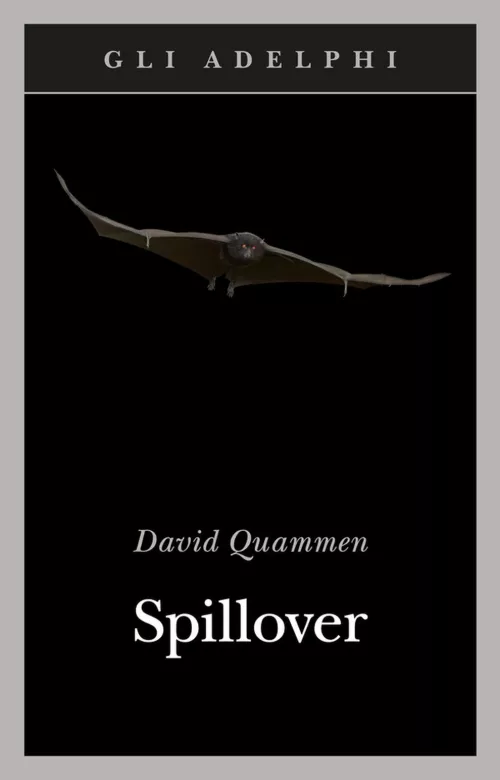Speciale
Dissesto ambientale, disuguaglianze economiche / Quammen: Covid, AIDS e altre epidemie
Solo da poco ho finito di leggere Spillover, il libro di David Quammen di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Uscito presso Norton (New York) nel 2012, era stato pubblicato da Adelphi piuttosto tempestivamente, due anni dopo. La versione italiana ha scelto di conservare il titolo originale, senza dubbio efficace, anche se la bella traduzione di Luigi Civalleri ricorre spesso all’equivalente italiano «salto di specie». D’altro canto, poiché al lettore italiano il termine inglese spillover non poteva dir molto, è apparso necessario aggiustare il sottotitolo. L’evoluzione delle pandemie è dicitura appropriata, e esplicativa quanto basta; ma certo meno precisa e soprattutto molto meno allarmante di Animal Infections and the Next Human Pandemic, che poneva in evidenza il dato a posteriori più clamoroso, cioè la previsione esatta di quanto sarebbe potuto succedere di lì a qualche anno. Il dato più clamoroso, e il più stupefacente: ma solo per i profani, giacché gli esperti discettavano da parecchio tempo del «prossimo disastro», the Next Big One. Che si è puntualmente verificato nell’inverno 2019-2020 ad opera del nuovo coronavirus.
Non entro nei dettagli delle previsioni di Quammen, che suonano come una profezia. Conviene tuttavia sottolineare due circostanze notevoli: 1) non si trattava affatto di una profezia, ma di valutazioni fondate su ricerche scientifiche in corso da decenni; 2) gli esiti di tali ricerche sono stati poco meno che ignorati dai governi, che non ne hanno tratto le dovute conseguenze. Lasciamo ora perdere i governi non democratici, o pochissimo democratici: a non tener adeguato conto dell’allarme che proveniva da solidissimi studi di infettivologi e virologi sono state anche quasi tutte le democrazie liberali dell’Occidente. Di questo non dovremmo sorprenderci. Non è un episodio isolato: le evidenze scientifiche sul surriscaldamento globale e sui catastrofici effetti che ne derivano sono vecchi di decenni, ed è spaventoso il divario fra le tante parole dette e scritte e le concrete misure intraprese. Ma forse c’è un’altra considerazione, meno scontata, che potremmo aggiungere.
Com’è noto, David Quammen non è uno scienziato, è un divulgatore. Ora, sulla parola «divulgazione» pesa una secolare ipoteca limitativa. Divulgativo è spesso qualificato ciò che manca di originalità; quando va bene, si dice di volonterose semplificazioni, da sogguardare con indulgente sussiego; accezioni positive, semplicemente, non se ne registrano. Il problema è la radice «volgo»: divulgare significa diffondere tra la moltitudine, la massa, sprovveduta e manipolabile (tipicamente, ad essere divulgate sono le notizie false e tendenziose), e quindi mai considerata con il rispetto che meriterebbe, nemmeno dove è invalso da tempo il principio della sovranità popolare. Ebbene, a me pare di poter dire non solo che i divulgatori svolgono un’opera di importanza assolutamente decisiva sul piano culturale e politico, ma che i divulgatori davvero bravi sono più rari dei bravi ricercatori. Studiosi di valore, in ogni campo – in primo luogo, in campo scientifico – non ne mancano; pochi sono invece gli scrittori capaci, come Quammen, di esporre gli esiti di complesse ricerche in maniera insieme rigorosa e chiara, efficace ed affabile, talvolta addirittura avvincente. Certe pagine di Spillover non hanno molto da invidiare a un romanzo di Michael Crichton. E infatti Quammen ha avuto moltissimi lettori. Il «volgo», da sempre imputato di passività e incapacità di scelta, sceglie, eccome: lo dimostra, in altro campo, lo straordinario successo sul web dello storico Alessandro Barbero, che alle competenze dello studioso unisce capacità comunicative di prim’ordine (a parte i sorprendenti numeri degli ascolti, è sintomatico che sia diventato oggetto di riuscite parodie).
Oltre alle preziose, irrinunciabili virtù della divulgazione, bisognerebbe anche parlare – questa volta soprattutto per le scienze naturali – delle presenti lacune nella formazione scolastica. La didattica delle scienze è la cenerentola in ogni settore scientifico-disciplinare: tant’è che a occuparsi di didattica è soprattutto chi non è riuscito a farsi strada nella ricerca. Non è questa la sede per entrare nei dettagli (che peraltro investono direttamente l’organizzazione del comparto universitario); mi limito a ribadire un punto. Senza bravi insegnanti di materie scientifiche (alcuni ci sono, ma dovrebbero esserlo tutti) la formazione scolastica è carente, e la democrazia è mutila: perché una cittadinanza ignara dei fondamenti della cultura scientifica non è in grado di decidere con cognizione di causa, e quindi di agire per il (proprio) meglio. L’Italia ha bisogno più che mai di docenti capaci non solo di impartire nozioni di matematica, fisica, chimica, biologia, ma di far capire alle nuove generazioni che il loro futuro dipende dalla possibilità che i risultati della ricerca scientifica non rimangano lettera morta. E che posizioni di vertice non vengano occupate, come purtroppo accade in alcune grandi democrazie di oggi, da incompetenti vanesi e irresponsabili.
Ma qualcosa di specifico su Spillover vorrei pur dire. In questi mesi sono state richiamate e commentate soprattutto le parti che hanno a che fare con i coronavirus, come la Sars e l’aviaria. A mio avviso merita invece un’attenta riflessione il lungo capitolo dedicato all’AIDS, perché dall’epoca in cui divampò quella che allora fu battezzata «la peste del secolo» sono passati ormai quarant’anni, e la storia di quell’epidemia è stata ricostruita in maniera molto accurata praticamente in ogni sua fase. La ragione è che alcune acquisizioni decisive sono state raggiunte molto dopo che l’allarme sulla diffusione del virus Hiv-1 era uscito dai radar dell’attenzione mediatica: ad esempio, il fondamentale contributo del microbiologo canadese Jacques Pépin The Origins of AIDS è uscito solo nel 2011.
In sintesi, la storia è questa. Il salto di specie dell’agente patogeno ha avuto luogo nel 1908 nel Camerun sud-orientale, presso una delle popolazioni che (ahimè) considerano una prelibatezza, propria anche di certi rituali tradizionali, la carne di scimpanzé. L’ipotesi più plausibile è quella del cosiddetto «cacciatore ferito»: basta una scalfittura su una mano o su un braccio perché possa verificarsi un contatto sangue-sangue, non tanto durante la predazione vera e propria, quanto nella macellazione dell’animale ucciso. Il virus Hiv-1 si è poi diffuso, essenzialmente per via sessuale, lungo il bacino del fiume Congo, fino alla cosiddetta palude di Stanley (oggi palude di Malebo), su cui si affacciano le città di Brazzaville e di Léopoldville (oggi Kinshasa), allora rispettivamente capitali del Congo francese e del Congo belga. La trasmissione sessuale, di per sé, sarebbe lenta e limitata, ma a favorire il virus sono stati due fattori contingenti: l’incremento demografico, che ha favorito l’urbanizzazione, e l’introduzione di pratiche sanitarie moderne, come le massicce campagne contro la malaria, la sifilide, la malattia del sonno, per cui venivano usate siringhe non sempre sterilizzate. Dopodiché intervengono fatti di ordine più strettamente politico. Quando il Belgio si ritira (piuttosto precipitosamente) dalla sua colonia africana, la maggior parte dei bianchi, tutti componenti della classe media, preferiscono tornare in Europa. Le conseguenze sono enormi: nel 1960 non c’è in tutto il Congo un solo nativo africano laureato in medicina. Per far fronte all’emergenza, le organizzazioni internazionali – ONU, Unesco, OMS – lanciano un appello: mancano insegnanti, tecnici, medici, infermieri. Benché la filantropia esista, non ci si poteva certo aspettare una mobilitazione di massa da parte di agiati professionisti di Parigi, Ginevra o Montréal. E infatti a rispondere sono soprattutto cittadini di più o meno remota ascendenza africana che vivono in un paese francofono afflitto da una dittatura, cioè Haiti: sono svariate migliaia gli haitiani che si trasferiscono in Congo.
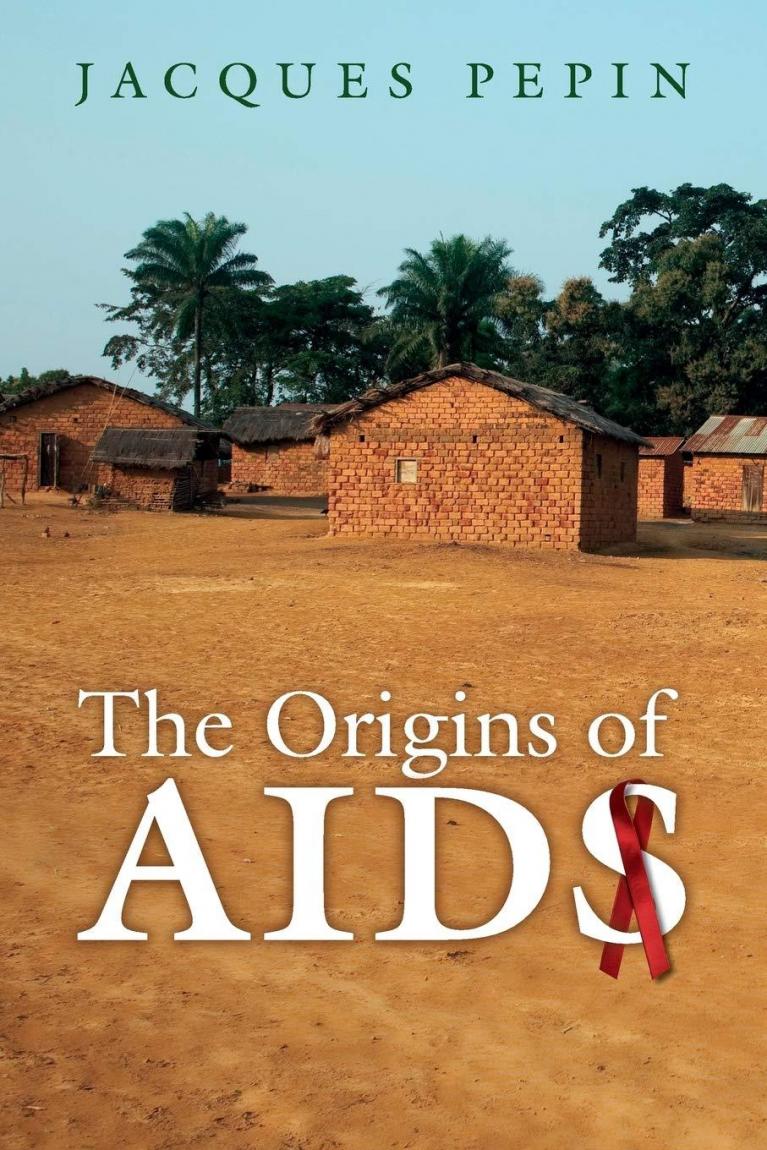
Pochi anni più tardi, però, un colpo di Stato dà avvio anche in Congo (ora ribattezzato Zaire) a una dittatura, e gli stranieri, mal tollerati, tornano nei rispettivi luoghi di provenienza. Qualche migliaio di haitiani infetti bastano a spiegare la successiva diffusione del virus negli Stati Uniti? No: a intervenire è un’altra circostanza. Da sempre chi non ha nulla si riduce a vendere il proprio corpo; e fra l’antica prassi della prostituzione e la moderna atrocità del commercio di organi esiste anche la donazione mercenaria di sangue. La allora recente invenzione della plasmaferesi, che separa la parte liquida del sangue da quella corpuscolata, rendeva possibile subire frequenti salassi senza diventare anemici. Risultato: all’inizio degli anni Settanta una società statunitense insediata a Port-au-Prince, la Hemo Caribbean, esporta negli USA da Haiti ogni mese 5-6000 litri di plasma congelato. E a questo punto ci sono tutti i presupposti perché esploda l’epidemia fra i sottogruppi sociali che conosciamo: i politrasfusi (per lo più emofiliaci), i tossicodipendenti che si scambiano siringhe infette, i maschi gay dalla vita sessuale molto promiscua.
Ora, la cosa più istruttiva in questa vicenda è la pluralità di dimensioni coinvolte. Non manca nulla: i mali del colonialismo e i guai della decolonizzazione, la cultura ancestrale dei nativi e la tecnologia moderna, i regimi dittatoriali e il sottosviluppo, il nazionalismo e la cooperazione internazionale, la distruzione degli ecosistemi e il disagio sociale all’interno del mondo industrializzato, gli effetti collaterali del progresso della medicina e lo sfruttamento economico della povertà. Quale insegnamento ne dobbiamo trarre? Molto semplicemente, che la globalizzazione da conquistare è quella dei nostri orizzonti mentali. Perché la pandemia più grave, nel mondo attuale – tale il punto d’arrivo di Spillover – è quella di Homo sapiens.
Non occorre indugiare su numeri che tutti più o meno conoscono. La popolazione umana sulla Terra ha superato i 7,7 miliardi. Ma quello che impressiona è la rapidità della crescita. Non solo quella in corso – fatevi un giro sul sito worldometers.info per averne un’idea – ma quella avvenuta negli ultimi tre o quattro secoli, o meglio, negli ultimi 10 o 20 mila anni. In termini ecologici, un’esplosione incontrollata. Una catastrofe.
L’unico motivo che impedisce di abbandonarsi al pessimismo più cupo è che gli umani, a differenza dei batteri e dei virus, sono capaci di ragionare. E di conseguenza possono adattare il proprio comportamento alle necessità, senza dipendere dalla roulette delle mutazioni genetiche e dalla mannaia della selezione naturale. «Un essere umano», scrive Quammen nell’ultimo capitolo di Spillover, passando in rassegna le zoonosi degli ultimi decenni, «può scegliere di non bere la linfa di palma, di non mangiare scimpanzé, di non mettere il recinto dei maiali sotto un albero di mango, di non liberare le vie aeree di un cavallo da corsa a mani nude, di non fare sesso non protetto con una prostituta, di non drogarsi con una siringa usata, di non tossire senza coprirsi la bocca, di non salire a bordo di un aereo se non si sente bene», eccetera.
Ma evitare di commettere imprudenze non basta. Per evitare che la catastrofe travolga anche la nostra specie, come di norma avviene nelle epidemie – gli agenti patogeni si moltiplicano a dismisura, poi crollano repentinamente – è più che mai necessario ragionare in termini globali. Innanzi tutto prendendo serie misure di tipo socio-sanitario, finanziario e organizzativo. In un articolo sul «New Yorker» dell’11 maggio, rapidamente tradotto da Adelphi nell’ebook Perché non eravamo pronti (pp. 24, € 1,99), Quammen cita quanto aveva scritto il virologo Ali S. Khan in The Next Pandemic (2016): «ricerca sul campo finalizzata alla scoperta di nuovi virus; vigile monitoraggio degli spillover; sistemi per produrre test diagnostici rapidamente e in gran numero; migliore capacità di risposta da parte delle strutture mediche; filiere agili per la produzione e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e dei respiratori, e programmi coordinati per spostarli da una giurisdizione all’altra; pianificazione coordinata tra città, Stati, province, nazioni e agenzie internazionali per contenere infezioni catastrofiche; educazione della collettività per rafforzare la disponibilità generale a sopportare il distanziamento sociale e il controllo della quarantena; migliore amministrazione della sanità pubblica e cicli di finanziamento sicuri; e, cosa più cruciale di tutte, la volontà politica di assumersi il rischio di sostenere le spese per una preparazione di cui forse non ci sarà bisogno».
Ma oltre a tutto questo, occorre che si agisca risolutamente su due fronti: il dissesto ambientale e le diseguaglianze economiche. Nelle popolazioni che muoiono di fame e di sete in un altro continente, nelle foreste distrutte all’altro capo del pianeta, è in gioco il nostro futuro comune. Sta a noi non solo evitare piccoli gesti imprudenti che nella loro banalità possono risultare pericolosi qui e ora, non solo preparaci nel modo migliore ad affrontare la prossima pandemia, ma anche adeguare le nostre priorità alle condizioni attuali del mondo, e ad esse informare le nostre strategie, il nostro modello di sviluppo, le nostre gerarchie di valori.
Molti, in questo tempo di pandemia, hanno parlato di guerra. Altri hanno sollevato obiezioni tutt’altro che infondate. Una guerra, il Covid-19? Tanto per cominciare, questa tutto fuorché imprevedibile malattia sarebbe meglio chiamarla Sars-2, così da ricordarci che non avevamo colto il campanello d’allarme della Sars-1. E poi, a mio avviso, no: non è una guerra, è una cosa diversa. È un’apocalisse. Auguriamoci che sia vissuta davvero come tale, secondo una laica etimologia della parola: cioè come una rivelazione. La rivelazione di uno stato di cose che a questo punto sarebbe davvero stolto ostinarsi ad ignorare.