Birds aren't real / Fake News e paranoie
Pasquale Palmieri:
Ho ricevuto nelle scorse settimane questa testimonianza da Francesca Beretta, che vive e lavora negli Stati Uniti da più di un decennio. Insegna lingua e cultura italiana, lavora a una tesi di dottorato sulle strategie educative per formare e informare la Generazione Z, in una delle università pubbliche più importanti del paese (UT Austin).
È lecito chiedersi se i fenomeni raccontati da Francesca ripropongano schemi consolidati o acquisiscano nella nostra epoca una loro specificità, anche alla luce delle possibilità comunicative che la tecnologia ci offre. La storia e le scienze sociali ci offrono indicazioni importanti in tal senso. Le ansie cospirazioniste non sono certo un’invenzione del nostro tempo. Sono riapparse in diverse epoche e in diversi contesti geopolitici, rivelando in ciascuna occasione delle sfumature inedite. Tuttavia non possiamo negare di aver assistito negli ultimi anni all’emersione di un’insofferenza diffusa contro le élites che si è tradotta in un complottismo tanto dilagante da riuscire a permeare diversi aspetti del nostro vivere comune.
Per spiegare le tendenze in atto, gli studiosi hanno fatto spesso ricorso a concetti universalizzanti come la “paranoia” o la “nevrosi collettiva”, che tuttavia stentano a far emergere le peculiarità dei singoli casi. Come ha scritto Ignazio Veca in un recente libro dedicato alla finta “congiura” contro il pontefice Pio IX del 1847 (La congiura immaginata. Opinione pubblica e accuse di complotto nella Roma dell’Ottocento, Carocci 2019), l’esplorazione delle “oscure profondità dell’animo umano” non è sufficiente a comprendere il fenomeno. Non siamo di fronte a una “ripetizione meccanica della fallacia percettiva” delle masse, descrivibile con formule atemporali. La fede nei complottismi ha invece una sua storicità: è il frutto di una prassi comunicativa che riesce volta in volta a trasformarsi in strumento di lotta politica, dando voce ai sospetti e ai timori circolanti nella popolazione, orientandoli verso obiettivi precisi (se ne parlava già qui).
La tensione semplificatoria ci spinge spesso a parlare di “webeti”, “analfabeti funzionali”, “scappati di casa”. Spingiamo il complottista all’esterno del corpo sociale, guardando alle sue congetture come forme di pensiero magico o sopravvivenze di antiche superstizioni. Ci affidiamo inoltre al determinismo tecnologico, ripetendo compulsivamente che sarebbe “colpa di internet” o “colpa dei social”. In tal modo neghiamo l’importanza della politica e della comunità, dimenticando che “l’educazione e le reti di relazioni costruite attorno a valori condivisi sono più importanti degli strumenti in sé (leggi qui). In definitiva, rifiutiamo di inserire le fantasie cospirazioniste un dispositivo di potere visualizzabile con percorsi di ricerca condivisi. Lo stesso dualismo rigido fra vero e falso non offre sbocchi costruttivi, soprattutto nell'uso strumentale che ne fa la propaganda politica. Quest’ultima ha tutto l’interesse a produrre divisioni manichee della realtà: non tende a facilitare lo sviluppo di idee complesse o contrapposte, ma al contrario bada soprattutto a dividere il mondo fra sinceri e bugiardi.
Questi spunti metodologici ci tornano utili proprio nell’analisi della vicenda di Peter McIndoe raccontata da Francesca Beretta. La straripante avanzata della fantasia cospirativa denominata Qanon – lo ha sottolineato anche Wu Ming 1 nel volume La Q di complotto (Alegre, 2021) – è andata di pari passo con la crisi delle democrazie occidentali, e si è rafforzata nei mesi della diffusione del contagio da Covid-19, avvalendosi anche delle instabilità emotive generate dalla reclusione forzata. Le disuguaglianze sociali preesistenti si sono aggravate, palesando una situazione insostenibile per molti cittadini e screditando i messaggi di unità diffusi dai poteri costituiti.
Le incertezze economiche e sanitarie si sono velocemente tradotte in sguardi angosciati verso il futuro e nella ricerca di occulti responsabili contro i quali dirigere la rabbia sociale. Si tratta di un fenomeno articolato che sfugge da qualsiasi spiegazione semplificante e che ha trovato nei racconti di QAnon un’efficace via di espressione. Il loro potere persuasivo è trasversale sul piano sociale, generazionale e culturale. Secondo recenti indagini statistiche, il 16% degli americani reputa quelle narrazioni “in gran parte vere” (“mostly true”). Si tratta di circa 52 milioni di persone, senza considerare che tanti altri le ritengono parzialmente vere o verosimili: un numero di seguaci più che sufficiente per far fallire qualsiasi campagna vaccinale, ma anche per destabilizzare interi sistemi politici e favorire esplosioni di violenza difficili da controllare. Vale dunque la pena di sottolinearlo, anche se può apparire scontato: la riespolosione delle tensioni razziali, l’assalto a Capitol Hill, il recente turbinio di notizie incentrate sull’invasione dell’Ucraina non sono problemi mediatici, né frutto di psicosi collettive, bensì questioni innestate nei delicati equilibri economici, culturali, morali, e religiosi del nostro mondo.
Le parole di Francesca vanno lette con attenzione: offrono infatti la possibilità di riflettere sul rapporto fra politica, società ed ecosistemi mediatici. Lascio quindi a lei la parola.
Francesca Beretta:
Ciao Pasquale,
ti mando qualche riga su una storia che ha catturato negli ultimi mesi la mia attenzione. Si tratta di un burdél, uno di quei ragazzi su cui ci interroghiamo discutendo della Gen Z nelle nostre classi. Il suo nome è Peter McIndoe. È un giovane influencer di 23 anni. Nell’ultimo dei suoi post social, Peter ha lanciato una macumba all’indirizzo di Taylor Lorenz, una giornalista del “New York Times”, che gli aveva dedicato un intero podcast.
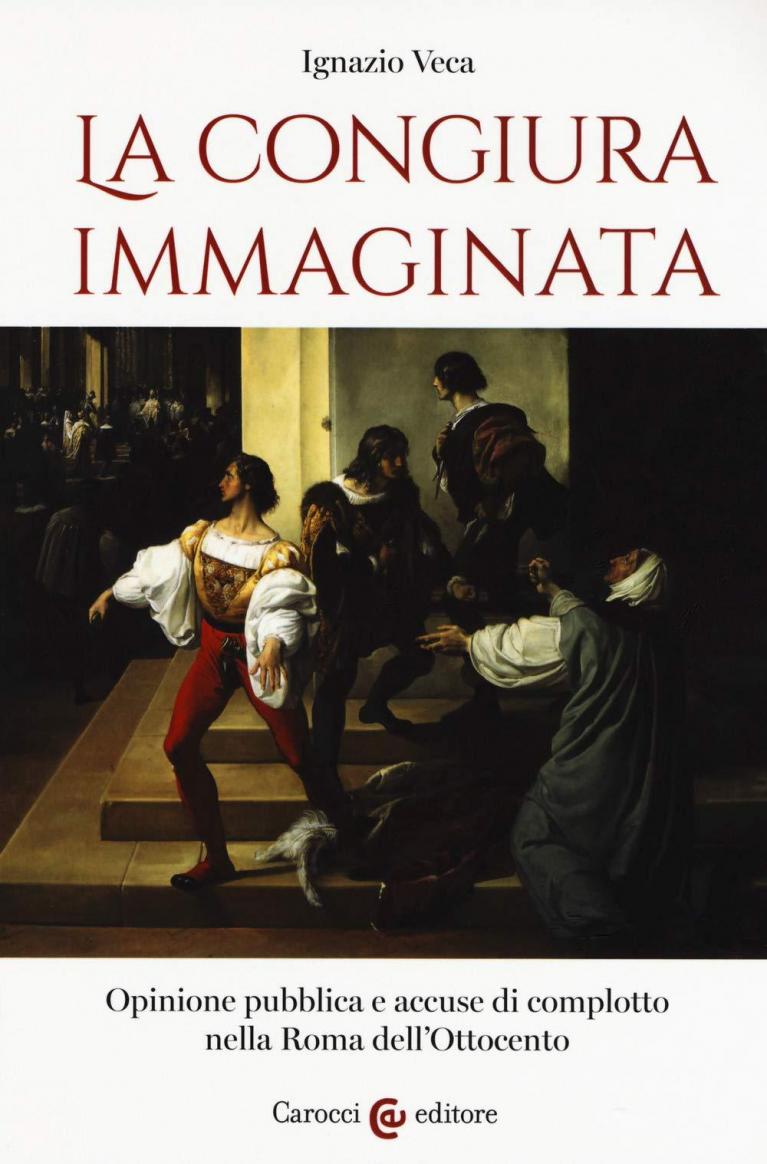
Stando alle notizie riportate da Lorenz, le cose sono andate più o meno così. Peter nasce e cresce con sette fratelli in una famiglia religiosa e conservatrice nella periferia di Cincinnati, Ohio, prima di trasferirsi nelle praterie dell’Arkansas, dove il padre è assunto dalla congregazione. Niente scuola. Il timore è che lì gli facciano il lavaggio del cervello per conto del governo toccando temi considerati eretici, come l’evoluzione della specie. Pertanto l’istruzione a casa è la soluzione più prudente. Nonostante famiglia e comunità tentino di preservarne l’anima, a 10 anni Peter rivela al proprio pastore di non credere in Dio, diventando un “indemoniato” in una comunità di (auto)emarginati. Nel momento di buio si rivolge a YouTube, da cui apprende che là fuori è tutto diverso da come gliel’han sempre raccontata. Eccola lì, una finestra virtuale sulla realtà, nel suo mondo cospirazionista in carne e ossa da cui riesce a evadere fisicamente nel 2016 quando si iscrive al college. Fine atto primo.
Gennaio 2017. Durante una breve visita a un amico a Memphis, Peter si ritrova nel mezzo di una marcia femminile contro il neo eletto Trump, apertamente ingiuriata da repubblicani soddisfatti che si trovano in zona. Striscioni e segni di protesta ovunque. A quel punto Peter pensa che sarebbe divertente avere un cartello che non abbia nulla a che fare con la diatriba politica, anzi, che non abbia proprio un senso. Stacca un poster ormai datato, lo gira e ci scrive poche parole: Birds aren’t real – gli uccelli non sono reali. Si unisce alla controprotesta pro Trump e inizia a scandire ad alta voce il suo nuovo slogan. Succede tutto molto in fretta. C’è chi gli domanda che cosa significhi e su due piedi Peter inventa di essere parte di un movimento cinquantennale secondo cui gli uccelli non sono reali. Fra i cori delle folle contrapposte, una donna lo filma mentre urla che piccioni e aquile non esistono. Già, perché dal 1959 al 2001 il governo americano si è reso autore del genocidio di oltre 12 milioni di uccelli e li ha sostituiti con droni di sorveglianza sotto mentite spoglie. Un Orwell moderno, alla portata di tutti, che finisce sul news feed di Facebook.
In centro a Memphis iniziano a comparire graffiti e scritte, sugli spalti delle partite di football nelle high school s’intonano cori: Birds Aren’t Real prende vita. Nel frattempo Peter, tornato fra i banchi della University of Arkansas, assiste affascinato all’escalation. Decide di creare un account Instagram dove si ricala in pieno nel personaggio inventato per caso in un giorno d’inverno e inizia a postare “notizie” surreali. Ad esempio, mette in guardia i bagnanti poiché i gabbiani, appena ricablati dal governo, riescono ad assicurarsi i dati di carta di credito e numero di sicurezza sociale con uno sguardo. L’account diventa virale a livello nazionale e, con l’aiuto di alcuni amici, Peter costruisce e condivide storie sempre più dettagliate. Spiega come fanno gli uccelli a sembrare reali, come atterrano, come producono uova che paiono vere. Arricchisce la sua spericolata costruzione intervistando un fantomatico membro della CIA, in realtà interpretato da un attore, che conferma il genocidio aviario.
Il seguito social aumenta, così come il numero di condivisioni e la richiesta della fan base di poter rappresentare il movimento tramite merchandiser: cappelli, magliette, adesivi, slogan come “Birds-watching goes both ways” (“il birdwatching è reciproco”) or “If it flies, it lies” (“Se vola è una bugia”) sono i tratti distintivi della bird brigate (la brigata degli uccelli), che cresce a vista d’occhio. Peter abbandona gli studi, mentre i suoi followers diventano un movimento di antiprotesta nelle strade. Intervengono anche nella manifestazione contro l’interruzione della gravidanza svoltasi nelle strade di Cincinnati, sull’onda della promulgazione della legge antiaborto in Texas ad opera del governatore Abbott. I cartelli con foto di bambini mutilati lasciano presto spazio a quelli della bird brigade con cori annessi a favore degli uccelli.
La brigata, reale e virtuale, è composta in buona parte dai membri della cosiddetta Generazione Z. Nati approssimatamene tra il 1995 e il 2010, i giovani della Gen Z non hanno mai sperimentato una realtà senza consumo tecnologico. Più fiduciosi nei rapporti online che in quelli di persona, rappresentano forse la coorte più empatica, visionaria e globalmente consapevole di tutti i tempi, con una scintilla per cambiare il mondo. Per la Gen Z americana, la maggior parte delle discussioni sui problemi correnti avviene online, in uno spazio digitale dove si sentono visti e compresi ma che, allo stesso tempo, provoca forti livelli di ansia e depressione verso il mondo reale, percepito come insidioso (come hanno scritto anche Corey Seemiller e Megan Grace: “Understanding Generations”, The Gen Z Hub, 2021). Tutto quello che conoscono è il mondo post 9/11, quello del terrorismo globale, della crisi finanziaria, della staffetta Obama-Trump, di George Floyd e Breonna Taylor, del Covid, della violazione russa in Ucraina. Vorrebbero che il mondo fisico intorno a loro, la famiglia, la scuola, l’università, favorissero conversazioni sui temi caldi di cui leggono quotidianamente online e invece si trovano a sbattere contro una più prudente cultura del silenzio che sbandiera ai quattro venti principi di uguaglianza e inclusione ma che poi, sul piano pratico, appare come un’inutile e vuota retorica buonista.
Ed è così che la Gen Z trova un appiglio nelle forme di comunità offerte dalla tecnologia, spesso tacciata di plasmare tuttologi farneticanti. Nelle parole di Peter, Birds Aren’t Real è uno specchio terapeutico di quello che è la società odierna, una sorta di spazio sicuro nel caos, un igloo nel mezzo di una tempesta di neve, al riparo dal mondo delirante dei grandi.







