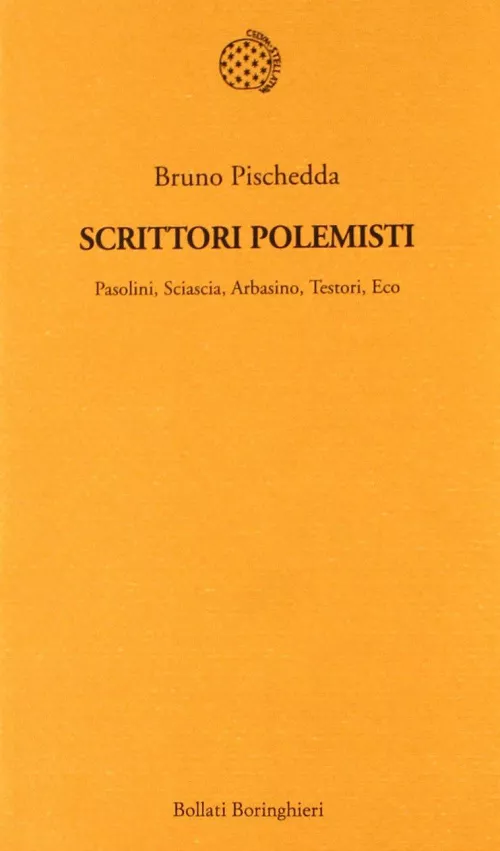Sulla crisi culturale / Ci mancano sì gli intellettuali (non tutti)
Ho sempre creduto (e anche scritto: Scrittori polemisti, Bollati Boringhieri 2011), che gli intellettuali, specialmente se di area umanistica, siano da valutare con un occhio di riguardo alle individualità: cioè non complessivamente, ma partitamente. E che questo esame sia da condurre in base a una triade fondamentalissima di coordinate: 1 – Che cosa esattamente dicono, nel rispetto dei contesti di enunciazione e nulla omettendo, in modo che emerga, quando c’è, una linea conti-nua di ragionamento. 2 – In che modo lo dicono, ossia rivolgendosi a chi, secondo quali strategie espressive, nella convinzione che anche le accortezze retoriche o la disposizione e scelta degli argomenti partecipino del contenuto. 3 – A quale ti-tolo lo dicono, avvalendosi cioè di questa o quella fonte di autorevolezza, necessaria per qualunque presa di parola in pubblico non riducibile al rango di una occasionale opinione (per esempio un partito, una chiesa, un ruolo istituzionale, in quanto persona indipendente ma che gode di fama e rinomanza).
Volendo allargare il panorama a scienziati, economisti, giudici ecc. ora aggiungerei un punto 4: Che cosa materialmente fanno: costruiscono l’atomica a favore di tizio o di caio, oppure no, o abiurano, emettono sentenze accettabili o meno, teorizzano politiche di spesa a favore di questi o quelli. Si applicano, in so-stanza, sulla base di un sapere qualificato ma senza che questo specifico sapere predetermini la loro utilità oppure la loro nocività rispetto all’ecumene dei consimili. Parlare, esortare, vaticinare è già un fare, ma poi ci sono comportamenti che obbligano in maggior misura, determinando la vita di ciascuno.
Da un secolo e mezzo a questa parte: dal caso Dreyfus – quando si afferma il termine – sino a oggi, gli intellettuali hanno dato prove molto difficilmente riducibili a un comune denominatore. C’è chi ha vagheggiato un partito degli intellettuali, appunto; chi li ha considerati la punta avanzata sul fronte del progresso e del bene comune; chi li ha investiti di un carisma che – proprio perché sciolto da ogni consuetudine con il potere – consente anche nelle circostanze più ingrate o minoritarie di attingere al vero, magari divinandolo (risparmiatemi i nomi). Ma resta il fatto che l’intellettuale ha esercitato le proprie prerogative su una scala di contenuti e di comportamenti massimamente diversificati. Si può andare dall’eroismo, dal sacrificio personale dinnanzi a dittature che svariano nei colori e nei modi, sino all’opportunismo più bieco o alla diretta assunzione di responsabilità in circostanze deprecabili. Nemmeno il «parlare fuori dal coro» o il proporsi come figura «eretica» – secondo una facile e biunivoca retorica – garantisce la qualità e la positiva incidenza di un pensiero: tutto sta nel situare la voce solista o nel caratterizzare con precisione l’ortodossia a cui si vorrebbe sfuggire.
Sia pure in dimensioni ridotte, prosastiche, è quanto vediamo in questi gior-ni pandemici, frequentati di buona lena da storici, filosofi bio-politici, psicologi nicciano-junghiani, ermeneuti dell’Inizio, della Fine, del Kathékon, che non perdono occasione di smarcarsi – platealmente – dispensando abissali sciocchezze. È ben vero che i modelli intellettuali, i testi di studio, gli Auctores trascelti, inci-dono poi nella qualità del pensare. Un po’ più di Hume e un po’ meno di Heidegger o di Nietzsche può fare sempre comodo nel valutare le contingenze del caso.
Ma anche a queste latitudini nulla si può prefigurare in senso ultimativo. Non ci sono «scuole» o filogenesi culturali che possono garantire la giustezza o il buon esito delle conseguenze che se ne traggono: ognuno è padre e figlio di se stesso, così nei meriti come nelle colpe. Beninteso, non mi sfugge affatto che gli intellettuali, come qualunque altra categoria di persone, sono soggetti a forme più o meno organizzate di egemonia. Forme distintamente individuabili, che rendono possibile una proficua e anche robusta storicizzazione del discorso: egemonia filosofica, cattolica, fascista, marxista, liberale-liberista, supposte autonomie indipendenti. In ogni caso il criterio della responsabilità individuale persiste, quali che siano i vincoli o le angustie in cui ciascun operatore titolato pensa. Anzi, prendendo spunto da alcune farneticazioni attuali, si potrebbe dire che quanto più i tempi volgono al peggio, tanto più è necessario un rigoroso discrimine tra le fila di coloro che posseggono o che si annettono sensibilità civiche.
C’è però anche un diverso ordine di problemi, che riguarda la costituzione dei saperi – delle competenze, degli specialismi – a fronte di una sormontante voga anti-intellettualistica, di un malinteso livellamento «egualitario» secondo il quale avrebbero un identico peso i pareri formulati da intellettuali dedicati e da commentatori avventizi: gli uni presuntamente in possesso di un’episteme a carattere sistematico, gli altri latori di una doxa che seppure ragionevolmente orientata è da ritenersi occasionale. Anche in questo caso il tema è ben vivo, e se ne occupa con acume appassionato Franco Brevini nel recente Abbiamo ancora bisogno degli intellettuali? La crisi dell’autorità culturale, Cortina 2021.
Il libro si basa su un’ampia e diversificata platea di contributi (discipline filosofico-letterarie, scientifiche, informatiche, statistiche, psico-sociali, socio-economiche), fornendo a conti fatti un pregevole esempio di specialismo multilaterale. Ne viene una sorta di ibrido, o di Trattato-Pamphlet, forse di impronta anglosassone, che di rado e comunque a fatica è frequentato dai saggisti nostrani.
Al centro della discussione stanno le ultime derive a cui si concederebbe l’universo massificato, interclassista, cosmopolita, reso Uno per tramite delle pratiche internettistiche a cui sovrintendono una manciata di oligopolisti. Il protagonismo sempre più accentuato delle moltitudini informatizzate, dice Brevini, e la crescente diffidenza nei confronti dei «custodi» di ieri, sta conducendo alla «revo-ca dell’autorità sociale» per i «soggetti dispensatori e mediatori del sapere» e, di riflesso, a un illanguidirsi progressivo «del sapere stesso». Un fenomeno che l’autore anziché temere o subire stoicamente si sforza di fronteggiare con l’unico me-todo consentito a un intellettuale: la ricerca dei suoi presupposti storici e la coniugazione virtuosa delle molteplici ragioni dalle quali s’ingenera.
Decisivo per esempio è il quadro economico determinatosi dopo decenni di convulso liberismo. Non solo disparità abissali ne sono discese, ma blocco delle promozioni sociali (il cosiddetto «ascensore», che nel cuore del Novecento aveva pure consentito a quote significative di proletariato l’approdo a una sia pur minima condizione di borghesità materiale). E ancora ristagno delle politiche per l’istruzione, marginalità periferiche, frustrazioni di qualunque disegno individuale rivolto al futuro. È quasi ovvio che da simili scompensi sorga, dice Fukuyama, una risposta risentita (a Politics of Resentment), che porta a diffidare di qualunque autorità costituita, ivi compresa l’autorità intellettuale comunque identificata. E allo stesso modo andrebbero considerate le campagne politiche volte per un verso alla neutralizzazione dei conflitti (di classe, di gender), ma contemporaneamente intese a una sovranità identitaria, agonistica, intollerante.

Da tutto questo e da altro ancora è motivata la diffidenza e quasi il rancore verso i latori di un sapere ufficiale; e di contro, da tutto ciò nasce il bric-à-brac eteronomo, il proliferare delle informazioni fasulle o non sufficientemente vagliate; l’incomodo primato dell’«internettuale», l’«anoressia culturale e bulimia bufalesca». L’inarrestabile e anche salutare proporsi di un protagonismo diffuso – sia pure limitato a immateriali piazze informatiche – non può coincidere con la sovversione di qualunque episteme: proprio qui anzi, nell’ingrossarsi del numero e nel mescolarsi caotico delle opinioni, si rende più necessaria la funzione specialistica e intellettuale. «Nei regimi democratici – dice Brevini – è giusto che a vincere sia la maggioranza, ma sarebbe fallace credere che lo stesso criterio valido nell’ambito della politica debba valere anche in quello della scienza e della cultura, che invece hanno tipicamente a che far con fenomeni qualitativi».
Aleggiano su tutto il discorso le riflessioni di Tocqueville, critico acuto del-la democrazia ma al tempo stesso suo strenuo sostenitore, dopo il tramonto cruen-to e irrecuperabile dell’Ancien régime (cosa che i teorici della destra antimoderna solitamente dimenticano). Brevini ha un’esatta cognizione del problema, anche se ci sarebbe da discutere riguardo a talune espressioni fin troppo recise, quasi sloganistiche: per esempio «il Super-Io [costrittivo, di ieri] ha ceduto il passo a Narciso»; come se la cura del Sé, e la sua valorizzazione, appunto ieri appannaggio positivo di pochi, diventi una menda intollerabile quando passa in capo alle moltitudini. Oppure «fiumane interclassiste»; o «individualismo di massa» da considerarsi alla stregua di un ossimoro, quando basterebbe sostituirlo con «individualismo per tutti» così da ottenere una più esatta rappresentazione del fenomeno.
C’è qualche punta nostalgica di troppo in un testo come Abbiamo ancora bisogno degli intellettuali?: i rimpianti per le toghe, per le cattedre rialzate, per il Liceo ideato da Gentile, la memoria veneranda per alcune figure di accademici già ai tempi della nostra giovinezza fuori tempo massimo; insomma le distanze da ripristinare tra docente e discente, la lacrimuccia versata sullo smarrirsi di un «millenario ordine gerarchico». La stessa convinzione sopra ricordata, per cui non solo nel campo della scienza, ma anche in ambito culturale latamente inteso debbano valere criteri qualitativi, lascia spazio a qualche perplessità. Per quanto condivisibile nei suoi massimi termini, l’asserto sembra scampare a una delicata tematizzazione come quella dei gusti, dei gusti in conflitto come espressione delle disparità sociali, su cui ci ha intrattenuto decenni orsono Pierre Bourdieu.
A riguardo gli odierni Hommes de Lettres non hanno meditato abbastanza, e soffrono, considerando che il loro parteggiare autorevole per Meneghello, Morante, Sciascia o Tabucchi non controbilancia adeguatamente i successi plebiscita-ri tributati a Camilleri, poniamo, o meglio ancora a Sveva Casati Modignani, a Moccia, a Fabio Volo. Il nostro autore, in questo senso, si presenta come un intellettuale mitemente revolté, a cui sta a cuore senza dubbio l’uguaglianza giuridica dei cittadini, meno la legittimità paritaria nelle scelte culturali, ma comunque di orizzonti democratici e se mai in ansia per il predominio dei populismi.
Tra le molte pagine interessanti a cui mette mano, spiccano d’altronde quel-le dedicate al rapporto tra autorevolezza intellettuale e nuovi ambienti comunicativi: tra competenze riconosciute e «disintermediazione» degli accessi, tramite cui appena ieri sembrava disegnarsi un orizzonte culturale più intensamente partecipato. Le cose poi non sono andate – non stanno andando – esattamente così. E non dovrebbe stupire. Sempre in un regime orientato al profitto le utopie ingenera-te dalla modernità sono destinate a realizzarsi in maniera insidiosa, sfigurata. Abbiamo ancora nelle orecchie i peana che i primi teorici della Rete avanzavano in termini di democrazia adempiuta, saperi rizomatici, disponibilità globale dei contenuti, superamento dei ruoli stabiliti (prosumers). Tutti auspici che in breve tem-po hanno preso corpo, ma in modo da suscitare più critiche che soddisfazioni.
«Con il Web 2.0 – dice ancora Brevini – è stata spazzata via la separazione tra produttori e utenti di cultura, che era uno dei pilastri dell’autorità culturale». La ragione algoritmica – su cui si regolano le piattaforme più frequentate – ha dato luogo a un tipo nuovo di sollecitazioni, del tutto diverse da quanto dispensavano gli specialisti del ramo, ma non meno vincolanti. Sollecitazioni mosse non già da giudizi oggettivi, ma dalle scelte formulate in precedenza dai clienti stessi; ciò che ha reso Amazon con tutte le imprese affini di e-commerce il più influente critico letterario del nostro tempo (se vogliamo stare alla letteratura). L’ingresso sulla scena di un automatismo algoritmico come il recommendation item-based collaborative filtering, un tipo di calcolo Item-to-Item, ha determinato un sensibile allontanamento dall’alterità ancora insondata, rigettando l’utente in un mondo autoconcluso, verrebbe da dire autistico. A questi patti la «disintermediazione» promessa si sta rivelando poco più che una chimera. Gli oligopolisti del Web le hanno poco per volta sostituito una loro, potentissima intermediazione, a base di ragioni economiche tradotte in essere da una intelligenza artificiale. Di qui un evidente restringimento delle responsabilità individuali, al momento della scelta, la messa in sordina di qualunque voce «terza», e un aumentato controllo.
È forse eccessivo sostenere che «lasciata a se stessa la Rete produce aberrazioni». Accanto agli inconvenienti di ordine dirigistico le vanno riconosciute anche alcuni pregi: il sensibile ramificarsi della distribuzione quanto ai prodotti di cultura, la tutela del mercato per i piccoli editori, l’aumento, e non la diminuzione, della biblio-diversità. Ma certamente con la Rete sono mutati i parametri fondamentali tramite cui un intellettuale può esercitare il proprio ruolo. Come sarà – si domanda infine Brevini –, dove starà il nuovo Tersite, personaggio omerico non nobile, però dotato di «qualche Megawatt di pensiero critico» e capace di de-nunciare le azioni inconfessabili e i soprusi dei grandi eroi? Domanda pressante, da girare a futurologi più agguerriti di noi. Basta dire al momento che è una figura necessaria, irrinunciabile anche nei tempi odierni, ma fintanto che si adatta con adeguate tecnicalità e riflessioni al diverso ambiente comunicativo.
Sarà come sarà, e non valgono rimpianti; tuttavia un precetto ciascuno di coloro che aspira a una funzione intellettuale dovrebbe «stamparsi» bene in testa, così da scansare impennate d’orgoglio e inevitabili ricadute frustrate: «un’informazione passa se il destinatario, a torto o a ragione, si convince che quell’informazione sia importante e valga la pena di essere presa in considerazione».