Trichophiala incognita / Lo strano caso di una falena namibiana
Il 31 di marzo del 1873 il naturalista ed eploratore svedese Gustaf De Vylder lasciò Città del Capo sul piccolo e veloce veliero Florence diretto a Port Nolloth, 300 miglia a nord sulla costa atlantica. Dopo un viaggio di tre giorni, il veliero giunse a destinazione il 3 aprile. Port Nolloth era un piccolo villaggio portuale che si era ingrandito nell’ultimo anno, dato che da qui partivano le piste verso i territori più settentrionali in quella che oggi chiamiamo Namibia. Allora questa vasta terra era conosciuta come Africa del Sud-Ovest, delimitata a nord dai fiumi Kunene e Okavango e a sud dal fiume Orange, e fiancheggiata dall’immenso deserto del Kalahari a est e, a occidente, dalla sottile striscia del deserto dipinto del Namib che scivola con le sue altissime dune direttamente nell’Oceano Atlantico meridionale. De Vylder era partito dalla Svezia nel 1871, grazie ai fondi messi a disposizione dal governo svedese, con l’intenzione di esplorare l’Africa australe e di raccogliere esemplari di fauna e flora in quelle lontane regioni. Dopo un lungo soggiorno a Città del Capo, il naturalista svedese decise di salire a nord in questa grande e magnifica terra, naturalisticamente parlando, in gran parte sconosciuta. Seguì itinerari noti, senza aprire nuove vie, e raccolse in abbondanza esemplari di ogni genere e specie.

Passò molto tempo nella Damaraland, la parte centro-settentrionale dell’Africa del Sud-Ovest colonizzata dai tedeschi che si estendeva dai fiumi Swakop a sud sino a Windhoek e Ugab a nord dove toccava la Ovamboland. Era quello il territorio originariamente dei Damara, una delle popolazioni di etnia e lingua Herero che da secoli abitavano quelle terre. Nei suoi tre “Giornali” di viaggio, De Vylder descrisse le sue avventure in Africa del Sud-Ovest con grande dettaglio, registrando così i reperimenti di insetti, scorpioni, millepiedi e animali vari. È solo, tuttavia, negli ultimi trent’anni che questi manoscritti furono recuperati, trascritti e tradotti in inglese.

Venni a conoscenza del signor De Vylder per caso tornando da un viaggio attraverso la magnifica, desertica e rossa Namibia. Ero andato in quel remoto paese per cercarvi insetti e soprattutto quella cimice gialla e nera che vive esclusivamente sulla pianta fossile del deserto del Namib, la welwitschia, una sorta di mostruosità aliena strisciante della famiglia delle gimnosperme che parrebbe quasi giunta da un altro pianeta e che vive in quelle lande desertiche. Trovai la cimice dall’improbabile nome di Probergrothius angolensis senza fatica durante quella missione poiché le piatte piante di welwtischia, alte non più di una spanna e larghe qualche metro grazie alle foglie striscianti che si diffondono a raggiera, ne ospitavano a decine.


Ma è meglio andare per ordine e tornare all’inizio del viaggio quando mi trovai una sera in un lodge sperduto sulle colline aride ad acacia, erbacce e cespi spinosi alti due metri che guardano da est la capitale Windhoek. Faceva fresco a 1700 metri di altitudine e il silenzio era interrotto solo da qualche verso di uccello e da lontani grugniti. Cenammo abbondantemente con carne di kudu in compagnia dei membri di quella spedizione naturalistica e Piscopo, che era di solito molto sobrio nelle sue cose, si inebriò con una birra di quelle parti, forte e amara, e che, chissà perché, gli piaceva moltissimo in quanto la trovava dissetante dopo il caldo secco della lunga giornata trascorsa. Felice e contento uscì fuori dalla grande stanza del lodge in legno dove avevamo cenato per prendere una boccata d’aria. Restò per qualche minuto al fresco della serena notte namibiana ad ammirare la via Lattea allo zenith; e poi improvvisamente lo vidi rientrare affannato e rosso in volto come se avesse rincorso qualcosa. Mi si avvicinò come un fulmine dicendo di andare a prendere immediatamente retino e vasetti poiché fuori c’erano decine di falene color nocciola grandi come il palmo di una mano. A dir il vero, di retino non c’era bisogno visto che volavano poco e si arrestavano incantate per decine di minuti intorno alle lampade che segnavano i sentieri e sui muri delle nostre capanne in legno dove stavano le luci. Erano grandi parecchi centimetri, in apparenza tutte uguali, seppur con variazioni di colore di fondo: dovevano appartenere tutte ad una singola specie. Posate, ponevano le ali a tegola una sull’altra. La pelosità era evidente e identificammo la specie come probabile membro della famiglia dei lasiocampidi. Infatti, l’aspetto ricordava da vicino quello delle nostrane Macrotylacia rubi e, ci dicemmo, di sicuro qui abbiamo una specie africana della stessa famiglia.

Quella sera ne raccogliemmo una decina, lasciando in pace il resto, ma sui muri e i paletti delle lampade ce ne saranno state un centinaio. Non ne vedemmo più per l’intera missione che ci portò su sino al fiume Kunene e poi giù sino al Namib Naukluft, ma l’ultima sera, quando di nuovo soggiornammo in quello stesso lodge sui colli aridi ad acacia, notammo lo stesso fenomeno: decine e decine di falene, tutte uguali e tutte simili alle nostre lasiocampe. Le fotografammo chiedendoci le ragioni per quell’abbondanza da quelle parti e l’assenza nelle rimanenti aree visitate. Forse il suo ciclo di vita dipendeva da qualche pianta presente solo in quella regione centrale della Namibia, o forse le lampade di questi lodge emettevano una luce che le attraeva maggiormente. Non ne raccogliemmo che un paio quella sera e ci limitammo a fotografarle.


Alle prime luci del giorno, il mattino successivo, percorremmo tutto il territorio selvaggio che stava intorno al lodge. Notammo una femmina ancora posata su un muro, ma le decine di falene della notte precedente se n’erano andate con l’arrivo all’orizzonte dei primi raggi di sole. Tutto era quieto ora. Esplorai l’area boschiva, camminando tra le acacie, i kudu bush, le spine di bufalo ed altri cespi spinosi, alla ricerca di qualche traccia delle falene, ma non vidi nulla: si nascondevano chissà dove tra la vegetazione di queste colline tondeggianti pronte a uscire la notte alla ricerca del partner per riprodursi e di qualche lampada intorno alla quale volteggiare e godersi poi un po’ di riposo.


Quando giungemmo a casa dopo il rientro dal lungo soggiorno in Africa, per prima cosa andai a cercare le bustine che contenevano quegli esemplari di presunti lasiocampi per prepararli, dato che la curiosità si era impadronita di me e desideravo identificare la specie. Piscopo, utilizzando il vecchio ma importante testo del Pinhey sulle falene africane pubblicato in Sud Africa e risalente agli anni 1970, mi aveva segnalato una specie molto simile, Philotherma rosa, che era, appunto, un lasiocampide. In realtà osservando bene gli esemplari, ora ben preparati con le ali aperte come si conviene, notammo che la nostra falena namibiana era differente in parecchi caratteri morfologici delle ali e anche in parte nel colore di fondo. Cercammo attentamente su internet valutando ogni falena africana reperibile che appartenesse alla famiglia Lasiocampidae senza giungere ad alcuna conclusione. Finii per rivolgermi al grande esperto europeo del Museo di Storia Naturale di Budapest, quello che avevo conosciuto durante una sortita notturna qualche anno prima e che riconosceva straordinariamente ogni specie di falena che giungeva alla lampada. Con il suo fare calmo e pensoso, grattandosi la barbetta incolta, si avvicinava al telo bianco, osservava con grande intensità, e emetteva il suo verdetto: Noctua janthina, Apamea monoglypha, Cyclophora punctaria. L’ungherese riusciva a distinguere le numerose e quasi identiche specie del genere Eupithecia, piccoli geometridi dal sobrio colore grigio-bruno che anche gli esperti di questa famiglia stentano a identificare con esemplare preparato e nella quiete del loro laboratorio. Ebbene, nel vedere la fotografia che gli avevo inviato anch’egli non riuscì a capire di che si trattava. Inviò l’immagine a un grande esperto di lasiocampidi, un entomologo russo che lavorava sia in un’università del proprio paese che in un famoso museo tedesco. La risposta del russo fu entusiasta: “Si tratta – scrisse all’ungherese – di una specie estremamente localizzata e poco nota, di cui non si conosce che la femmina. Il suo nome è Trichophiala devylderi e appartiene alla famiglia di falene tropicali, per lo più afro-asiatiche, degli Eupterotidae. Vale la pena studiare gli esemplari e descrivere per la prima volta la loro morfologia e i genitali”. Dopo che l’amico ungherese mi trasmise il messaggio, contattai l’entomologo russo per avere ulteriori informazioni sulla famiglia e la specie e per valutare che tipo di ricerca fosse necessaria. Iniziò così un’indagine su questa falena nella letteratura entomologica. Su internet, trovai la fotografia della femmina conservata insieme ad altri due esemplari femmina al Museo di Storia Naturale di Stoccolma. Venni a conoscenza del fatto che quelle tre femmine erano gli esemplari originali del grande entomologo svedese Per Olof Aurivillius che la descrisse nel 1879 sulla base del materiale namibiano portato in Svezia da Gustaf De Vylder pochi anni prima.

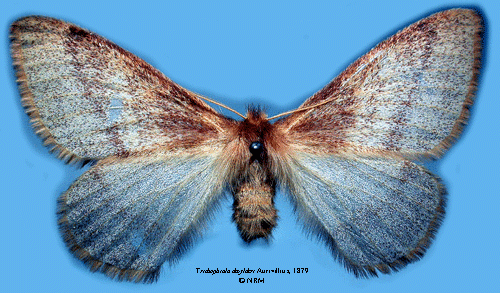
Aurivillius aveva a disposizione solo le femmine e il suo lavoro, apparso su di una rivista svedese del tempo, si concentrò sulla descrizione del solo disegno alare. Il nome imposto di Trichophiala al nuovo genere evidentemente voleva ricollegarsi a quello del genere “cugino” già conosciuto, Phiala, a cui aggiunse un prefisso probabilmente per sottolineare la pelosità della falena. Il nome della specie fu poi una dedica al signor De Vylder. Stranamente, Aurivillius non indicò un olotipo, ovvero l’esemplare che funge da modello e standard per la specie al momento in cui questa viene scoperta, e si limitò a parlare di “tipi” per le tre femmine in suo possesso. Consultai poi alcuni siti internet e musei europei ed africani. Su di un sito dedicato alle falene d’Africa trovai la specie nella lista della famiglia Eupterotidae accompagnata da alcune immagini fotografiche: quella della femmina era la riproduzione della fotografia del museo svedese mentre quelle di due maschi erano chiaramente un errore, trattandosi di esemplari sud-africani appartenenti al genere parente Phiala. Nessuno ne sapeva granché, dunque, neppure i membri della Società Lepidotterologica Africana che richiese, senza successo, informazioni presso i propri aderenti sparsi in tutta l’Africa australe. Contattando vari musei, scoprii che a Berlino si conservavano una ventina di esemplari. A Londra, Copenhagen e Ginevra non se ne sapeva nulla. Dal Sud Africa e dalla Namibia seppi che solo il museo di Pretoria possedeva qualche esemplare, mentre i musei di Città del Capo e di Windhoek non conoscevano la specie. Come si era supposto, davvero non esisteva nulla in letteratura oltre all’articolo originale del 1879 che descrisse la nuova specie.
L’esperto russo, nel frattempo, fece un’analisi accurata della collezione del Museo di Monaco di Baviera e qui trovò una ventina di vecchi esemplari di Trichophiala devylderi. Notò, da esperto qual è di questa famiglia, che alcuni sembravano più scuri e bruni degli altri, chiari e rosati come i nostri, e cominciò a ipotizzare che in realtà potevano esserci in quella collezione due specie diverse entrambe classificate sinora come Trichophiala devylderi. L’analisi dei genitali maschili degli esemplari conservati a Monaco confermò l’ipotesi: vi erano piccole ma significative differenze nell’edeago, l’organo copulatore del maschio, sufficienti per questa famiglia di falene a definire due specie diverse. L’enigma ora era rappresentato dalle femmine. Se quelle originali di Aurivillius sono Trichophiala devylderi per definizione, quali maschi compongono la coppia? Quelli scuri e bruni oppure quelli chiari e rosati? Con l’entomologo curatore del Museo di Ginevra studiammo uno degli esemplari che avevamo portato a casa dalla Namibia.
Iniziò allora una nuova ricerca che, a questo punto, non poteva che essere di natura genetica. Occorreva prelevare il DNA dalle zampe delle falene e inviarlo al laboratorio del museo di Parigi dove sono esperti di questi studi. Così feci e così fecero anche gli entomologi di Stoccolma e di Monaco. Nel laboratorio parigino estrassero il materiale genetico di maschi e femmine, e lo confrontarono per capire se si trattava di taxon diversi oppure della stessa specie che presentava variazioni individuali. Conclusero senza ombra di dubbio che ci trovavamo di fronte a due specie simili appartenenti allo stesso genere ma diverse tra di loro. In altre parole avevamo scoperto una nuova specie in quanto i nostri esemplari chiari e rosati differivano geneticamente da quelli più scuri che corrispondevano alle femmine di Trichophiala devylderi originali di Aurivillius conservate a Stoccolma.
Fu immensa la gioia per aver identificato un nuovo taxon sino ad allora sconosciuto alla scienza. Furono giorni febbrili di letture e di consultazioni per preparare un rapporto scientifico accurato sulla nuova specie e darle un nome che avesse per noi un significato speciale. Decidemmo di chiamarla Trichophiala incognita per sottolineare il fatto che per 140 anni si era mascherata abilmente tra gli esemplari di una specie nota confondendo decine di entomologi e specialisti incapaci di riconoscerne la vera identità.







