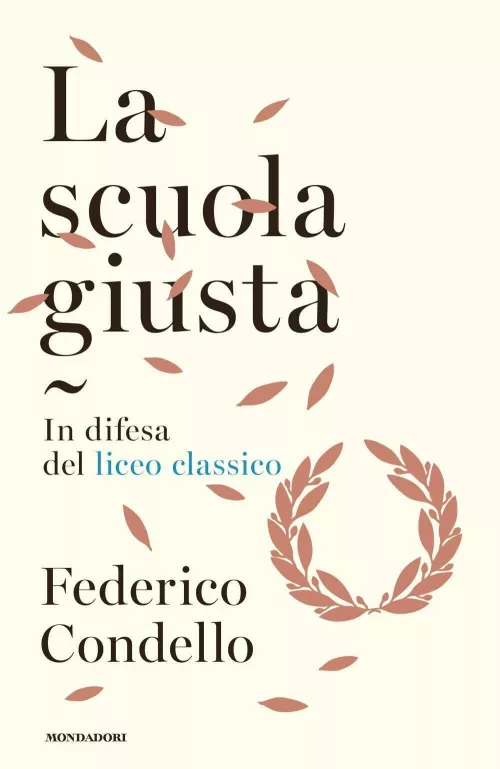Speciale
"Dar da pensare" / Dove va la scuola italiana?
A cinquant’anni dal Sessantotto nessuna profezia di quella stagione utopistica appare più realistica del libro di Mitscherlich uscito in quegli anni Verso una società senza padre. L’immagine della nostra società rispecchia questa assenza, che si manifesta anche nel mondo della scuola, il luogo della socializzazione secondaria, in cui sembra essersi smarrito ogni principio di autorità. Non vorrei essere frainteso e sembrare portatore di nostalgici rimpianti. Non è il caso di desiderare un ritorno a un modello familiare che aveva molti risvolti repressivi, ma ritengo sia necessario affrontare seriamente le cause della perdita oggi di autorevolezza degli adulti e degli insegnanti in particolare, cioè delle figure che in passato suscitavano rispetto e apprezzamento anche per il ruolo che rivestivano nella società. Il libro di Giovanni Floris Ultimo banco (Solferino 2018) è una testimonianza di questo declino, attendibile, anche se di parte, anzi soprattutto perché di una parte in causa che sa comunque guardare a fondo al problema in modo multilaterale.
Che cosa è successo nella scuola?
Certo è sotto gli occhi di tutti, perché alimentato dalla morbosità dei media, il dilagare del bullismo, quando non del cyberbullismo. Non ne conosciamo l’indice di frequenza, ma non possiamo restare a guardare. è inutile denunciare la maleducazione dei giovani, con l’atto censorio dei vecchi. C’è qualche anello che si è rotto nella catena delle generazioni e bisogna con urgenza ripararlo, prima che sia troppo tardi. La scuola è troppo importante per il riscatto del nostro Paese. “Restituire centralità agli insegnanti” – e in questo concordo con Giovanni Floris – “è il primo passo per cambiare la scuola e il Paese”.
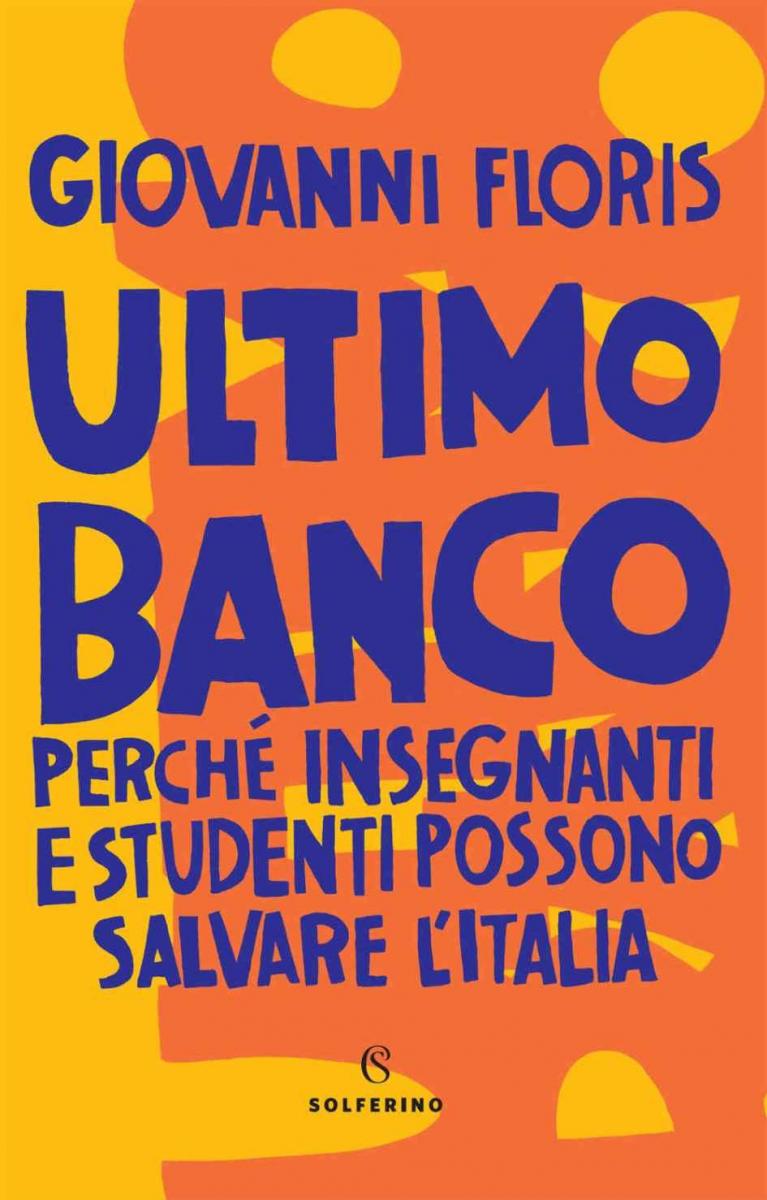
Perché gli insegnanti hanno perso prestigio?
Non è facile ricostruire le cause, non ultima però quel falso egualitarismo (denunciato anche su queste pagine da Bottiroli nell’articolo Promuovere gli asini produrre i bulli), iniziato nella stagione del Sessantotto che ha rinnegato la competenza e che ha favorito il lassismo e la mistificazione (come si può giustificare altrimenti la trasformazione di un quattro in un sei asteriscato?). Le non riforme che si sono succedute non sono state altro che improvvisazioni e smentite, confuse innovazioni mai dettate da un serio e organico disegno generale. Il tentativo di una riforma strutturale dei cicli fatto da Berlinguer si arenò per mancanza di consenso. La riforma non era ben concepita e aveva molti punti contraddittori, ma quella doveva essere la strada. Solo un disegno razionale complessivo, frutto di un meditato e condiviso ripensamento, può giustificare le innovazioni. Altrimenti è preferibile, senza apparire reazionari, salvaguardare l’impianto tradizionale della nostra scuola, che non deve essere soppiantato con affrettate omogeneizzazioni solo perché “l’Europa lo vuole”.
Anche l’attuale moda della valutazione delle “competenze” sta sostituendo non senza problemi il sistema di valutazione delle conoscenze (cfr. tecnica della scuola.it, 6 maggio 2018). Con quale risultato?
Il ripensamento della NAEP, l’INVALSI americana, sembra rimettere in discussione questo modello di valutazione basato sui test e sulla verifica delle competenze specifiche, che penalizza la valutazione personalizzata. Sia ben chiaro: la rimessa in discussione dei test non significa necessariamente rifiuto di ogni sistema di valutazione standardizzato, quale quello delle prove INVALSI, che in Italia hanno la loro ragion d’essere per una comparazione dei risultati a livello nazionale e per uno stimolo al miglioramento. Il sistema di valutazione nazionale ha certamente un’utilità, purché però gli item predisposti siano pensati da team di lavoro che diano garanzia di affidabilità e non di improvvisazione. C’è da chiedersi infatti quali valutazioni intendeva acquisire quel quesito, dato nella scuola primaria (la famigerata domanda n.10, contestata su fattoquotidiano.it dell’11 maggio scorso), al fine di rilevare informazioni sugli studenti di 6-10 anni, che presentava una serie di affermazioni sulle aspettative del futuro (cfr. avrò sempre abbastanza soldi per vivere…), inquadrabili in un modello troppo economicistico (deleterio anche per gli studenti più grandi, cfr. l’articolo di Paolo di Stefano sul Corriere della sera del 18 maggio scorso, p.34 Un buon voto non si paga), lontano da quel mondo dell’immaginario che dovrebbe essere valorizzato nei bambini di quella fascia di età, non ancora appiattiti sul “principio di realtà”. C’è da dire inoltre che, come hanno provato anche alcune ricerche dell’Università del Colorado, i sistemi scolastici basati sulle statistiche dei punteggi finiscono per incentivare un insegnamento basato unicamente sull’obiettivo del superamento dei test e sugli studenti che possono ottenere i risultati migliori. è questa una distorsione di cui si vedono esempi eclatanti nel mondo anglosassone. In quel mondo – e parlo in particolare del Regno Unito – il modello di scuola migliore, che è prevalentemente privato (perché la scuola pubblica rifiuta ogni valutazione individuale), viene determinato dai risultati dei test e l’accesso alle scuole migliori viene predeterminato selettivamente da indici di gran lunga sopra la media nei test d’intelligenza (spaziale, verbale, visuale etc.). Noi siamo lontani per fortuna da queste aberrazioni che intendono la scuola un luogo in cui creare “classi di eccellenza” che non incontrino ostacoli nel cammino di apprendimento. Un’idea di scuola che rischia di produrre un “analfabetismo sociale grave”, perché nella vita reale non ci si ritrova mai solo tra migliori. Ma se quel modello produce una competizione selvaggia e la rincorsa a potenziare le competenze, alimentando il business dei tutor, precettori privati che alzano le loro quotazioni sul mercato della cultura, noi stiamo invece producendo la svalutazione della cultura, lasciando ai Whats App delle mamme, come ricorda Floris, lo strumento per decidere se e quanti compiti è lecito assegnare, se e come si insegnano le discipline, in una deriva populistica che delegittima la competenza professionale. Al centro di tutto nel nostro Paese è certamente la perdita di prestigio dell’insegnante, anche a causa della scarsa considerazione sociale, dovuta ai livelli retributivi inadeguati.
Non si può che partire di lì. Non però come ha fatto la “buona scuola” del governo Renzi immettendo in ruolo molte persone anche ad occupare posti “vuoti”, ma valorizzando la professionalità e allontanando i “fannulloni”. è troppo delicato il compito del docente per non affrontare seriamente il problema del reclutamento, che non può essere determinato solo da un punteggio burocratico. Non voglio arrogarmi il diritto di dare consigli, tuttavia la mia esperienza di scuola mi suggerisce di non affidare la valutazione agli indici di gradimento di genitori e studenti, troppo interessati, ma di non ignorare neppure che il bravo insegnante che svolge con equilibrio il proprio lavoro ordinario riesce a farsi apprezzare da tutte le componenti della struttura scolastica. Ci sono molti rischi di conflittualità nell’introdurre criteri meritocratici come incentivi economici per i più bravi, ma ci sono altrettanti rischi nell’annullare ogni valutazione del merito e del demerito. I dati internazionali suggeriscono che le scuole che possono contare su una maggiore autonomia gestionale, pur nel quadro di una direttiva comune e di un comune standard di riferimento, riescono a funzionare meglio. Ma non è facile prevedere il passaggio dalla burocratizzazione all’autonomia, senza un recupero del senso di appartenenza a una comunità educativa. Il fallimento della “buona scuola” è stato determinato soprattutto dall’assenza di un coinvolgimento diretto dei protagonisti della vita scolastica, che hanno invece subito decisioni imposte dall’alto e vissuto con frustrazione anche i trasferimenti forzati. Le risorse messe a disposizione sono state in parte sprecate, mentre avrebbero potuto essere utilizzate per valorizzare quella progettualità e autonomia che venivano sollecitate. Ma una tradizione burocratica non si cancella facilmente. Per questo sarebbe molto importante che chi è alla guida della scuola apprendesse l’arte della “leadership adattiva”, insegnata con successo ad Harvard, e che chi ne fa parte integrante ritrovasse la passione nella relazione educativa. C’è però bisogno di un disegno complessivo, come quello delineato in Francia dall’uomo di scuola Blancher (L’école de demain, Parigi, Jacob 2016), prima di assumere il ruolo di ministro nel governo Macron. Un piano organico che parta prioritariamente dalla prima infanzia e attribuisca un ruolo fondamentale all’educazione linguistica precoce, come aveva sostenuto oltre quarant’anni fa Tullio De Mauro, tutt’altro che cattivo maestro, come ho cercato di dimostrare nel mio libretto Sull’attualità di T. De Mauro, Il Mulino 2018. Perché l’uguaglianza perseguita da una scuola che voglia essere democratica non può che riguardare il punto di partenza, per poter abbattere precocemente quei gap sociali e quei deficit cognitivi che pregiudicano il successo scolastico all’arrivo. Un successo che non deve necessariamente essere un traguardo identico per tutti (come vorrebbe quel falso egualitarismo che ha prodotto disastri) ma una meta appagante per ciascuno rispetto alle proprie attitudini e alle proprie preferenze, alla fine di un percorso di orientamento, che non può essere delegato a uno spot pubblicitario, ma deve accompagnare tutto l’iter di apprendimento.
Non posso in questo breve intervento pensare di delineare quale dovrebbe essere la riforma generale della scuola: sarebbe velleitario. Ma alcune cose si possono dire. La soluzione organizzativa più razionale, secondo me, è la seguente: a) investimento massiccio di risorse economiche e intellettuali nell’educazione della prima infanzia e riduzione del numero degli alunni per classe; b) anticipo dell’obbligo scolastico a cinque anni con uno stretto raccordo tra scuola materna e scuola primaria; c) una scuola media di rafforzamento delle competenze di base, ma anche di orientamento con un accompagnamento personalizzato; d) un percorso di cinque anni poliedrico, che si avvii alla diversificazione tra una formazione professionale che sappia prevenire la dispersione e il dramma dei neet, per cui sia importante l’esperienza di alternanza scuola /lavoro, e una preparazione liceale che non distrugga quella capacità di inquadramento storico dei fenomeni e di problematizzazione filosofica che è il punto qualificante e irrinunciabile della nostra tradizione formativa. Certo ho molte perplessità sulla sperimentazione del liceo quadriennale, avviata in alcune scuole quest’anno, con il sostegno del MIUR, non tanto perché non condivida l’idea di una conclusione degli studi superiori a 18 anni, come in molti Paesi europei, ma per due motivi, in particolare. Innanzitutto, mi pare grave smantellare un edificio quinquennale ben strutturato con improvvisati percorsi di accelerazione, anche se studiati con innovazioni metodologiche apprezzabili: semmai sarebbe stata più opportuna un’anticipazione dell’obbligo a 5 anni e una revisione dell’organizzazione della scuola media! Un’altra ragione, più profonda, è il rifiuto di assecondare la surrettizia corsa all’eccellenza attraverso il possesso di requisiti come il livello B1 nelle certificazioni delle competenze di inglese.
La scuola italiana non ha motivo di soffrire di complessi di inferiorità rispetto alle scuole europee. Se in passato il liceo classico è stato criticato per il suo carattere elitario, non è il caso di sostituire quel modello con sistemi più insidiosi di sbarramento, che rischiano di essere classisti, visto che le certificazioni hanno costi. Se si restituisce valore allo studio e all’impegno, la tradizione filologica del liceo, rinnovata con il ricco apporto delle discipline scientifiche e tecniche è un modello insostituibile che spesso ci invidiano all’estero. Che fosse e sia La scuola giusta lo lascio dire a Federico Condello, autore di un recente documentatissimo saggio sul liceo classico (Mondadori 2018), ma anch’io non sono lontano dal crederlo, pur riconoscendo realisticamente che non può essere la scuola di tutti. Può essere però la scuola di molti, ancora più “attuale” oggi in un momento in cui la grande sfida di un mondo ipertecnologico che spinge alla specializzazione richiede l’attitudine a interrogarsi, a discutere sempre nuovi dilemmi con approccio problematico, come hanno insegnato gli antichi. Non una scuola parcheggio, né una scuola di nicchia per eruditi, ma una scuola capace di “dar da pensare”.