Antonio Prete / Torre saracena. Viaggio sentimentale nel Salento
Dopo essere stato per decenni trascurato e lasciato ai margini (come Matera), da qualche anno il Salento è approdato in pompa magna sulle mappe del turismo, anche di massa. Quella che una volta era terra prevalentemente di emigrazione, ora è terra di arrivi (clandestini inclusi: terra di transitabilità e di accoglienza, dove l’identità si definisce come costante apertura al diverso) e di ritorni. Molti andati via per lavoro, ora scelgono di tornare, non tanto per nostalgia, quanto perché le opportunità di vita, e la sua qualità, sono diventate attraenti. Poi c’è anche tutto il resto. Che è tanto.
Anche di questo parla Torre saracena, l’opera più recente di Antonio Prete, che fonde insieme narrazione, ricordi d’infanzia, reportage turistico, artistico e sociologico che insieme al paesaggio non trascura di ricordare il lavoro che lo ha formato, la povertà e le rivolte contro lo sfruttamento, un passato ricco di figure note e meno note, di artisti importanti e artigiani non meno grandi, come i creatori delle statuine di cartapesta, gli scalpellini e i decoratori che hanno reso possibile il magnifico barocco salentino. Un personale nostos a quella terra d’origine a cui peraltro l’autore ritorna, oltre che di persona, anche nei suoi libri di saggistica, con un ricordo o un racconto, ogni volta che viene toccato qualche punto particolarmente sensibile o impervio, nei momenti in cui la tensione anche teorica è più marcata.
Il libro si apre con la partenza del giovane Antonio verso il Nord per continuare gli studi, su un treno colmo di migranti che come lui cercano altrove quello che non può dare la terra di origine, dove regna una “povertà diffusa” che fa di tutti i sud un solo Sud, e poi continua con l’incontro con lo sguardo del nuovo (che al nuovo va e dal nuovo proviene) e degli altri che già in passato erano transitati da quei luoghi e vi approdano tuttora, per diffondersi successivamente con le varie forme di memoria, personali e culturali, e con il ritorno sulle cose rimaste uguali pur se in parte mutate.
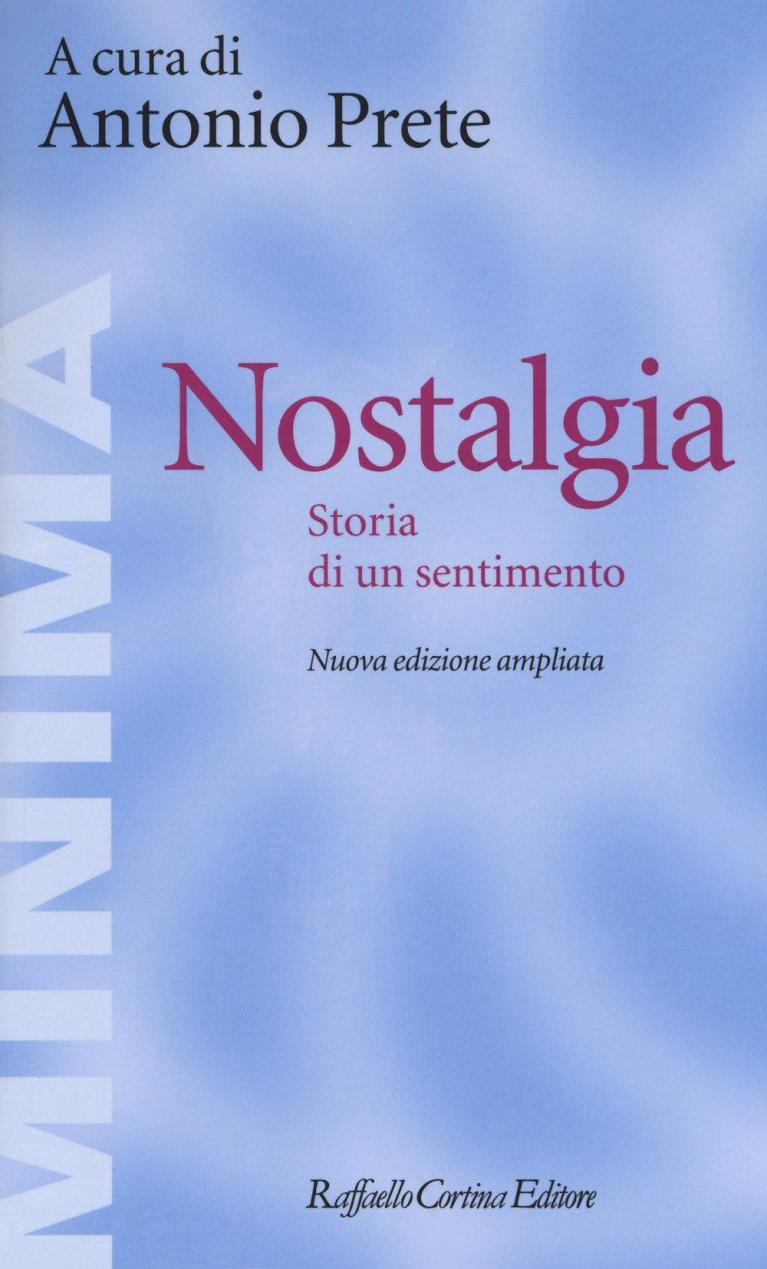
Ma ogni sguardo al proprio luogo, anche quello di chi non si è mai allontanato, è in qualche misura uno sguardo da lontano, perché per vedere occorre staccarsi dalle cose e dai luoghi, dalla loro placenta, e accostarle come oggetti e paesaggio. Si vede quando ci si allontana, fosse pure di un intervallo minimo; ci si allontana per vedere; ci si rende estranei per ritrovare ciò che è nostro e ci definisce. Si va via per tornare. Per tornare a se stessi, se non altro. L’urgenza della comprensione di sé, in Prete (ma dovrebbe esserlo per tutti), è la stessa che muove alla lettura e alla scrittura, all’attenzione verso il mondo. Come dice espressamente in Il cielo nascosto, Grammatica dell’interiorità (Bollati Boringhieri, 2016), “mettersi in ascolto di sé e del testo, lungo gli anni, mi è apparso un compito unico, inseparabile. Il passaggio alla scrittura poteva avvenire solo da questa congiunzione”.
La descrizione della casa è sempre, in qualche modo, quella di uno straniero; è un moto di avvicinamento che è, appunto, un ritorno. L’incontro con il nuovo è incanto, avvolge, colma, basta a se stesso. Non dà luogo a descrizione. Non la contempla. Appena si comincia a descrivere (e a narrare), invece, si è già operato un distacco. Un’interruzione. Una fine. Fosse pure di un attimo, di un millimetro. Resta magari la traccia vaporosa dell’incanto, ma questo è già finito. Si descrive solo dopo dall’intervallo, non solo dopo che distacco c’è stato, ma dal momento che la distanza è stata avvertita, che la fine si è già verificata.
La descrizione allora ha sempre qualcosa della nostalgia. Per descrivere si torna alla cosa, ma si torna a descrivere per averla ancora con sé, per non perderla del tutto dopo che ci si è già allontanati, dopo che già la si è persa. La nostalgia è già nella scrittura. Non caso ad essa, e alla lontananza, Prete ha dedicato dei bellissimi saggi (Nostalgia. Storia di un sentimento, Raffaello Cortina, Milano 1992, nuova edizione allargata 2018 e Trattato della lontananza, Bollati Boringhieri, Torino 2008).
“Percepire, dice Deleuze, significa sottrarre all’immagine quello che non ci interessa, c’è sempre meno nella nostra percezione” (Pourparler, 1990, trad. it. S. Verdicchio, Quodlibet, 2000, p. 61); narrare e descrivere significa invece ridare alla percezione ormai trascorsa la sua pienezza anche attraverso ciò che in origine era rimasto ai suoi margini, grazie alla piega che divide e unisce introdotta dal tempo, che anziché favorire qui uno sguardo critico o ironico, recupera l’emozione passata, quando non la suscita.
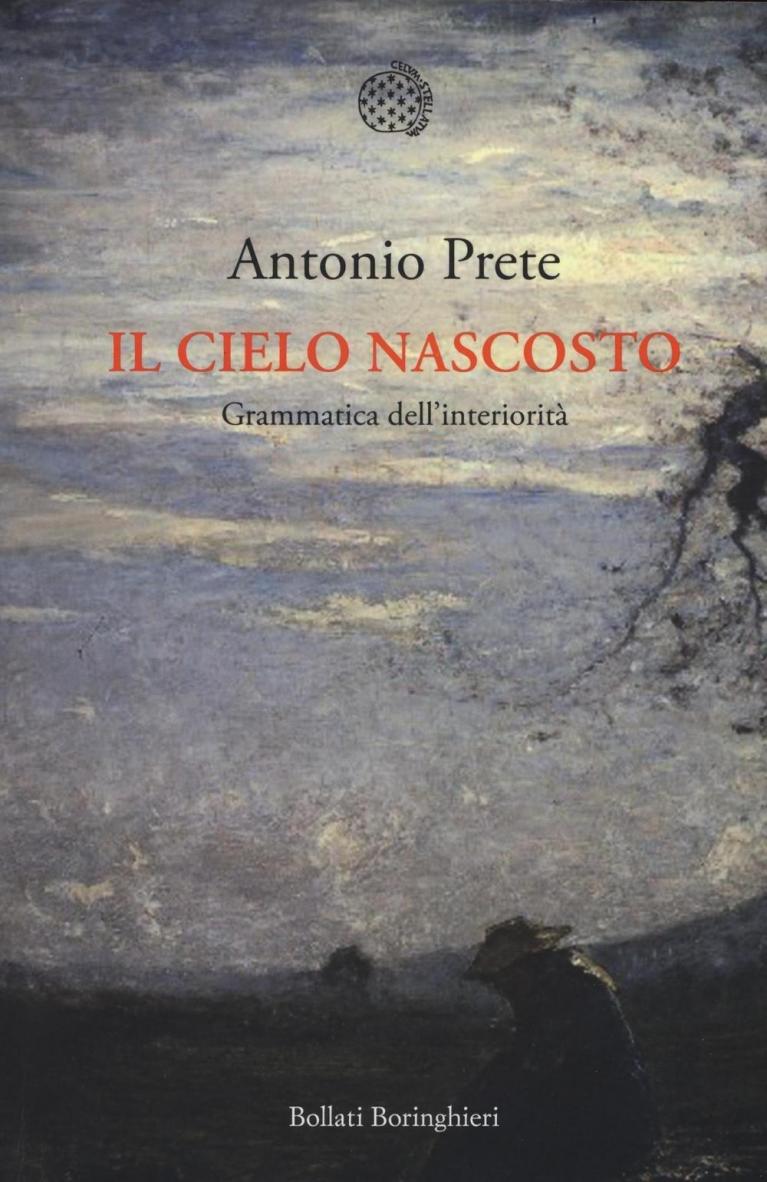
La scrittura di Prete è sempre emozionata: anche nei saggi, nei momenti in cui uno meno se lo aspetta, quando il pensiero si avvicina al punto indicibile oltre il quale c’è silenzio e smarrimento, il tono invece di smorzarsi si accende, scatta il ricordo, l’immagine che si svolge in breve narrazione, in scarto lirico che poi impone il suo passo proseguendo fino al suo diverso limite, dove ciò che solo in quel modo poteva essere detto ha trovato la sua forma, e il discorso, spostato ora più avanti, o di lato, laddove si scopre che un percorso prima invisibile si è aperto, illuminato da questa luce nuova può proseguire. Spesso si tratta di un ricordo d’infanzia o della prima giovinezza, ma una funzione analoga la possono esercitare anche un paesaggio, un’immagine, un quadro, un’architettura, o una fantasia, un miraggio. Qualcosa che in ogni caso non viene ad aggiungersi al discorso, alla riflessione o alla narrazione, ma ne fa parte integrante, ne costituisce il carburante segreto che solo in quei momenti diventa percepibile e irrora però della sua energia, che è sentimento, o passione, ogni altra frase e pensiero in cui il corpo e i sensi sono sempre presenti, imprescindibili.
La passione per i lunghi elenchi (penso, per esempio, a quello delle piante e erbe spontanee in riva al mare del Salento, ma se ne trovano occorrenze ovunque nei suoi scritti sia narrativi che saggistici) in cui ogni voce sembra emanare un profumo, tradursi in un colore, o esprimere la sua fisicità, anche in assenza di ulteriori specificazioni, solo in virtù della successione dei nomi e dei sostantivi, del loro reciproco contaminarsi e della suggestione dell’atmosfera in cui sono immersi, è la stessa di quella per la descrizione di ogni cosa nella sua singolarità, che a sua volta spesso si slarga e dirama nella descrizione minuziosa della singolarità di ogni suo darsi e di ogni sua occorrenza nel ricordo o nell’esperienza. Non si tratta solo di volontà classificatoria, di cura e accuratezza, ma anche di desiderio di preservazione, di conservazione che risponde meno a una finalità pratica e esistenziale, cioè all’eventualità di un suo qualsivoglia uso, quanto piuttosto all’appello della sua stessa consistenza, nel tempo e anche fuori dal tempo: del suo essere proprio così e esattamente in quel momento e luogo. Un magazzino che tale non è, sognato e reale, perché in esso è conservata l’aria stessa della vita, come quello dove sono inscatolati, e in vendita, i fruscii, i profumi, le ombre e i colori di luoghi e momenti specifici, persino con le loro sfumature climatiche, del magnifico racconto “Questioni naturali”, in Trenta gradi all’ombra (Nottetempo, 2004).
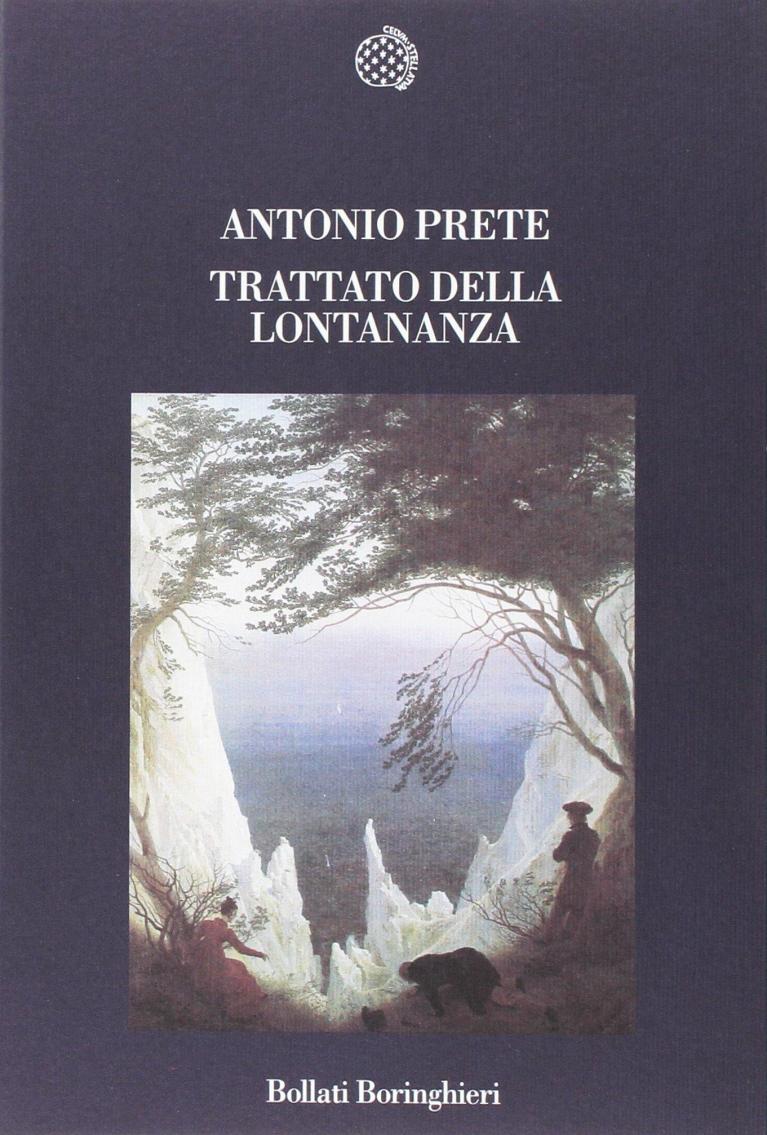
Per Prete “descrivere [è] vivere”, una vera e propria passione che può trasformarsi a volte, ai miei occhi, in eccesso di indugio, e di sottigliezza, che tuttavia accetto volentieri, e apprezzo, come contraltare salutare alla mia impazienza, alla propensione alla sbrigatività e alla fretta che lenta mi consuma. Ma in certi casi si avverte come la volontà di mettere tutto, di saturare, senza tralasciare la minima sfumatura, il più fuggitivo tremolio dell’apparenza, ricorrendo anche a un linguaggio astratto che diventa paradossalmente tanto più indefinito quanto più intende rendere la concretezza degli oggetti e luoghi descritti e degli eventi narrati, così che l’intensità da cui aveva mosso si allenta e la tensione lirica rischia di tracimare nell’esercizio di acume e bravura (innegabile) da cui l’urgenza si è momentaneamente assentata, lasciando di sé solo l’ombra. Colorata però. Fresca, come quella che si trova sotto gli ulivi o in riva al mare.
Talvolta invece si è come di fronte a fotogrammi, con la narrazione ridotta all’osso, quando non assente, senza però che questa assenza pesi. Nei lunghi elenchi di cose, persone, mestieri, fatti di nomi nudi o con qualche minimo dettaglio descrittivo o specificazione, le sensazioni appaiono atomizzate, sezionate fino al limite dell’inconsistenza, messe in fila una dopo l’altra, come resoconti di dissezioni non anatomiche ma sentimentali, dove ogni tratto può portare a una scoperta, gettare una luce su un angolo prima innominato, ignoto, e così accedere a una conoscenza che sarà anche di chi legge.
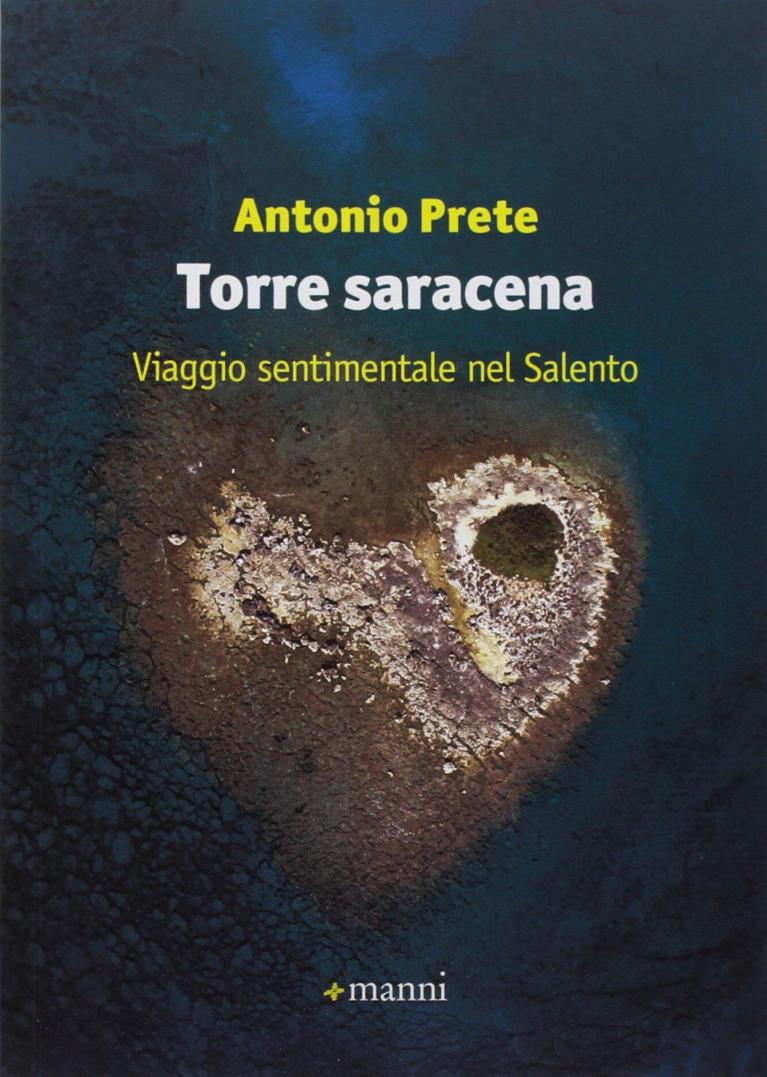
Ma nonostante questa sottigliezza analitica ogni oggetto e ogni spazio e emozione, riconosciuti e nominati, non restano mai chiusi in sé ma rimandano sempre a una fittissima rete di richiami e collegamenti, di altre cose, storie, tempi e libri e opere, e infine a una dimensione cosmologica in cui si avverte il peraltro esplicito magistero leopardiano (basta pensare a tutto lo studio che al grande poeta Prete ha dedicato, a partire da Il pensiero poetante, Feltrinelli 1980, ed. ampliata 2006, fino ai numerosi saggi dedicati allo Zibaldone curato da Fabiana Cacciapuoti edito da Donzelli).
Il cielo, gli astri e anche persino la quotidiana meteorologia (la luna e le nubi, e soprattutto le ombre nella loro vasta fenomenologia), il cosmo e la sua dimensione temporale sono una presenza costante, più che uno sfondo, che inquadra ogni cosa, che in essa trova sempre la sua misura, senza esserne per forza schiacciata, e anzi, spesso, traendo forza dalla sproporzione e riscatto dal proprio nulla.
Molte delle pagine migliori di Torre saracena, ma vale anche per gli altri suoi libri, sono quelle in cui Prete si affida alla propria inclinazione alla “libera divagazione ed erranza” (nei fatti controllatissima però), che nel ricordo e nelle sue associazioni e riverberi sul e, a posteriori, dal presente trovano l’impulso e la materia. Memorie che sono anche letterarie, come se niente potesse arrivare se non attraverso le parole e le forme, “di là dal bivio tra ermeneutica e libera fantasticheria”, o meglio, dal confine in cui si può ascoltare, come a Otranto tra Oriente e Occidente, lo scambio incessante tra quei due mondi, la loro sovrapposizione, se non proprio la loro fusione, tra il “silenzio della natura, da una parte, [e] il rumore affannato e sanguinoso della storia, dall’altra”, che lungo le coste del Salento par di sentire a ogni svolta del paesaggio e a ogni torre a difesa dei saraceni che guarda il mare, con la stessa sorpresa e meraviglia di Prete bambino e dei suoi amici che un tempo le scoprivano nelle loro corse in bicicletta.

Walter Benjamin opera una distinzione tra chi viaggia in città straniere e esotiche e chi le descrive da nativo, il primo che viaggia nello spazio, il secondo anzitutto nel tempo, così che “il libro di viaggio scritto dal “nativo” avrà … una certa affinità col libro di memorie”; “tuttavia come negare che nell’evocare quella lontananza nel tempo si faccia esperienza di un’estraneità e di uno spaesamento analogo a quello che prova il viaggiatore in terre nelle quali non è vissuto?” La descrizione dei luoghi “senza un piccolo viaggio nel tempo, sarebbe come una frase priva della sua sintassi. O come una musica priva del suo ritmo.”
È questa musica che si avverte sempre in questo libro, una sintassi che assegna alle cose il loro posto e ruolo, e al contempo le tiene insieme nella varietà dei suoi toni e dei suoi ritmi e le fa vivere.
Antonio Prete, Torre saracena. Viaggio sentimentale nel Salento, Manni, 2018, p. 158







