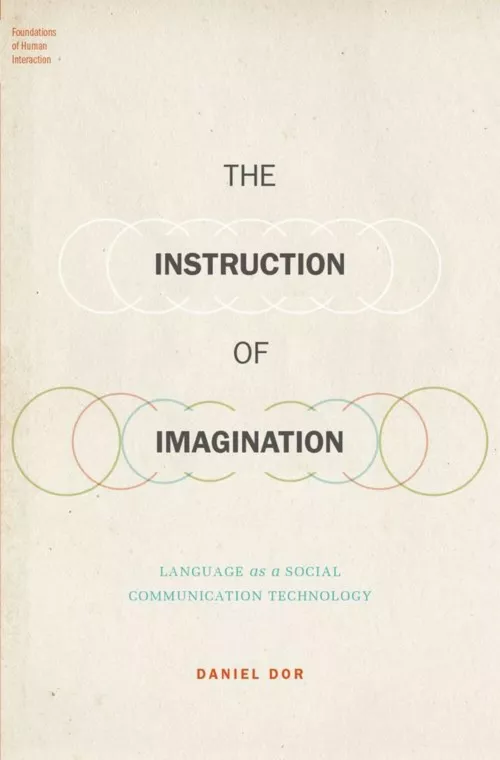I gatti, il dito puntato e la cultura umana
Qualche anno fa mi sono reso conto che i gatti di casa non capiscono il gesto di indicare, cioè di mostrare con il dito. Sono gatti (tengo a precisarlo) che capiscono una quantità sorprendente di cose, come del resto la maggior parte dei loro simili; e immagino che, per parte loro, spesso si stupiscano di quanto poche ne capisca io. All’idea di indicare, però, sembrano impermeabili. In questo sono in buona compagnia: a quanto pare, tutte le grandi scimmie – tanto più simili a noi di quanto non lo siano i gatti, e di noi ancor meglio equipaggiate quanto a diti indici – non sono use indicare. Possono bensì apprendere il gesto, se appositamente addestrate, ma non lo praticano fra loro, pur avendo sviluppato nella loro storia evolutiva una comunicazione gestuale piuttosto articolata.
La questione è familiare agli specialisti. Nei convegni di studi sul comportamento dei primati o sull’apprendimento del linguaggio il cosiddetto pointing è un tema cruciale. Se infatti il gesto di puntare con un dito può apparire di una disarmante semplicità, le implicazioni concettuali sono oltremodo complesse. Michael Tomasello, psicologo americano attualmente in forza al Max Planck Institut di Lipsia per l’Antropologia evoluzionistica, ha proposto anni fa questo esempio. Immaginiamo, per strada, di indicare a chi ci sta accanto una bicicletta. Gesto banalissimo; ma cosa significa? e, soprattutto, come significa? Ho il braccio proteso e l’indice puntato, d’accordo. Ma a che cosa sto puntando? Alla bicicletta, al colore, al tipo di sellino, al metallo del telaio? Dirigere l’attenzione altrui verso un luogo o un punto del contesto percettivo non basta a garantire che l’interlocutore identifichi in maniera corretta il referente del gesto. Perché ciò accada occorre che sia l’emittente sia il destinatario sappiano che l’oggetto dell’indicazione è pertinente rispetto a un contesto più grande, che entrambi condividono. Insomma, indicare diventa un gesto significativo solo in quanto si basa su un terreno intersoggettivo comune già stabilito.
Ebbene: secondo il linguista israeliano Daniel Dor, questa interpretazione del pointing equivale a mettere il carro davanti ai buoi. Lungi dal presupporre l’esistenza di un terreno comune, il gesto di indicare serve proprio a costruirlo. La differenza è fondamentale: in un caso si ragiona sui meccanismi della comunicazione in chiave strettamente cognitiva, nell’altro si adotta una prospettiva sociale. In un caso si cerca la soluzione del problema nel funzionamento interno di una struttura, nell’altro ci si sposta sul piano della relazione intersoggettiva. A uno studioso di letteratura questo capovolgimento non può non ricordare vicende analoghe avvenute nel campo della teoria post-strutturalista, a cominciare dalla critica del concetto jakobsoniano di letterarietà formulata da Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo. È vano ricercare contrassegni distintivi della letterarietà nella configurazione formale del testo: un testo non è intrinsecamente letterario, ma lo diventa, quando il destinatario lo legga come tale – cioè quando ci si sposta dal piano semiologico al piano pragmatico.
Ho tratto l’esempio della bicicletta e il commento relativo dal volume di Daniel Dor The Instruction of Imagination: Language as a Social Communication Technology (Oxford University Press 2015). Qui Dor presenta una nuova teoria complessiva del linguaggio che, rispetto alla grande fortuna riscossa negli ultimi decenni dalle prospettive cognitiviste, è davvero paragonabile a una rivoluzione copernicana. Detto un po’ all’ingrosso, tali prospettive tendono a considerare il linguaggio come qualcosa che nasce e prende forma all’interno del cervello. Partendo dal presupposto che la condizione umana è caratterizzata da un grado eccezionale di socialità, Dor afferma invece che il linguaggio è un’entità sociale (a social entity), che deriva da un processo collettivo di invenzione e di sviluppo. La sede del linguaggio non è dentro i parlanti, bensì fra di loro (between speakers, not in them): il luogo dove cercare l’essenza del linguaggio è la vita sociale, non la mente. Beninteso, ciò dicendo Dor non intende disconoscere l’importanza dei contributi offerti alla linguistica dalle neuroscienze; tuttavia non esita a qualificare le teorie del linguaggio orientate in senso cognitivo come astruse e barocche. Le complicazioni in cui esse incorrono sono causate dal fatto che l’obiettivo perseguito è irraggiungibile: non si può fondare su meccanismi neurologici quello che in realtà non è altro che uno strumento sociale. Insomma, gli umani non parlano per estrinsecare capacità maturate misteriosamente tra i meandri delle reti neuronali, ma perché hanno bisogno di comunicare con i propri simili.
Ecco la definizione di linguaggio proposta da Dor: a socially constructed, imagination-instructing communication technology. Una tecnologia comunicativa (la prima, tra le tante inventate dalla nostra specie) frutto di una costruzione sociale, che consiste nell’istruzione dell’immaginazione. Il dato di partenza è infatti che l’esperienza percettiva è privata. Ciascuno di noi è separato dagli altri da un experiential gap: ogni individuo vive in un mondo di esperienze distinto. Il problema di superarlo si è posto naturalmente molto prima dell’invenzione del linguaggio; e comunicare ha sempre significato cercare di colmare un divario per poter condividere o trasmettere un’esperienza. Tale scopo può essere perseguito tramite sistemi diversi. Il primo comprende le strategie di presentazione, che possono essere molto differenti fra di loro, ma che hanno in comune il fatto di aver corso qui-e-ora, all’interno dell’esperienza (espressioni del volto, posture, gesti, smorfie, gridi, danze). Il secondo consiste nelle strategie di rappresentazione (disegni, pitture, mappe), che consentono di affrancarsi dall’hic et nunc ma che serbano carattere iconico. La comunicazione linguistica segue una terza via. Il messaggio non equivale a un’ostensione diretta (“questa è la mia esperienza”), bensì a un invito alla cooperazione (“la mia esperienza è di questo tipo, cerca di immaginarla”). Ciò che viene fornito è solo un insieme di coordinate, di impalcature, che devono sostenere lo sforzo immaginativo. La funzione delle parole è di attivare e guidare l’immaginazione del destinatario. Seguendo quelle direttive, egli cercherà di riprodurre nella propria mente i significati che il parlante ha desunto dalle proprie esperienze.
La trattazione di Dor è ampia e sistematica, e non è quindi possibile darne conto in dettaglio. Conviene invece sottolineare alcuni punti sui quali insiste, tornandovi a più riprese. Il primo è il carattere negoziale della comunicazione linguistica. Sia il linguaggio in quanto tale, sia i concreti scambi di parole rappresentano uno sforzo di superare una distanza tramite un’intesa reciproca, la quale non si può realizzare se non operando insieme, per aggiustamenti successivi, per tentativi e approssimazioni (un concetto richiamato spesso è quello di mutual identification). Il secondo è che il tentativo può fallire – quello della mutua identificazione è un meccanismo intrinsecamente, inesorabilmente fragile – così come può riuscire solo in parte. Molte teorizzazioni sul funzionamento del linguaggio sono viziate dall’implicito presupposto che gli esiti possibili in uno scambio comunicativo sono solo due, successo o insuccesso, mentre la realtà pullula di comunicazioni venate, screziate, pervase di incomprensioni e fraintendimenti, di equivoci, di ambiguità, di zone d’ombra. Analogamente, un’antica e robusta tradizione negli studi linguistici tende a privilegiare il discorso compiuto, le frasi ben formate, la comunicazione riuscita, laddove in tanti campi di ricerca (medicina in primis) la storia dimostra che sono proprio i casi patologici che aprono la strada alla comprensione della fisiologia, sono le anomalie che rivelano la norma. Da questo punto di vista, la ricerca sulla natura del linguaggio deve saper attingere da un lato alle risultanze della formalizzazione più rarefatta (il confronto con quanto accade nel mondo dei computer è sempre istruttivo), dall’altro alla spuria concretezza della comunicazione empirica più avventurosa. Infine – terzo punto – va sottolineato che, al pari di ogni innovazione tecnologica, lo sviluppo del linguaggio è la risposta a una pressione evolutiva. I nostri progenitori si sono trovati nella necessità – nella necessità pratica – di migliorare la propria capacità di interazione (ricordo per inciso che nel campo propriamente evoluzionistico Dor collabora da tempo con la biologa e genetista di origine polacca, Eva Jablonka, che è tra i fautori, sulle orme di Stephen J. Gould, della extended evolutionary synthesis, nota ai lettori italiani soprattutto grazie alle opere di Telmo Pievani).
È probabile che questo libro costituisca un’autentica pietra miliare negli studi sul linguaggio. E ci potremmo chiedere quanto ciò dipenda dall’essere il suo autore abitante di una delle aree del mondo dove comunicare, negoziare, intendersi è più difficile. Non a caso Daniel Dor, docente presso la Tel Aviv University, è anche un intellettuale molto attivo sul fronte della difesa della democrazia, e più voci della sua bibliografia sono dedicate alle distorsioni e manipolazioni dei media nel conflitto israelo-palestinese: Intifada Hits the Headlines: How the Israeli Press Misreported the Outbreak of the Second Palestinian Uprising (Indiana University Press 2004), The Suppression of Guilt: The Israeli Media and the Occupation of the West Bank (Pluto Press, London-Chicago 2005). Come dire? Anche l’evoluzione degli studi può trovare alimento nella pressione ambientale.
Il libro: Daniel Dor, The Instruction of Imagination: Language as a Social Communication Technology, Oxford University Press 2015.