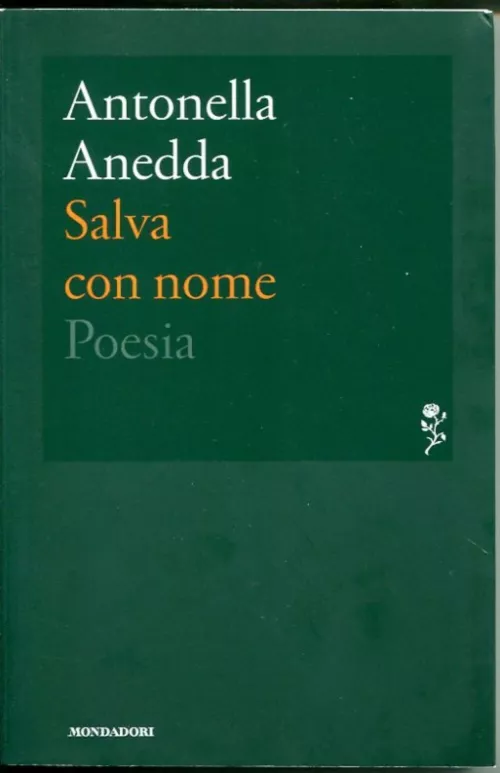L’irriconoscibile in Antonella Anedda
Lo sfaldamento dei corpi e dei nomi. L’assottigliamento del sé che impallidisce, sino a divenire quasi spettrale. La scomposizione di un’immagine, il ritaglio dei dettagli. Dove si incontrano questi due movimenti: il vento gelato del tempo cui siamo in balia, che disperde le identità materiali e simboliche, e la furia analitica dello guardo che fissa i particolari, li isola dal tutto.
Sfaldamento e scomposizione: all’incrocio di queste due correnti ascensionali stanno i due ultimi libri di Antonella Anedda: i saggi, dedicati alla storia dell’arte e al suo incontro ecfrastico con la poesia, di La vita dei dettagli. Scomporre quadri, immaginare mondi e quindi la raccolta poetica Salva con nome (rispettivamente del 2009 e 2012, da cui provengono tutte le citazioni non altrimenti segnalate).
“Perdere? è una porta sul vuoto”, scriveva Anedda nell’ultimo testo de la Vita dei dettagli. È in quella porta che s‘inoltra ora Salva con nome. L’estinzione e la perdita: qui sembrano incontrarsi le correnti gelide dello sfaldamento e della scomposizione. Collezionare perdite, l’ultima sezione de La vita dei dettagli, già esibiva a livello formale quell’alternanza tra parole e frammenti d’immagini che caratterizza la tecnica compositiva dell’ultimo percorso poetico di Anedda. L’interrogazione sul senso dell’arte e sullo statuto dell’immagine – dettagli di pitture, fotogrammi, ritagli di luoghi e paesaggi – giunge così a ridefinire la stessa trama della scrittura poetica, la messa in forma del suo sguardo. Una forma che è tanto più urgente, quanto più essa permette di approssimarsi a un contenuto conoscitivo, ad una realtà cui essa rinvia e che non è accessibile altrimenti.
Meditazioni sulla perdita, sul processo dell’estinguersi del corpo, del sé, del nome. Ad un primo sguardo, questo collezionismo della perdita sembrerebbe motivato dal bisogno di salvare in qualche modo ciò che si estingue: il bisogno di dire l’individuale, di dire il nome delle cose, e in questo modo salvarle nella parola dall’oblio.
Eppure, mentre quest’aspirazione viene enunciata – già nel titolo del libro – ad essa si mescola un’altra corrente, un senso ulteriore che si riflette nell’apparenza di quel nome. La verità della perdita del corpo, del sé e del nome, di cui parlano sia il testo conclusivo de La vita dei dettagli, sia la prosa incipitaria di Salva con nome, è la de-possessione, lo spossessamento:
perdere: smettere di possedere, dare oltrepassando […] scavalcare se stessi smarrendo, smarrendosi.
Guardare la verità terribile della perdita è anche cogliere in essa un movimento di de-soggettivazione. Quel moto attraverso cui gli individui, svincolati dal nome e dal processo di soggettivazione che a esso li aveva avvinti, escono dal tempo, tornano ad una prospettiva spaziale.
La dispersione dell’identità quale verità della perdita, come perdita del possesso, liberazione dal sé. È la stessa opera di chi con le forbici ritagli una foto, un ritratto, fino a ottenere, da questo idolo, dei frammenti che si disperdono lontani gli uni dagli altri. Essi diventano così irriconoscibili. I dettagli, isolati, scomposti, separati, non sono più riconoscibili, non sono più attribuibili a ciò cui appartenevano, all’identità dell’immagine originaria.
Lo spazio dice: una volta dispersa è irriconoscibile.
La traiettoria della fuoriuscita dall’identità, e dal tempo in cui è incastrata, dischiude così una visione dall’alto, in prospettiva aerea, e una dominante spaziale entra nella scrittura. Per quest’urgenza interna la stessa tecnica compositiva di Salva con nome si trasforma:
Contro il tempo troviamo l’arte dello spazio
la precisione che non permette alla mente di affondare.
Eppure il soffio di un’altra vita anima quest’arte dello spazio. Il collezionismo della perdita non è solo una galleria di dettagli irrigiditi, il museo del mortuum, ma è intriso da un’ansia di trasformazione e metamorfosi. Dov’è dunque l’altra vita dei dettagli?
Lo sfaldamento e la decomposizione operano una depossessione che svincola la cosa dal suo nome e dall’identità cui stava alla mercé. Ricombinata con altre cose frammentate, essa diviene irriconoscibile: irriconoscibile perché altra. Perché in essa si manifesta dell’altro.
La cosa è ricondotta alla sua nudità (“solo la nudità alla fine ci raggiunge”): spogliata dall’identità storica del nome, essa torna alla sua fragilità creaturale, alla sua caducità. Risolta nella sua vulnerabilità, e vulnerata, la cosa si rivela come qualcosa di ulteriore. Come nei lavori di Roger Ackling, resti di oggetti che il mare restituisce a una spiaggia scozzese – legni, cartoline, cose perdute, “brani di oggetti non più identificabili ma reali”, irriconoscibili ma esistenti. In quest’opera, così come nei frammenti di immagini e corpi che il tempo disperde, Anedda coglie una verità ulteriore. Questo smarrimento, questa fuoriuscita dal tempo dell’identità, manifesta ciò che non era visibile, rendendo irriconoscibili gli oggetti in base alla loro funzione usuale, consente di rivelare l’ultrasottile:
In quello scarto tra il prima e il poi, cercare l’ultrasottile proposto da Elio Grazioli attraverso Duchamp: la non sostanza dell’intervallo, l’ombra del possibile, tutto quello che va verso il non visibile, come la polvere e il fumo.
Non è il nome, né l’identità storica che la poesia può salvare. Per quanto terribile sia questa verità, l’identità era anche una prigionia, un essere alle mercé, una vita confinata.
Poi ricorda tutto il verso
“estinguere la passione del sé”.
E ancora: “estinguere il verso che rima
da sé: estinguere perfino me”.
“Estinguere perfino me”: un verso di Amelia Rosselli che ritorna nel finale di Salva con nome. Per quanto disperante, non è annichilente la meditazione sull’estinzione. Perché qui è in gioco il soffio di una vita ulteriore, quella vita dei dettagli che nella grande arte dello spazio si produce.
Condivido queste tracce (sono vere) con te che leggi, con te che so hai perduto.
Come può la poesia, quest’arte dello spazio, essere condivisione? Come può essere una condivisione nella dispersione? È questa la domanda che Salva con nome articola come propria di una poesia capace di tradursi e di tradurci in altro.
Servono aghi e forbici. Serve precisione.
In Salva con nome quest’immagine dell’arte poetica come tagli e cuci va a costituire la sezione centrale del libro, introdotta da una citazione da Louise Bourgeois:
Quando ero piccola, tutte le donne di casa maneggiavano aghi. Mi hanno sempre affascinato gli aghi, hanno un potere magico. L’ago serve a ricucire gli strappi, è una richiesta di perdono. Non è mai aggressivo, non è uno spillo.
La forbice che taglia, frammenta, analizza. L’ago che ricuce, connette parti diverse, lega ciò che la morte separa, ma in una forma irriconoscibile, unendo parole e foglie, parole e lembi di stoffe, parole e parole. È un patchwork, una cucitura di dettagli, che non può far risorgere l’identità originaria, storica, ma che semmai anima un’altra vita, altri particolari, frammenti e relazioni prima non visibili, infinitesimali, che prendono rilievo proprio in questa condivisione/dispersione.
Così, all’inizio e alla fine di Salva con nome, troviamo il “senza nome”: la maschera del carnevale di Oristano, Su Componidori. Liscia, bianca e androgina, questa maschera annulla l’identità del singolo. Il Componidori così
diventa tutti gli uomini e le donne che è stato e i cui nomi si confondono sino a essere perduti.
E nel finale del libro, intitolato Visi. Collages. Isola della Maddalena, troviamo gli ex-voto della chiesa della Trinità, descritta come un immenso collage di visi e volti di epoche diverse, e messo a contrasto con la verità degli ossari, in cui gli individui si confondono tra loro:
Questo confondersi, che dovrebbe insegnarci quanto puerilmente siamo attaccati ai nostri nomi.
Che cosa possono le poesie e l’arte contro questo confondersi? Nulla. Ma non ci si può trattenere al di qua, non resta che attraversare questa porta sul vuoto. Salva con nome è il resoconto di quest’attraversamento, della lucida, coraggiosa volontà di guardare in volto il senza volto, di dire il senza nome, di perlustrare quella vita ulteriore, di vedere la vita dei dettagli in quel vuoto.
Anche questo è un compito ecfrastico, dove le parole devono tradurre immagini nello spazio. L’attenzione e la cura per i dettagli, isolati dal contesto, liberati dall’appartenenza alla loro icona, sciolti in una vita più vasta, immaginata, diluiti nel mondo. Dunque, cos’è qui in gioco?
Uno scardinamento dei generi: quel confondersi, che nasce dall’isolare e dal ricombinare, manomette i generi letterari e artistici costituiti – poesia, saggistica, pittura… – e come tale è pure segno dello scardinamento delle categorie entro cui le nostre vite finite sono tracciate.
Un’ontologia delle cose: ad esser in gioco è anche l’ontologia delle cose, il loro vero essere, giacché l’attenzione al dettaglio – watch it closely, secondo l’adagio ripreso da Elizabeth Bishop – è insieme l’aspirazione a cogliere ciò che è in esse. Cogliere la loro realtà vulnerabile, fragile e nuda, e quindi l’alterità misteriosa e sepolta sotto la loro funzione usuale: quell’alterità prima irriconoscibile. Quell’alterità nascosta dall’individualità che noi le attribuiamo (il non volto, che nel Malte di Rilke sta sotto la maschera).
Una metamorfosi: in gioco è così il passaggio, la traduzione in altro delle cose stesse. Dar vita all’elemento latente e dormiente nel quadro, nella vita, rianimare il resto, il residuo, è un’operazione metamorfica, poiché è ciò attraverso cui il dettaglio esce da sé, si spossessa, si trasforma “in un altro quadro, un’altra vita”. La perdita, come dislocazione di sé, e dell’identità delle cose.
Un’etica: qui si annida infine il movente etico dell’ontologia metamorfica dei dettagli. La realtà fragile, caduca, non è forte. Essa, con le parole di Arendt, ha bisogno della nostra protezione (il rinvio è a Le origini del totalitarismo: “La realtà non è tenace, non è forte, ha bisogno della nostra protezione”). Ma questa protezione non può consistere nel salvare l’individualità data, né può metterci al riparo dalla fragilità, dalla paura che le è intrinseca. La poesia, questo “panico controllato”, con le parole di Elizabeth Bishop, partecipa di quella condizione, né può immunizzarci da essa. Essa è quell’uccellino costiero, il Sandpiper, “che cerca e cerca, nonostante sia stordito e spaventato”.
Impaurito, quell’uccellino vede che la nostra esigenza di protezione deve accogliere anche la verità della perdita, che è anche la verità etica della disappropriazione, della perdita come dono e decreazione, come apertura all’ulteriore.
Vede che la protezione di sé non è lo scudo dal male. Vede che la distruzione del male, che l’attenzione ai dettagli promette – secondo quanto scriveva Simone Weil (“Ogni volta che facciamo attenzione distruggiamo il male in sé”) –, deve essere ancora pensata.