Mari e monti (4). Oceano, sostantivo singolare
Tutti sommersi
“Gli oceani del mondo contengono 285 milioni di chilometri cubi di acqua, quindi se tutta l’umanità – quei cinque miliardi di corpi – venisse gettata nell’oceano, il livello dell’acqua si alzerebbe di meno di un centesimo di millimetro. Un solo schizzo e la Terra sarebbe per sempre spopolata”: così scriveva Stanisłam Lem – l’autore di Solaris, il pianeta dotato di un oceano senziente – in One Human Minute (Harcourt Brace & C. 1986, pp. 12-14). In realtà immagina di riportare un passo di un libro inesistente suddiviso in duecento capitoli, di cui scrive una recensione. Una riuscita riattivazione della tradizione della pseudoepigrafia, con cui Lem si è esercitato a diverse riprese.
A colpi di statistiche, il libro immaginario restituisce ogni singola attività della specie umana sulla Terra durante un solo minuto di tempo, avanzando ipotesi astruse: “se l’umanità tutt’intera fosse presa e ammassata in un unico luogo, occuperebbe trecento miliardi di litri, ovvero poco meno di un terzo di chilometro cubo”; “24,9 miliardi di litri di sangue potrebbero essere versati da tutta l’umanità e non farebbero un Mar Rosso, nemmeno un lago”; “oggi ci sono più malati di mente in ogni minuto che tutte le persone che hanno vissuto sulla Terra nelle ultime decine di generazioni”, e così via.
Senza dubbio Lem si prende gioco dell’approccio quantitativo e materialista alle faccende umane, ma non solo, ridicolizzando il progetto moderno della specie umana che si vuole padrona del mondo. Infatti Lem considera le statistiche come “un promemoria che noi – che con la potenza della nostra industria abbiamo avvelenato l’aria, il suolo, i mari, che abbiamo trasformato le giungle in deserti, che abbiamo sterminato innumerevoli specie di animali e piante vissute per centinaia di milioni di anni, che abbiamo raggiunto altri pianeti e abbiamo alterato persino l’albedo della Terra, rivelando così la nostra presenza agli osservatori cosmici – potevamo scomparire così facilmente e senza lasciare traccia”.
A rileggere One Human Minute oggi, cioè in piena crisi climatica e nel corso di un’estate di anomalie termiche, l’umanità gettata nell’oceano fa pensare meno a un ritorno della nostra specie all’origine, al primigenio ambiente amniotico che al nostro annegamento-annientamento. Un de profundis oceanico. Certo, non siamo più cinque miliardi, quindi le acque si alzerebbero di qualche millimetro in più, ma vale la pena di prendere sul serio la boutade di Lem quando consideriamo il nostro rapporto con l’oceano.
Un solo oceano
Al riguardo, due pubblicazioni recenti – Roberto Casati, Oceano. Una navigazione filosofica (Einaudi 2022) e Oceano, The Passenger (Iperborea 2022) – condividono sin dal titolo un aspetto solo apparentemente marginale: l’oceano è pensato al singolare, come quel mare unico e indiviso che copre il settanta per cento del pianeta. Distinguere tra mare e oceano è infatti legato a una visione del mondo ormai tramontata, “non corrisponde a nessuna differenza utile e quindi ci impedisce di vedere l’unità del sistema oceanico, perfettamente stabilita dal punto di vista fisico e biologico (non conoscono frontiere le correnti, gli scambi di temperatura, di salinità, di ossigeno e di carbonio, le migrazioni del vivente), e implicitamente accettata da chi naviga su lungo corso (da ogni porto da cui si salpa si raggiunge ogni altro porto). Mare/oceano” (Casati, pp. 14-15).
Secondo Casati, “l’acqua cancella ogni confine; e visto che tutti i mari del mondo dialogano con tutti gli altri mari, i confini che la storia ha tracciato nel mare sono puramente concettuali” (p. 59); non a caso riprende la carta dell’oceanografo Athelsan Spilhaus che, nel 1979, mostra come l’oceano si propaghi nelle pieghe delle terre emerse. Mettendo alla prova la nostra visione terracentrica, oltre che antropocentrica, l’oceanografa Sylvia Earle (intervistata in The Passenger) considera la Terra come un Oceano e le masse terrestri come isole. Una visione resa celebre dallo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke: “Bisognerebbe chiamare la Terra Oceano, perché tutte le masse terrestri sono isole”.
Eppure la nostra indifferenza verso l’oceano regna sovrana, al punto che solo il tre per cento è protetto in quanto parco marino. Lo stesso vale per la fauna selvatica oceanica, verso la quale proviamo una scarsa empatia rispetto al suo corrispettivo terrestre: “la gente è convinta che il pesce le appartenga. Il pesce è considerato una risorsa gratuita; basta uscire e prenderselo. Con gli alberi la situazione è migliore perché quando li perdiamo siamo in grado di capire causa ed effetto. Quando si pesca nell’oceano la perdita non si vede, ma perdiamo tonnellate di animali” (Sylvia Earle in The Passenger, p. 16). Certo, le sensibilità mutano col tempo: una volta i balenieri erano considerati degli eroi; oggi le balene non sono più “semplici chili di carne. La gente non pensa ai pesci negli stessi termini degli altri vertebrati, ma anche loro lo sono, proprio come gli uccelli e i mammiferi” (p. 17).
Più che elargire sussidi alla pesca, dovremmo insomma batterci per sostenere una blue economy. Una questione urgente perché la scarsa considerazione per l’oceano ha conseguenze nefaste su qualsiasi livello, dalla superficie agli abissi, come mostrano bene quattro pagine di The Passenger dove l’azione umana è dettagliata a seconda della profondità marina.
Per semplificare, siamo davanti a un oceano-discarica, in cui finiscono i container smarriti oltre a ciò che non può essere smaltito sulla terraferma: “La Fao stima che ogni anno nel mondo vengano perse o abbandonate in mare circa 640mila tonnellate di equipaggiamento da pesca, circa un decimo di tutti i rifiuti oceanici” (The Passenger, p. 26).
Il Punto Nemo indica il luogo del mare più lontano da qualsiasi terra emersa, più o meno a metà strada tra Nuova Zelanda e Capo Horn, l’Equatore e il Polo Sud, 2500 km dalle isole più vicine. Ebbene, ricorda Casati, “le agenzie di vari Stati si sono trovate d’accordo sul bombardare una regione intorno al Punto Nemo con i relitti ancora più o meno pilotabili di svariati oggetti orbitanti, tra cui un paio di stazioni spaziali e una pletora di satelliti artificiali, si parla di un totale tra duecento e trecento scassoni che sono finiti sul fondo dell’oceano da quelle parti” (p. 137). Da quelle parti, ovvero in quella che può essere considerata come la quintessenza dell’oceano.
Siamo davanti inoltre a un oceano-risorsa infinita: non solo a causa dell’overfishing (sovrapesca degli stock ittici marini) ma anche del bycatch, quegli animali pescati involontariamente che spesso muoiono – “danni collaterali” potremmo dire. Un fenomeno aggravato dall’uso del palamito industriale, con i suoi chilometri di lenza e i numerosi ami da esca estesi per trenta miglia, che vanno alla deriva continuando a far danni, aggravati quando le reti dragano i fondali. Lo stesso vale per i minerali estratti dalle acque profonde, che contribuiscono all’industria delle energie rinnovabili compromettendo però gli ecosistemi dei fondali marini.
Siamo davanti infine a un oceano-medium commerciale: qual è la percentuale delle merci di cui ci serviamo nella nostra vita quotidiana trasmesse via mare? Pochi si rendono conto che la cifra sfiora il novanta per cento, e che tale commercio è quadruplicato dal 1970, una tendenza che non cessa di aumentare: “In mare ci sono più di centomila navi che trasportano tutti i solidi, i liquidi e i gas di cui abbiamo bisogno per vivere. Le navi cargo sono solo seimila, ma compensano con la loro vertiginosa capacità di carico: la più grande può trasportare oltre ventimila container. Può contenere abbastanza banane da darne una a ogni europeo” (Rose George in The Passenger, p. 48). Una tendenza facilitata dal cambiamento climatico: la riduzione della copertura di ghiaccio marino è considerata come un’opportunità che apre nuove rotte polari attraverso il passaggio a Nordest e a Nordovest – una nuova rotta commerciale tra Cina ed Europa, la Via artica della seta.
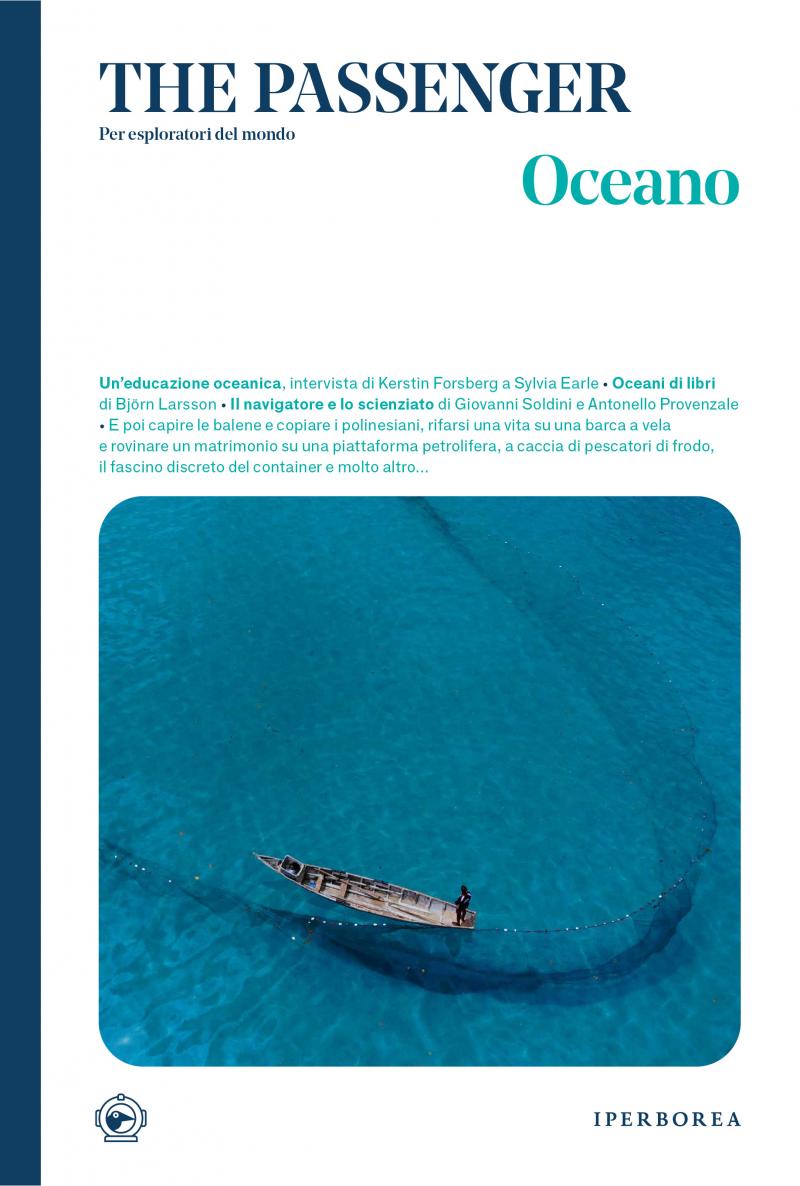
Che il fondo degli oceani, difficilmente raggiungibile e ancora oggi poco conosciuto – “Solo un quinto del fondo oceanico è stato cartografato a una risoluzione simile a quella delle terre emerse” (Casati, p. 52) – sia risparmiato dallo sfruttamento indiscriminato? La risposta è negativa: persino le fosse oceaniche, nella zona abissopelagica (da 4000 a 6000 m), sono diventate un archivio della nostra storia industriale, a causa della presenza di sostanze ormai proibite come i pop, persistent organic pollutants (inquinanti organici persistenti), “sostanze chimiche tossiche molto resistenti alla decomposizione che quindi risiedono nell’ambiente per lungo tempo” (The Passenger, p. 29).
Ma questi fondali contengono, della nostra civiltà, non solo l’archeologia ma anche il presente, con i cavi delle telecomunicazioni, e persino l’avvenire, grazie all’accumulo di “miliardi di noduli polimetallici, cioè rocce della dimensione di una patata, ricche di nichel, cobalto e altri metalli utili alla transizione energetica, che si formano nel corso di milioni di anni. Società minerarie hanno già costruito prototipi di macchinari giganteschi per aspirarli in superficie, manca solo l’approvazione dei regolamenti che disciplineranno il settore. Ogni nodulo, però, è un minuscolo ecosistema che ospita anemoni e spugne che a loro volta albergano coralli, vermi tubolari e altre creature che vivono sui fondali” (The Passenger, p. 29).
Come sottrarre l’oceano a questo destino?
Pensare l’alterità
In genere abbiamo una visione dell’oceano dalla spiaggia, dalla terraferma o, a bordo di un volo intercontinentale, dall’aria; una distesa d’acqua che distanzia due punti e allontana dalla meta da raggiungere: “Il mare è uno spazio da sorvolare, un tappeto tra decollo e atterraggio” (Rose George in The Passenger, p. 49). I viaggi in mare sopravvivono solo grazie a qualche sparuto avventuriero, di cui seguiamo le gesta da casa e su schermo, nonché nella loro pallida versione turistica della crociera all inclusive.
Questa visione contribuisce alla situazione attuale, che trascura ad esempio quell’alterità radicale del mare su cui insiste Roberto Casati nel suo saggio: “Il mare aperto è un deserto umano che non offre riparo dal sole, è senza ombre e senza odore, ha un colore indefinito e cangiante, è fatto di un’acqua che non si può bere, è in continuo movimento, è battuto da venti violenti che sollevano onde maestose […] è dominato da correnti alle quali non si può opporre forza, nasconde abissi perigliosi, ed è chiuso in ogni direzione da un orizzonte uniforme poverissimo di informazioni” (p. 21).
Luogo inabitabile e profondamente disumano, l’oceano non costituisce un riparo come la terraferma, e attraversarlo con delle imbarcazioni, poco importa quali, non ci mette fuori pericolo: “non c’è tipo di nave che non sia naufragato, dalla canoa alla caravella al trimarano alla portacontainer” (p. 8).
Questa sfida è posta non solo alla navigazione ma anche, secondo Casati, al pensiero: “Il mare è un mondo altro, differente; radicalmente differente. Questa differenza è una sfida per la conoscenza e per i concetti che usiamo per descriverlo. Dobbiamo accettare fino in fondo questa alterità. Non è riducibile, né ha senso cercare di ridurla. Non possiamo assimilare il mare” (p. 13). Per questo l’autore ci invita ad adottare una filosofia del mare che sappia confrontarsi con tale alterità, che sappia pensarla senza assimilarla: “Dovremmo trattare fino in fondo il mare come un esopianeta, i suoi abitanti come extraterrestri. Il mare andrebbe visto come un pianeta estraneo che ci sta però incollato, con il quale possiamo avere rapporti culturali, diplomatici o anche commerciali, ma un esopianeta comunque” (pp. 176-77).
È vero, molti vivono sulla costa o sulla banchisa, ma non esiste un popolo del mare e nessuno vi ha stabilito il suo domicilio: “non si hanno società esclusivamente marine: gli esseri umani non si ripartiscono tra i terrestri e i marini, ci sono soltanto umani terrestri sul nostro pianeta” – “non c’è Waterworld e non c’è Aqualand” (Casati, p. 32).
Eppure l’oceano resta un crogiolo di storie umane per lo più invisibili. I lavoratori del mare descritti da Victor Hugo nel corso del suo esilio sull’isola di Guernsey compongono oggi un esercito di 1,89 milioni di lavoratori, soprattutto uomini. Diversi reportage pubblicati su The Passenger ci familiarizzano con l’industria petrolifera offshore, marittima e ittica, con le compagnie di navigazione di cui non sappiamo nulla nonostante siano essenziali per la nostra esistenza quotidiana. Un settore dove si lavora a condizioni inaccettabili a terra, come se il mare fosse uno spazio eslege: “Esistono infinite leggi sul mare, ma il mare dissolve la carta” (Rose George in The Passenger, p. 53). Un settore segnato dalla violazione dei diritti umani: “Il lavoro è duro e rischioso. C’è la minaccia continua di esplosioni, asfissia, ustioni chimiche, carichi pericolanti” (The Passenger, p. 124). E se i salari sono in media più alti rispetto a quelli di un operaio sulla terraferma, non indifferente è l’impatto sulla sua vita privata, incompatibile con ritmi così sostenuti e assenze così lunghe.
Biblioteca della vita
A proposito dell’oceano, da una parte Casati (pp. 152-3) propone di adottare un nuovo lessico: non più riserve ittiche ma popolo extraterrestre; non più giacimenti petroliferi ma zone sottomarine di protezione atmosferica; non risorsa ma condizione di sopravvivenza; non gas naturale ma gas fossile; non pesca ma estrazione meccanica. Oppure, seguendo il geografo Alasdair Neilson: “descrivere l’osteoporosi del mare (l’acidificazione degli oceani rende fragili le conchiglie), parlare dei coralli come di polmoni (filtri), o dire che l’inquinamento sonoro in profondità crea una nebbia di sfondo per la comunicazione tra i cetacei, nella quale gli impulsi del sonar delle navi esplodono come dinamite. Si potrebbe anche presentare l’aumento della temperatura del mare come una forma di febbre” (in Casati, p. 156).
Dall’altra parte, si possono incentivare azioni come la caccia ai pescherecci di frodo, a partire dal più lungo inseguimento marittimo della storia (110 giorni), quello del Thunder, su cui The Passenger pubblica un dettagliato reportage. Un evento che ci rende consapevoli che le acque internazionali sguazzano in una zona grigia se non in un vero e proprio Far West normativo: “uno stato costiero ha piena sovranità sulle sue acque territoriali, che si estendono fino a dodici miglia dalla costa. Inoltre può anche istituire una propria zona economica con il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse naturali fino a duecento miglia dalla costa. Il resto dell’oceano è terreno di caccia libera; non appartiene a nessuno” (The Passenger, p. 76). In rari casi questa situazione diventa benefica, se pensiamo a Wow! (Women on waves), il progetto dell’attivista e artista Rebecca Gomperts che aiuta a far abortire in sicurezza le donne che vivono in stati in cui l’aborto è illegale, perché oltre venti miglia una nave risponde alle leggi del paese di cui batte bandiera.
Radicalmente altro da noi, l’oceano – discarica, risorsa, medium commerciale ma anche “sudore della terra” come scriveva Empedocle nel Poema fisico? – rende possibile la nostra esistenza. Basta immaginare l’immersione in profondità come un viaggio nel tempo, per riprendere in conclusione le parole dell’oceanografa Sylvia Earle: “Quando ti immergi sott’acqua, è come immergersi nella storia della vita sulla terra. Ci trovi tutte le principali specie di esseri viventi: dalle spugne ai coralli, dai granchi alle meduse, dai pesci, ai delfini e alle balene. L’oceano è una biblioteca della vita” (in The Passenger, p. 11).
Leggi anche:
Maurizio Sentieri | Mari e monti (1). Sulle strade degli Appennini
Giuseppe Mendicino | Mari e monti (2). Le mille storie del Monte Bianco
Gianfranco Marrone | Mari e monti (3). Sicilia degli dèi
Pietro Lacasella | Mari e monti (4). Sulle tracce dei ghiacciai







