Nella Benevento romana
Un’agile liburna era appena approdata al porto fluviale di Cellarulo. Alcuni membri dell’equipaggio balzarono, lesti, a terra per dar manforte ai marinai beneventani impegnati ad assicurare le gomene alle bitte. Frattanto, alla battagliola si era affacciato un uomo anziano ma ancor vigoroso. Una lieve brezza ne faceva fluttuare la lunga capigliatura candida e la barba d’identico colore che gli incorniciavano il volto alla moda greca. Apollodoro di Damasco, il più illustre architetto dell’impero, era giunto a Benevento in qualità di inviato senatorio, con l’incarico di sovrintendere alla costruzione dell’arco che il Senato Romano aveva deliberato di innalzarvi per celebrare l’inaugurazione della Via Traiana.
L’insigne nabateo – aveva sessantadue anni, uno in meno dell’imperatore, con il quale aveva condivisa la giovinezza in Siria – si portò una mano alla fronte per farsi schermo dalla luce del sole e scrutò la banchina. Si augurava che il pretore Marcellino, messo a capo della città, avesse inviato a prelevarlo un mezzo di trasporto: non aveva alcuna intenzione di raggiungere il cantiere a piedi, il caldo e le zanzare lo avevano fiaccato.
Sul basolato della via Traiana risuonavano, cadenzati, i passi di un giovane che la stava percorrendo, spedito. Era partito alle prime luci dell’alba da Canosa, un vico della Daunia alla volta di Benevento; gli era infatti giunta notizia che laggiù ci fosse del lavoro per uno scultore bravo quale lui reputava di essere diventato. Il mestiere lo aveva appreso da suo nonno, formatosi a Roma sul cantiere del grande anfiteatro fatto ergere dalla gens Flavia fra il Celio e l’Esquilino. Si poteva anzi affermare che fossero quasi tutte di mano del suo avo le statue che ornavano l’interno delle arcate del secondo e del terzo ordine di quell’architettura magniloquente. E lui le conosceva a menadito. Ne aveva infatti copiati e ricopiati i calchi nel suo lungo apprendistato, tanto da essere ormai in grado di riprodurle ad occhi chiusi. Il suo scalpello, rotto a qualunque arditezza di panneggio, dispiegava forme coniche, tratti enantiomorfi e andamenti elicoidali con consumata abilità. Nei bassorilievi e negli altorilievi, poi, sapeva dar vita a figure colte in arditi scorci, delle quali modulava i piani di profondità in aggetti talmente articolati, da far sì che la luce vi giocasse a rimpiattino. Ma ciò in cui non aveva eguali era nell’uso delle proporzioni del corpo umano, da lui apprese studiando il Canon del greco Policleto di cui suo nonno conservava con devozione una copia nella propria biblioteca. La ponderatio, infine, non aveva segreti per lui. Nelle figure erette che scolpiva, il baricentro giaceva sempre sull’asse di simmetria: anche per questo esse rasentavano la perfezione.
Recava nel tascapane una lettera del suo avo indirizzata al sovrintendente del cantiere per l’erigendo arco onorario dedicato all’imperatore Traiano.
Una matrona era ferma su un lato del cantiere dell’arco ad osservarne i lavori. Indossava un’elegante tunica damascata color ocra, sopra la quale era drappeggiata una morbida stola di seta cremisi. L’accompagnava uno schiavo che le reggeva sopra la testa un tendalino di foggia orientale, a proteggerla dai raggi del sole. La sua domus sorgeva a poca distanza dal cantiere ed erano giorni che non udiva altro che battere, picchiare, scavare, raschiare, così si era risolta ad andare a verificare di persona l’opera dei carpentieri. Stava ammirando le imponenti macchine che sollevavano senza sforzo enormi blocchi di pietra dall’aspetto pesantissimo fino ad un’altezza di quindici metri dal suolo, quando vide arrivare una lettiga sorretta da otto littori, dalla quale discese un uomo anziano, d’autorevole aspetto – la cui barba qualificava come non romano – che destò subito la deferenza di tutti i lavoranti. Che si trattasse di quell’Apollodoro di Damasco di cui tanto si sentiva parlare?, si domandò la donna celandosi dietro un blocco di marmo per osservare la scena senza esser vista.
Era passata da poco l’alba, quando un giovane si presentò sul cantiere dell’arco con una missiva per il direttore dei lavori.
“E così tu sei il nipote di Valerio de Apulia” esclamò Apollodoro che, rotti i sigilli del plico, ne aveva scorso rapidamente il contenuto. “Valente scultore, tuo nonno. E in queste righe egli sostiene che tu lo saresti ancora di più” soggiunse fissandolo coi suoi occhi penetranti. “Optime. Ti metterò subito alla prova. Vedi laggiù quella lastra di marmo? Dovrai scolpirvi questo gruppo di figure” continuò mostrandogli un disegno sul quale erano riprodotti dei personaggi togati che sembravano dialogare con un altro dalle sembianze più primitive. “Vedi di non sbagliare. Quel marmo pario al Senato è costato una fortuna.” E, senza aggiungere altro, si allontanò lasciando il giovane da solo.
Con un occhio al disegno e l’altro alla lastra, questi iniziò subito a lavorare. Tracciò dapprima i confini della scena a carboncino, quindi i profili delle forme, poi, estratto dalla giberna il suo scalpello prediletto, prese a digrossare il marmo a colpi di martello.
Era talmente concentrato che non si avvide che Apollodoro era tornato e seguiva ogni sua mossa.
La prima figura che apparve fu quella di un uomo togato sulla sinistra della scena che aveva i tratti dell’imperatore Traiano. Il giovane passò poi a liberare dal marmo superfluo la parte centrale, da cui fece emergere l’immagine di Giove Feretrio. Maestoso e severo, col corpo aitante come quello di un atleta, il Padre degli uomini e degli dei impugnava fulmini e saette e guardava verso destra, dove di lì a poco comparve un soggetto barbuto con indosso una corta tunica, stretta alla cintola e alti calzari che gli lasciavano scoperti i poderosi ginocchi. Imponente ed umile al contempo, il capo dei nemici sconfitti, era colto nell’atto di sottomettersi all’imperatore dei Romani.
La mano lesta dello scultore passò infine ad occuparsi della parte alta del riquadro lapideo, da cui fece scaturire una folla di teste crinute e glabre e una selva di fasci laureati che spiccavano su un fondo arboreo di querce guarnite di ghiande.

Si era fatto quasi buio quando il giovane depose gli attrezzi. Il tempo era volato senza che se ne fosse reso conto. Soddisfatto, si ripulì le mani sulla tunica e fece per allontanarsi di qualche passo, così da poter rimirare il risultato della sua fatica da una distanza opportuna. Nel retrocedere, però, andò a cozzare contro qualcuno che gli stava alle spalle. Si girò di scatto e, con sorpresa, riconobbe Apollodoro.
“Concordo con tuo nonno, ragazzo” dichiarò questi con un sorriso. “Sei davvero molto bravo. Di sicuro è stata l’Ananke a mandarti a me. Affari urgenti mi richiamano nell’urbe e prima che tu arrivassi non avrei saputo a chi delegare la direzione dei lavori. Ora posso partire tranquillo. La affiderò a te.” Quindi, posatagli la mano destra su una spalla, continuò: “Nel nome del Senato e del Popolo Romano, ti conferisco la carica di «Maestro delle gesta». Sono certo che non deluderai la mia fiducia, ragazzo”.

La domina era andata ancora molte altre volte a seguire i lavori dell’arco. Ursidia Otacilia – questo il suo cognome da nubile – non lo faceva solo per ammirazione. Sebbene ne avesse sposato uno, in realtà covava in petto un risentimento atavico contro i Romani. Ora, il vedere come questi celebrassero se stessi e la propria gloria nella sua città, le procurava un dolore senza eguali, al quale non riusciva a sottrassi. Provava, insomma, quell’attrazione-repulsione – che diviene presto dipendenza – tipica della vittima nei confronti del proprio carnefice. Nelle sue vene, infatti, scorreva sangue sannitico e, nonostante fosse trascorso molto tempo dalla definitiva sconfitta del suo popolo ad opera delle legioni romane, in lei il dolore non si era sopito e neppure lo sdegno per i soprusi subiti dai suoi avi, privati dell’onore, della dignità e persino del nome. Non più Sanniti, i Romani vollero chiamarli Campani fiaccandone il coraggio con leggi inique. Non li fecero federati, furono ridotti a colonia e, a poco a poco, la loro energia si spense.
Ursidia si fece scura in volto. D’un tratto le era sovvenuto il vero nome della sua città. Quando la sua gente l’aveva fondata, l’aveva chiamata Malòenton, con parola greco-dorica, che significa gregge di pecore, perché i suoi avi erano stati sì indomiti guerrieri, ma anche abili pastori. Montani atque agrestes li aveva definiti Tito Livio, ma lui non aveva scritto la loro storia. I Sanniti non avevano avuto storici che inneggiassero alle loro vittorie o che piangessero le loro sconfitte, ma il monito dell’onta era ancor vivo nella loro prosapia, della quale Ursidia era la rampolla più nobile. In lei, infatti, si concludeva la discendenza degli Otacilii, che avevano retto il Sannio prima della conquista di Roma.
Non era vero che Malόenton significasse “cattivo evento”. Erano stati i soldati romani, ignoranti in greco, a confondere le cose. Della parola avevano colto solamente il suono e lo avevano tradotto in latino come malum eventum. In seguito alla vittoria su Pirro, i loro generali avevano mutato il nome della sua città in bonum eventum, divenuto poi Benevento.
Una brezza leggera rinfrescò l’aria. Era ormai autunno inoltrato. Ursidia rabbrividì e, gettatasi il mantello sulle spalle, si risolse a far ritorno a casa. Mentre camminava, mormorava una nenia composta da lei stessa, in rima libera e in lingua osco-sannita, affinché i Romani non potessero comprenderla.
Era la litania dell’arco, che recitava ogni giorno, come un’ossessione, o, forse, come una esorcizzazione:
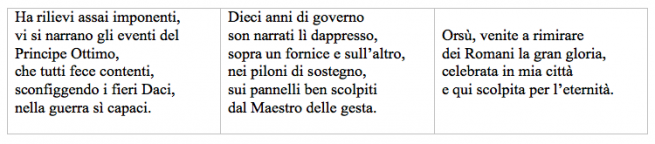
Nota: I rilievi dell’arco sono oggi molto danneggiati dalle intemperie e dall’incuria. Ci si augura che vengano presto restaurati e ricoverati in un luogo chiuso, sostituiti, come è stato fatto altrove, da copie.







