Dumbo secondo Tim Burton / Quando Dumbo eri tu, o ero io
Nessuno ricorda che anche Dumbo, come Pinocchio, o Alice nel paese delle meraviglie, è una storia d’autore, anzi d’autrice: fu scritta da Helen Aberson, nel 1938. La casa di produzione Disney liquidò con mille dollari l’acquisto definitivo del copyright, e tacque il nome della scrittrice nei crediti del film. È una brutta e triste faccenda; può darsi, però, che questa omissione, guardata a distanza, ci riveli qualcosa di più di una prepotenza imprenditoriale. Se nessuno si chiede chi abbia inventato Dumbo, the Flying Elephant, trasformato in un successo dal film d’animazione (1941), ciò dipende anche dal fatto che questa storia di un elefantino dalle orecchie mostruosamente grandi possiede, anche più di altre narrazioni trasformate in cartoni animati, quello speciale potere, anche impersonale, che hanno di solito le fiabe, vale a dire quei racconti emblematici che sembrano arrivare da un tempo fuori dal tempo e che non appartengono a un'unica voce creatrice, ma sono di tutti e parlano di tutti, funzionando come corpi plastici e polimorfici che svolgono, generalmente attraverso un animale magico e presenze o situazioni soprannaturali, una vicenda di trasformazione e di iniziazione alla vita attraverso il superamento di paure e emozioni profonde e primordiali. Dumbo, in effetti, fa proprio questo, perché ci fa vivere e rivivere, proiettandoci sulle sue goffe e spaventate timidezze, la solitudine e la paura di essere rimasto senza la mamma e dunque di non farcela; quell’elefantino freak parla, come pochi altri miti, al momento della nostra vita (magari eravamo piccoli, magari no) in cui Dumbo siamo stati, o eravamo, o siamo noi, anche se non tutti hanno avuto delle orecchie a sventola. Dumbo, infatti, è la vergogna di non essere accettati e di non riuscire a stare nel mondo. In questo senso, dunque, è un archetipo che possiede una forza simbolica e un’energia narrativa quasi insuperabili.

“Dumbo” (2019).
Ma Dumbo è anche una fiaba, e dunque, proprio come le fiabe più belle, oltre alla capacità di parlarci di verità umane universali, possiede anche una seconda importante qualità, vale a dire una sorta di porosità che consiste nel potere di assorbire e di restituirci, con colori diversi, nuovi significati e risonanze appartenenti al momento preciso e all’immaginario particolare dentro i quali, da un’epoca all’altra, riattiviamo e consumiamo quella fiaba. Così, parlare del film Dumbo realizzato da Tim Burton, criticarne i difetti e trovarne i limiti confrontandolo con la versione del 1941(diretta da Ben Sharpsteen, Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill Roberts, Jack Kinney e Samuel Armstrong) certamente ha senso, ma fino a un certo punto. Perché il film che adesso è in sala ci racconta, se guardiamo meglio, una storia che in parte è identica, ma in parte, invece, è anche una storia abbastanza diversa.
Entriamo nei dettagli. Il film del 1941 racconta di un elefantino dalle orecchie troppo grandi, ma che riuscirà, con l’aiuto di cinque corvi e un topolino parlante, a trasformare questa stranezza in un talento speciale, che gli consentirà di valorizzare le sue risorse fenomenali, trasformandolo in una star e consentendo a lui e alla sua mamma – ingabbiata e isolata per aver difeso il suo piccolo – di avere un trattamento di riguardo all’interno del circo.

“Dumbo” (1941).
Dumbo (2019) è un’altra storia, perché il film (sceneggiato da Ehren Kruger) racconta la vicenda di un elefantino diverso e discriminato che però, stabilendo un’intesa speciale con dei cuccioli umani, vale a dire dei bambini rimasti orfani di madre, potrà imparare a volare e, dopo varie (incespicanti) peripezie, riuscirà a sottrarsi alla schiavitù, tornando nella giungla con la sua mamma, in una sorta di Eden ritrovato e del tutto assente nella prima versione. Questo scenario meraviglioso, questa sorta di utopia ecologista ritrovata, da narrazione primaria diventerà, nel vero finale, un racconto secondario, messo in quadro da un altro racconto: quello della bimba che ha aiutato Dumbo prima a imparare a volare, e poi a fuggire, e che adesso, girando la manovella sotto il tendone del circo, proietta le immagini del suo amico finalmente libero.
Gli inizi e i finali delle storie non sono soltanto delle porte da cui entrare e uscire: sono gli spazi e gli sguardi grazie ai quali si inventano e si organizzano i significati delle storie. Così, attraverso queste soglie, e soprattutto attraverso il punto di vista complessivo costruito dalla fine, il film di Tim Burton usa l’elefantino generato al computer per realizzare, anche con difetti e dei limiti, una tipologia completamente diversa di rapporti con ciò che è vissuto come altro e diverso. Una tipologia visionaria, in senso tecnico-formale, ma pure poetico-cinematografico.
Sarà anche meno originale di altre opere precedenti, forse, ma certamente valeva la pena che Burton dirigesse questo film, non fosse altro che per l’intensità dell’immagine di Dumbo con il cerone. A prima vista dovrebbe sembrare un pagliaccio, perché è stato inserito nel numero dei clown, come accadeva anche nella prima versione; ma quell’animale truccato che guarda in macchina e che ricorda Gelsomina (Giulietta Masina) in La strada (Federico Fellini, 1954) funziona e agisce come un mimo, assomiglia persino un po’ a Marcel Marceau, nel senso che non ci fa ridere, nemmeno per un istante, piuttosto esprime, enfatizzando il visibile corporeo, la malinconia invisibile che lavora sotto le parole e al di là di esse.

Marcel Marceau (Getty Images).

Giulietta Masina ne “La strada” (1954).
Niente e nessuno è più nudo di quella maschera reinventata dal film, che costruisce e ferma la visione, dilatandola, come uno spazio vuoto, muto eppure eloquente. E così, soprattutto in quel punto, ma anche altrove, Dumbo non ci impressiona soltanto per gli effetti speciali, ma per la particolare forma di “empatia” tra umani e animali che il film persegue. Possiamo allora indugiare su quell’empatia, perché forse in essa lavorano gli aspetti più riusciti del film, e dunque vale la pena di considerarla meglio. Dumbo è un lavoro del 2019, vale a dire nato da un’epoca, per esempio, in cui non si guarda più con indifferenza a un circo in cui sono tenuti e maltrattati degli animali; è un mondo in cui l’ecologia (ne parla Scaffai in un suo libro) è diventata non solo uno dei saperi, ma anche una relazione narrativa e identitaria tra le più diffuse. Un mondo che sa che potrebbe essere l’ultimo a poter vedere, realmente, gli elefanti, «il loro carattere, il modo in cui si comportano e tengono unita la famiglia», persino il modo in cui si divertono a fare gli scemi, come ci fa considerare uno dei saggi più belli usciti lo scorso anno: Al di là delle parole, di Carl Safina.
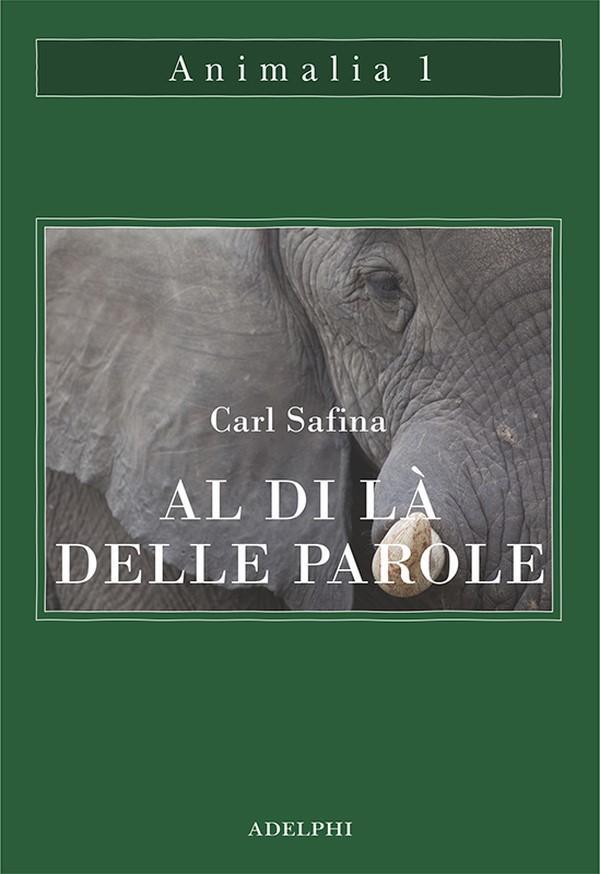
Ma la speciale empatia che ci lega a Dumbo arriva anche da altre stanze dell’immaginazione. Danny DeVito, nel ruolo del proprietario del circo “Max Medici”; Colin Farrell, che torna dalla guerra senza un braccio (il film è ambientato nel 1919) e da cowboy si adegua al nuovo lavoro di guardiano degli elefanti; Michael Keaton impresario spietato; Eva Green affascinante trapezista – per la verità fatta passare troppo rapidamente dalla funzione di antagonista a quella di aiutante dei due bambini che fanno amicizia con l’elefantino. Sono tanti gli attori in scena nel nuovo Dumbo; molti di loro appartengono alla galleria dei personaggi più iconici dell’opera burtoniana, e, effettivamente, sembrano che stiano lì più per funzionare da apparizioni che per agire davvero, perché al centro della storia il film non mette loro, ma la relazione tra i tre cuccioli – Dumbo e i due figli di Holt, in particolare la bimba (Nico Parker), che sostituisce Timoteo, il topolino parlante della prima versione. A questo livello della storia il film trasforma in tema forte un’altra qualità del mito di Dumbo, che in effetti ci parla non soltanto della paura di sentirsi diversi, o di portare per il mondo un corpo considerato dagli altri “difettoso”, ma ci fa vivere anche il bisogno e il sogno che nell’infanzia qualcuno ti faccia credere di essere una creatura speciale. Si può passare tutta la vita a rivivere o a sognare questo bisogno, e le creature immaginarie del cinema di Tim Burton, in un certo senso, fanno proprio questo. La scelta crudele dell’impresario senza scrupoli di rinchiudere la madre di Dumbo nella “Fabbrica dello Spavento”, la sua resistenza ingiustificata a ricongiungere l’elefantino alla sua mamma, adombra – forse troppo rigidamente – proprio questa metafora traumatica, elaborando al tempo stesso il pensiero vitale che può tirarla fuori dalla gabbia, perché l’elefantessa non è più la pazza (“mad elephant” nel film del 1941) rinchiusa per aver difeso il suo cucciolo; è soprattutto colei con la quale Dumbo ha un legame speciale, che il direttore vorrebbe spezzare, ma che invece rappresenta la relazione da capire per essere adulti in maniera vera.

Il cinema è il circo in cui queste promesse di felicità possono librarsi come una piuma, ed esprimersi senza paura di cadere e di fallire. Così, esattamente come Horace, il bambino che in Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016) era capace di proiettare i sogni e avere visioni sul futuro, sarà proprio Milly, la bimba che ha insegnato all’elefante a volare, a impersonare, nel finale, questo destino “visionario” e il patto circolare tra cinema e salvezza creativa, perché è proprio lei, quello che il personaggio rappresenta assieme a Dumbo, l’invenzione del cinema: lei che proietta, nell’ultima scena, le immagini di Dumbo nella giungla, consegnandoci un volo tra l’utopia e tra i sogni che altro non è che l’anima profonda di tutta la filmografia di Tim Burton e che assomiglia tanto a un elefantino truccato da mimo che ci guarda e sogna in silenzio, come un essere magico.







