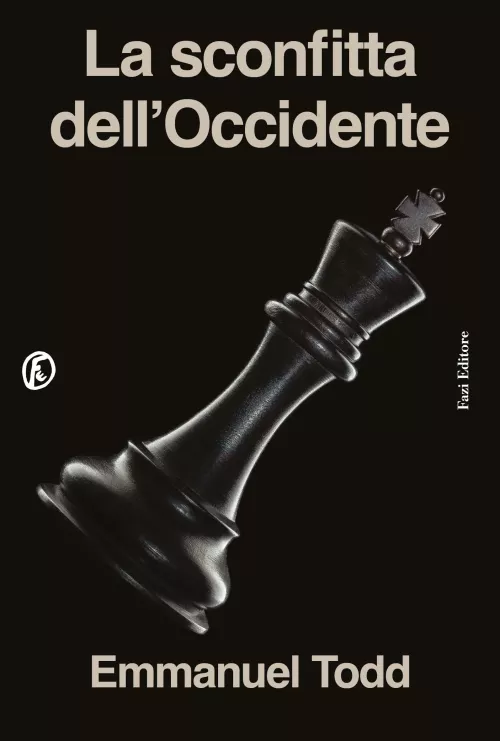Todd, Mounk e l’occidente in trappola
Dal 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina siedono insieme nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite quali membri permanenti: da loro essenzialmente dipende la responsabilità di assicurare l’ordine mondiale.
Occidente e Oriente condividono da allora la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (così lo Statuto dell’ONU).
Questo compito immane è stato sin qui svolto nonostante i tanti conflitti, locali e regionali, nonostante rivoluzioni (Cina 1949) e cambiamenti di regime (Russia 1991) e l’emergere di nuovi attori geopolitici ‘globali’ (dall’Iran komeinista ai paesi arabi produttori di petrolio, dal nuovo Sudafrica all’India al Brasile alla Turchia etc.) e infine nonostante la comparsa del terrorismo globale dall’11 settembre 2001.
Infatti, in quei conflitti mai si erano scontrati direttamente i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Oggi, il conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente stanno mettendo in crisi quell’ordine. Mantenerlo significa confermare l’assetto del 1945 o trovare nuove soluzioni, e quali?
La crisi dell’ONU nasce forse da quanto aveva visto Carl Schmitt, il giurista tedesco che fu legato al nazionalsocialismo, già al tempo della prima Società delle nazioni, negli anni ’20 del Novecento: la mancanza di una effettiva potenza coercitiva, di una effettiva “sovranità” da parte dell’organo mondiale. Basterà un allargamento del Consiglio di Sicurezza dell’ONU a Germania, India, Giappone, a due membri permanenti dell’Africa, due per l’America Latina e uno per le piccole isole – come propongono gli USA – ad aumentarne la “sovranità”?
Per capirlo leggiamo due testi appena usciti, molto diversi e che forniscono risposte opposte. Emmanuel Todd, sociologo e storico francese, in La sconfitta dell’Occidente elenca i motivi per cui l’Occidente sta scivolando nella “solitudine mondiale”: tutto il resto del mondo non condivide quello che noi occidentali, Stati Uniti ed Europa, stiamo facendo in campo internazionale. Non abbiamo capito che la guerra in Ucraina è stata causata da una pressione espansionistica della NATO, e non da un’aggressione russa. Abbiamo reagito in modo bellicistico, Gran Bretagna e Paesi nordici in testa, armando l’Ucraina che è uno “Stato fallito”. Come europei, non abbia espresso nessuna volontà comune che ci permettesse un certo grado di autonomia dagli Stati Uniti. In definitiva (p. 38): “a mettere a rischio l’equilibrio del pianeta è invece una crisi occidentale, e più precisamente una crisi terminale degli Stati Uniti, le cui onde più periferiche sono andate a schiantarsi contro la banchina della resistenza russa, contro un classico Stato-nazione conservatore”.
Ma quali prove Todd avanza a sostegno di questa sua singolare tesi? Esse sono: che in Europa e Stati Uniti non c’è più lo Stato-nazione in senso classico; che la classe media che ne era il fondamento è stata distrutta; che il substrato cristiano (protestante) che ne era alla base si è dissolto; che le classi dirigenti americane (ed europee) che ne erano alimentate si sono polverizzate. Una tesi paradossale perché, sarebbe come prendere Aristotele (La Politica) e Max Weber (L’etica protestante) a testimoni dell’attuale crisi dell’Occidente.
Todd ritiene invece che la Russia sia un solido Stato-nazione che, in vista del calo demografico cui va incontro, decide di agire. Ecco la tesi di Todd: “I dirigenti russi hanno le idee chiare e preservare la sovranità del paese rappresenta per loro un imperativo morale. Proviamo a metterci al loro posto. Sanno che la propria popolazione è destinata a diminuire. Che cosa ne deducono? Non certo che, contrariamente a quanto credevano gli americani, sarebbe una follia attaccare, bensì che, siccome questo declino diventerà pericoloso solamente nel medio e lungo termine, occorre agire il prima possibile, perché dopo sarà troppo tardi” (p. 82). Una singola tesi hobbesiana, la guerra di tutti contro tutti, è mescolata con una malthusiana idea del declino e della pressione demografica. Naturalmente con queste categorie in mente, non interessa a Todd se la Russia sia la potenza che ha attaccato l’Ucraina né che stia violando, al proprio interno, i principi della democrazia liberale (p. 146-7). Sfugge del tutto a Todd che questi regimi oppressivi devono attaccare all’esterno proprio per continuare a reprimere il dissenso all’interno: spiegava Simone Weil che per essere in grado di esercitare questa oppressione, il potere è ancora più imperiosamente costretto a volgersi all’esterno.
Del resto, a Todd interessa analizzare la sconfitta dell’Occidente. Ebbene, esso è “impegnato a difendere una democrazia che non esiste più” (p. 153). A sostegno di questa tesi Todd cita sé stesso (Après la démocratie, 2008) e un nutrito gruppo di autori, da Cristopher Lasch a Colin Crouch per sostenere la tesi di una democrazia occidentale in fase terminale. In realtà questi autori hanno idee molto diverse da quelle di Todd, partono da un’analisi più fine della complessità culturale e della stratificazione sociale delle nostre società occidentali. Invece, Todd afferma che la democrazia rappresentativa è stata vanificata dall’elitismo e dal populismo. La conclusione è delirante: “Annunciata dal pensiero dominante come la lotta delle democrazie liberali dell’Occidente contro l’autocrazia russa, questa diventa piuttosto un confronto tra le oligarchie liberali occidentali e la democrazia autoritaria russa” (p. 158).
Se Todd avesse letto Tocqueville, forse avrebbe invece capito che fin dal suo stesso sorgere la Democrazia in America (il testo tocquevilliano è del 1830) è fatta di gruppi, interessi, auto-interesse, rivalità e conflitti che sono essenziali e che vanno governati. Che i liberi Stati dell’America del Nord (come li chiamava Marx) realizzavano una forma di autogoverno ancora sconosciuta in Europa, anche se devono continuamente confrontarsi e scontrarsi tra loro e con lo Stato federale. Che il rapporto tra libertà ed eguaglianza è altamente problematico e sempre in bilico. Che l’uomo democratico è spinto dal proprio interesse e che dagli interessi in conflitto può nascere un equilibrio sempre provvisorio che chiamiamo bene comune. Che infine la religione riformata – sulla cui eclisse Todd costruisce il suo modello – aveva già allora cominciato a evolvere verso un deismo individualistico o una religione civile. Altro che la popolazione cristiana zombi di cui parla Todd (p. 164)!
Ancora più incredibile è che Todd esalti (p. 312 ss.) la patrilinearità dei paesi non occidentali: “Le famiglie nucleari si trovano ormai ovunque, nei palazzi di Mosca, nelle megalopoli della Cina, a Il Cairo o a Teheran; ma non per questo sono scomparsi tutti gli antichi valori, patrilineari, comunitari e refrattari al femminismo radicale”. Perfino l’omofobia è considerata in chiave geopolitica come un fattore apprezzabile: “uno sguardo alla mappa dell’omofobia mostra fino a che punto essa somigli a quella della patrilinearità. Ed entrambe illustrano l’isolamento dell’Occidente” (p. 317). Insomma, che nostalgia per il seppur controverso gran libro di Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente (1918), qui neppure citato.
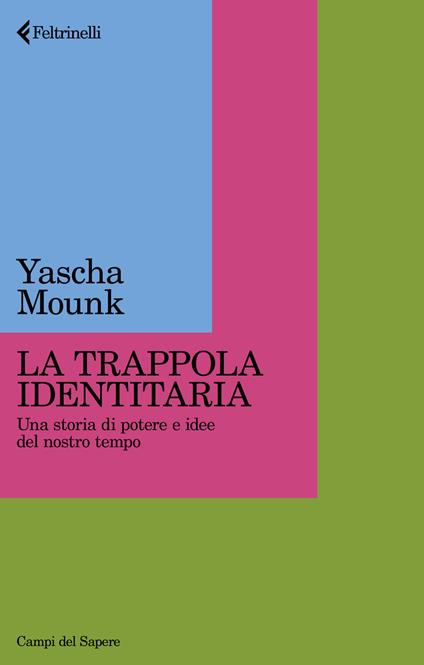
Forse possiamo passare allora al secondo testo, di Yascha Mounk, politologo di origine tedesca oggi americano, La trappola identitaria. Un saggio molto diverso dal precedente, molto documentato (100 pagine di note e bibliografia) e scritto con una profondità storica assai maggiore. Qui l’origine è un’altra: la tendenza della società occidentale (americana ma anche canadese e inglese) a passare dall’universalismo al separatismo progressista, isolandosi ciascun gruppo ed etnia da altri gruppi ed etnie. Non è una riedizione del razzismo ma una tendenza a riconoscere le diversità di genere, cultura di origine e orientamento sessuale etc. come attributi che ci definiscono e vanno riconosciuti. Una tendenza avanzata e progressista – fatta risalire alla lezione di Foucault – che si traduce nel suo contrario, in una trappola identitaria. In campi come la sanità, le arti, l’istruzione, l’economia ecc. si punta all’identità anziché alla uguaglianza come criterio-guida delle politiche. La “sintesi identitaria” sarebbe nei prossimi i decenni la nuova ideologia: spingerebbe l’Occidente a una società basata sulle identità. Questa per Mounk è una deriva che favorirebbe il populismo di estrema destra a cui vorrebbe invece contrapporsi.
Ma cosa c’entra tutto questo con il quadro globale da cui siamo partiti?
I regimi totalitari e autocratici, come la Russia di Putin, l’Iran di Khamenei, la Cina di Xi ecc. stanno attaccando l’Occidente proprio sui valori dell’individualismo e dell’universalismo, che sarebbero degenerati e decadenti, della cultura occidentale. Su questa base quei regimi rifiutano i diritti civili della persona e del gruppo, del genere e dell’etnia, che sono in quei regimi negati e perseguitati.
Per l’Occidente è quindi vitale questo tema dell’identità, che è l’identità stessa della cultura occidentale.
Infatti, tutto nasce secondo Mounk dalla fine degli imperi coloniali dell’Occidente, sulle cui ceneri in pochi decenni compaiono nuovi Paesi postcoloniali che devono cercare nuove identità. Le élite culturali postcoloniali le trovano però proprio nella cultura occidentale di cui sono eredi, formatisi nelle scuole e nelle università di Parigi, Londra, Oxford, Cambridge, Princeton, Harvard. La critica dell’idea di “Oriente” come costruzione occidentale, svolta da Edward Said in Orientalism (1978), deve molto proprio a Foucault. Gayatri Spivak, la studiosa postcoloniale indiana, proprio in discussione con Foucault e Derrida elabora la sua idea di “marcatori identitari” e di “essenzialismo strategico” per i gruppi sociali oppressi per etnia, genere, status etc. Insomma il pensiero postcoloniale guiderebbe questa svolta verso la trappola identitaria sia in Occidente che in Oriente.
Anche in Occidente, osserva Mounk, la trappola identitaria ha una sua storia lunga: la segregazione razziale ha prodotto anche una desegregazione (con l’abbandono da parte dei bianchi delle scuole pubbliche ad esempio) che si traduceva in ulteriore discriminazione. Meglio allora, sosteneva l’avvocato nero Derrick Bell, creare scuole separate ma davvero uguali, istruzione di qualità per bianchi e per neri! O ancora il caso delle Università americane dove proliferano gli African American studies, gender studies, queer studies, disability studies, Latino studies e Asian America studies. È l’ideologia del punto di vista, la c.d. standpoint theory, che si afferma. Il punto di vista di un gruppo oppresso permette di vedere meglio e in modo diverso l’intera società. Fin qui il resoconto di Mounk.
Invece, abbiamo bisogno di una polis integrata di diversi che forse non c’è più nella città anglosassone polarizzata, a New York o a Londra che pure hanno fatto la loro fortuna con l’ibridazione culturale, ma che c’è nella città mediterranea, a Napoli o a Barcellona, e in forme diverse nella città mitteleuropea, da Berlino a Vienna a Odessa, e che – proprio in questa fase drammatica di guerre –sappia essere un motore di cambiamento sociale universale. Nell’epoca delle identità, con tutto ciò che questo significa anche in termini di trappola identitaria, questa visione consentirebbe una risposta avanzata, una proposta di convivenza umana e di integrazione civile di cui abbiamo smarrito il valore.
Rivendicare l’identità, infatti, non significa arrendersi alla disuguaglianza e all’ingiustizia, da cui pure la storia umana è segnata, ma avviare un lento e tenace superamento delle difficoltà della democrazia, nelle parole di Max Weber.
Che questo sia possibile lo dimostrano – con le cautele del caso – i sondaggi Gallup riportati da Mounk alla fine del volume sulle aspirazioni degli “aspiranti migranti” nel mondo. Le democrazie liberali surclassano i rivali regimi autoritari nella capacità di attrarre potenziali migranti. Le prime 20 posizioni nella classifica dei paesi più felici al mondo sono tutte occupate da democrazie. Dei 30 paesi con l’indice di sviluppo umano più alto, 27 sono democrazie liberali. Così per le aspettative di vita, 29 su 30. Così per il PIL più alto, 27 su 30 (le eccezioni sono Singapore, Kuwait, Emirati). Sembra quindi che siano tuttora forti le aspirazioni verso la democrazia e i suoi vantaggi da parte degli aspiranti migranti. Peccato che le democrazie liberali non sembrino affatto interessate ad accoglierli, e questo sì rappresenta una sconfitta dell’Occidente. Il che ci deve spingere a vedere i limiti e le contraddizioni delle nostre democrazie, i rischi sempre presenti e perfino crescenti, ma per difenderle e migliorarle e non certo per affossarle.
A questo proposito, Mounk sostiene giustamente che la libertà di parola non va limitata da nessun potere di attori privati in grado di censurare il dibattito politico (alla Elon Musk). Che va superato il “separatismo progressista” favorendo in ogni modo il “contatto intergruppo”. Che occorre cioè mantenere l’orizzonte dell’universalismo.
Liberarsi dall’ossessione dell’Occidente era stato, una generazione fa, l’assillo di molti intellettuali del Medio e Vicino Oriente. Poi una generazione successiva, quella delle “primavere arabe”, ha invece manifestato la sua attrazione verso una società migliore che sembrava aver superato il risentimento dei padri (si veda Daniela Falcioni, Introduzione, in AAVV, Genealogie dell’Occidente, Bollati Boringhieri 2015). Ma è stata sconfitta, e anche questa è una sconfitta dell’Occidente. Oggi l’esplosione del conflitto in tutto il quadrante mediorientale, dalla Libia all’Iran, sembra aprire una nuova incalcolabile stagione.