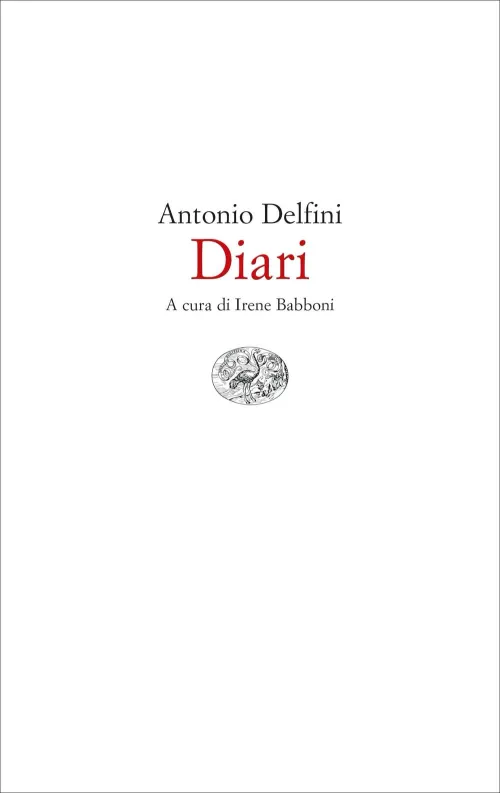Antonio Delfini: non sono fatto per i diari
Si può riassumere lo Zibaldone di Leopardi? Sembrerebbe, a rigore, impresa piuttosto ardua.
Ugualmente, di questa nuova edizione dei Diari di Antonio Delfini (Einaudi, 2022, a cura di Irene Babboni, con nota al testo di Claudia Bonsi), definita da Marco Belpoliti, nell'introduzione, uno “zibaldone a zig zag”, è difficile fornire un riassunto.
Proviamo però a gettare delle sonde dentro queste 406 pagine – scritte dal 1927 al 1944 ma con ampie sfasature cronologiche, riprese e ritorni – lungo alcune direttrici scelte.
La prima è quella che potremo chiamare del “metadiarismo”, le considerazioni sul genere “diario”, tenute dall'autore all'interno del diario stesso.
Anche perché la prima annotazione, del 14 aprile 1927 (Delfini ha appena diciannove anni), rientra a pieno titolo nella categoria prescelta: “Incomincio questo diario sperando che venga pubblicato in avvenire. Io non sono fatto per i diarii perché, quello che sento e che ho provato, mi piace tenerlo per me”.
Tipico di Delfini: compresenza paradossale di affermazione e negazione.
E il paradosso riveste addirittura valore inaugurale, dato che si ritrova invariato parecchie altre volte nel corso di queste pagine.
Ad esempio a p.55: “Ne ho abbastanza. Non voglio più scrivere il diario perché non serve”. E poi p.111: “A che pro scrivere sul diario?”. Ancora: il quasi trentenne Delfini, nel dicembre 1936, annota sconsolato: “Quando non c'è niente da fare, e non si saprebbe nemmeno che cosa fare, e non si ha niente da dire, e si è delusi; quando, si può dire, ogni fantastica gioia futura è assolutamente scomparsa dalle tue visioni; allora si decide di scrivere un giornale, un diario...”.
E nel 1939, riandando con la memoria alle origini (1927) delle sue pagine diaristiche, ne conclude che quegli esordi erano “noiosissimi”, poiché “ogni giorno ripeteva, con parole sempre più inutili” altrettanto inutili propositi e voti (p.333).
Non diversamente (p.351) nel gennaio del 1942 constata che “tenere questo giornale, oltre che mi annoia molto, so che non è affar mio, ch'è inutile, e che non mi servirà mai per l'avvenire”. Sarebbe meglio, molto meglio rinchiudersi, ballare, piangere, abbracciare, cantare!
Quando poi, il 14 gennaio 1944, si rende conto che è dal 31 agosto 1942 che non metteva mano al diario, conclude che le cose che avrebbe avuto da dire, e ne aveva avute svariate, “si ricorderanno da sé”, senza bisogno dell'ausilio della parola scritta.
Insomma: per tutto l'arco temporale della sua stesura questa scrittura è una scrittura che dubita di sé, che non crede molto in se stessa o, più probabilmente, che mette in scena, chissà forse a scopo scaramantico o apotropaico, un invincibile scetticismo su se stessa, continuamente smentito, però, dal flusso inarrestabile della scrittura medesima.
Non è solo il diario l'oggetto di questi diari; una larga parte, naturalmente, ha l'autore. Di chi dovrebbero parlare i diari di Delfini, se non di lui?
Ecco allora alcuni folgoranti autoritratti: uno brevissimo, quasi lapidario: “io, offeso non so di che, pauroso, timido e ribelle, filosofo, infelice e innamorato” (p.350); un altro molto più articolato: “Son poeta, filosofo o musicista?... Passeggiando, profilo autobiografie, elaboro romanzi, novelle, articoli, preparo battaglie, vittorie e sconfitte; mi vedo alla direzione del giornale vestito di velluto verde come un montanaro, e il fazzoletto al collo, bianco al giorno di festa e nero in quello di lavoro...” (p.86).
Fino a questo, programmatico e in terza persona: “Non c'è che da rifugiarsi in se stessi e vivere in mezzo agli uomini cercando di farsi attorno il massimo di autonomia” (p.131).
“Delizioso nullafacente” e “collezionista di inutilità assolute” non sono propriamente riferiti a sé (piuttosto a protagonisti immaginari di racconti non scritti), ma si adattano, ci pare, magnificamente al nostro autore, che si seccava non poco con chi si ostinava a chiedergli la sua “carta di positura nel mondo” (p.132).
Delfini era appunto un letterato fuori dagli schemi, autodidatta (“autodidacte” come scrive lui a p.267) ma che si determina, anche in questi diari, nel rapporto con i letterati “veri”, “ufficiali”, quelli fiorentini, ad esempio, o quelli romani; sentendosi, lui modenese, sempre un “provinciale”. (Ma tenendo conto che, nella torrenziale e splendida Prefazione del 1956 al Ricordo della Basca, è detto che “i veri provinciali sono i romani”).
“Le cose barbose bisogna lasciarle ai letterati” (p.77). “Non credere che io dica del solito stupido bruciante sole dei poeti di professione” (p.140).
Bisogna essere “cantori veri senza pressioni altrui” (p.75).
“Meno incontri tra letterati... un po' più di vita tranquilla (contemplativa) solitudine. Vivere un poco di più con gli altri, con quelli che non sono letterati” (p.273). “Tacere e non esigere che tutto il mondo sappia o si interessi del tuo silenzio” (ivi). E anche: “perché non si tace? Forse il silenzio è un lavoro troppo duro” (p.226).
Lo scrittore deve essere libero e, “per rendere la libertà allo scrittore” non bisogna “assediarlo con polemiche inutili. Strapaese e Stracittà, avanguardismo e passatismo, calligrafismo, contenutismo” (p.191).

Vengono in mente le celebri invettive della già ricordata Prefazione al Ricordo della Basca: “Andate un po' tutti in c... con la forma e il contenuto”, a proposito di un'altra di queste sterili contrapposizioni tipica dei primi anni Trenta.
A Delfini i letterati laureati chiedevano soprattutto soldi, per finanziare le loro riviste, e lui, ricco e generoso, pagava e si faceva sfruttare. Ma fino a un certo punto.
Il suo provincialismo, vero o presunto, si traduceva in una faticosa e ostinata conquista, o riconquista, solitaria della Tradizione. Con l'avvertenza però che Delfini è perfettamente consapevole che non si dà il Nuovo Assoluto, che tutto è già stato detto: “Tutto si sa prima che possa essere cantato” (p.78) e anche: “io so che in arte nulla è superato” (p.275).
Vengono in mente certe posizioni di Celati, quelle delle Note d'avvio (1992) dei Narratori delle riserve: “il visibile è sempre il già visto, il dicibile è sempre il già detto”. E forse anche la poetica del “sentito dire” del Celati degli anni '80 potrebbe dipendere da queste considerazioni del Delfini 1928-1930 (pp.78, 79 e 137: “la filosofia che abbiamo vagamente studiato, o meglio intravveduta per sentito dire”).
Un corposissimo capitolo di questi Diari è quello che riguarda le donne.
L'eterno adolescente Delfini è sempre attanagliato dalla timidezza, o timidità. In questo campo non c'è storia, non c'è evoluzione. Il grido del 1° settembre 1927: “tutto il dramma della mia vita era la timidità” è perfettamente sovrapponibile all'esclamazione del 17 maggio 1941 “la mia maledetta timidezza”.
Tra Modena, Viareggio, Firenze, Roma sfilano teorie di ragazze dagli occhi verdi, dagli occhi d'oro, dai capelli biondi, dai capelli neri, Nadie, Adriane, Gabrielle... Sono sempre sfuggenti o fuggenti. Sono più che incontri, mezzi incontri o incontri mancati.
“Le donne sono, per me, come le case. Si desiderano, ma quando si visitano per acquistarle, si trova sempre che l'ubicazione, la mancanza di un dato corridoio, certa stanza obbligata... non sono quell'ideale che si era sognato” (p.341).
Le donne come le case, dunque.
Come non pensare al grande trauma della vita di Delfini, di cui naturalmente è parola anche in queste pagine, e cioè la vendita obbligata, per far fronte ai debiti, della sua grande casa modenese di Corso Canal Grande 21, nell'ottobre del 1935?
La perdita della Casa si rispecchia nella mancanza della Donna.
Ma la Donna ha a che fare anche con la scrittura.
Pare quasi che trovare il coraggio di scrivere a una donna equivalga a trovare il coraggio di scrivere in assoluto (p.141).
E certo la cesura che pare avvertirsi tra le pagine diaristiche dell'aprile 1928 e quelle del settembre del medesimo anno, lo stacco tra aridi elenchi e prosa esteticamente molto più valida pare doversi ascrivere alla presenza di una ragazza, “una ragazza con gli occhi colore del mare”, dove le bellezze di lei si riverberano in quelle del paesaggio e viceversa.
Certo, questa è una Donna oggetto di amore platonico. (Non mancano, a onor del vero, notazioni più prosaiche su case da lire dieci o lire venti, dove Delfini aveva talora impellenza di andare a “sfogarsi”).
E il platonismo non pare assente da queste annotazioni. Non è il “platonismo depravato” della più volte citata Prefazione del 1956. È proprio qualcosa che sembra discendere dalla noesi platonica effettiva. Delfini aspira a una conoscenza per rivelazione. Attende la luce folgorante. Lo sprazzo che illumina le tenebre. Il fulmine. Il lampo (p.106 e 111).
La Donna quindi è una creatura letteraria e filosofica quante altre mai. Coesistono con essa però, contraltare penoso, anche le “virago senza forza”, “vere streghe prive di incantesimi”, “sudicie larve animali”. Queste sono soprattutto quelle che Delfini definisce le “donne politiche” (p.379), corresponsabili dell'avvento e del consolidamento del fascismo, forse anche più degli uomini.
Ciò ci permette di sondare la dimensione politica dei Diari.
Nel 1932 Il Nostro, che nel 1951 darà alle stampe il manifesto per un partito conservatore e comunista in Italia, delinea già il programma embrionale di un Partito rivoluzionario o insurrezionale d'Europa. Si profila una sorta di partito camaleonte che sia contemporaneamente liberale conservatore democratico repubblicano comunista, a seconda dei casi e delle necessità (p.180).
Poco oltre (p.187) Delfini enuncia il proposito di “organizzare una nuova élite”. Precisa poi che uno dei capisaldi del nuovo programma politico sarà l'abolizione dei debiti (“I debiti verranno cancellati per tutti”). E qui, a qualunque modesto cultore di storia romana, viene un colpo. È lo stesso identico programma di Catilina: “tabulae novae! Tabulae novae!”. Così come a p.267 viene annunciata la futura “abolizione della tirannia della pigione” e qui affiorano alla memoria le posizioni ciceroniane in materia, nettamente contrarie ovviamente.
Straordinaria persistenza e vischiosità della Storia!
Delfini, fascista a dodici anni, poi comunista e monarchico, è però in effetti, a ben vedere, un anarchico primordiale, quale fu Adamo, per usare le sue parole.
Un uomo che non si vuole confondere con il “rigoglio della mediocrità” e con altri uomini che non sono che “numeri”.
Uno di quelli o quelle che si differenziano dalla massa anche solo per via del nome.
Infatti si resta colpiti dall'inesauribile fantasia onomastica di Delfini, che si sbizzarrisce per tutto il corso di queste pagine a inventare nomi per possibili protagonisti dei suoi racconti: Luigi Guasti, Geminiano Sallustri, Corrado Pacca, Edelberto Kranfer Michetti, Caterina Sfenci Guidalustri, Tacitacone e Epidaura Bellusio, il conte Daniele Turbin della Baratta, Drusilla Livi, Lorenzo Matricolo, Lorenzo Peterpel, la principessa Permallino, i Ballenga Breviari, Nomer Don, Elisabetta Farnesani o Marfesani o Feresari, Farmisani, Darfisani, Eruda, Erada ed Erida, Amilcare Buggiaroni, Giananastasio Cirocchi e così via così via in un folle elenco che potrebbe continuare a lungo e aggiungersi a cognomi poi effettivamente usati in racconti editi, come l'immortale Gnochirignocchi di Il 10 giugno 1918.
In conclusione, un libro estremamente ricco, estremamente vario di un autore forse molto meno bizzarro e molto meno ingenuo e assai più colto di quanto ancora sia comunemente ritenuto.