Circe di spalle, una mitobiografia
Nel mito di Edipo Freud vedeva la messa in scena di un normale complesso infantile, Joyce, in Ulysses, vedeva un’odissea in una normale giornata di un uomo normale, Leopold Bloom, nella sua città di Dublino. Edipo, Ulisse: figure mitiche attraverso cui una vita comune fa trasparire i suoi diversi aspetti, come un raggio di luce rivela la sua composizione multicolore attraversando un prisma trasparente.
È un’operazione che più modestamente facciamo tutti fin dall’infanzia, quando raccontiamo noi a noi stessi in forma mitica: io ero questa… io ero quello…, e il verbo all’imperfetto ha la magia di trasportarci fuori dal presente, in un tempo del passato e del futuro dove giochiamo un ruolo fantasticato: i racconti iniziali, o iniziatici, in cui mettiamo in scena noi a noi stessi sono “mito-biografie” spontanee.
Il libro di Stefania Portaccio, Circe di spalle, è invece la costruzione intenzionale di una mitobiografia: la ricerca di un mito in cui si possano proiettare e rappresentare i nodi della propria esistenza. Poiché il mito è una storia codificata da una tradizione culturale, riconoscersi in esso è come uscire da una dimensione strettamente privata verso una dimensione pubblica, render sé stessi comunicabili ad altri e a sé stessi, concepire che la propria vita singolare non è isolata ma inscritta nel flusso di una vicenda collettiva, o universale. Un atto essenziale della cura del sé sta infatti nel trascendere la chiusura del sé in sé stessi, nell’attraversare i confini dell’“immaginario che ci immagina” come destino segnato, per riconoscere la propria singolarità nel contesto dell’umano quale si rappresenta nell’estensione metaforica e simbolica del mito.
L’Autrice ha incontrato Circe come controfigura partendo, ci dice, da Joyce prima che da Omero.
È stato l’Ulysses di Joyce ad aprire il varco […] È stato incontrare Circe in un testo del Novecento a convincermi che la sua permanenza implicasse una potenzialità, e a darmi agio a guardare la Circe omerica con una curiosità e una libertà che non avrei avuto altrimenti. (p.9)
Nell’Ulysses di Joyce, Leopold Bloom attraversa la sua odissea di un solo giorno tra situazioni, immaginazioni e pensieri frantumati in cui il prima e il poi si contraggono come in un quadro cubista, in cui percezioni immediate e rievocazioni si compenetrano come in un’immagine surrealista, dove presupposti psichici e mentali filtrano situazioni reali e danno loro figura interiore e linguaggio. In quella giornata normale e insieme esemplare di Bloom, Circe compare nel capitolo dei bordelli, ma più come situazione che come singolo personaggio. È l’attraversamento di un caos di metamorfosi, di disgusti e piaceri, di eccitazioni e umiliazioni, di innocenza e sensi di colpa, di rivolgimenti del maschio in femmina o al contrario, rimbalzando da un sentore all’altro come in un lunghissimo affollato sogno fluttuante. È un attraversamento psichico di fatti in un ambiente urbano vivace e lordo, di lampioni e penombre, di afrori organici e di sferragliamenti meccanici di tram:
[…] nell’episodio non vi sono monologhi interiori: tutto è detto, l’irreale, il fantasticato, diventa reale, in un rovesciamento prodigioso di tutta la cornucopia dell’inconscio. Quale inconscio? Quello di un uomo irlandese, intriso del cattolicesimo che detesta, della sessuofobia che aborre, del vittimismo irlandese che deplora. Di un uomo intessuto fino al midollo di tutta la cultura occidentale, un materiale che lo compone e lo avvolge e che lui vuole strappare e che gli strappi mostrino il sotto. (pp. 77-78)
Questa intenzione di strappo per vedere il sotto anima tutto il libro di Portaccio.
Mentre la Circe di Joyce, Bella Coen tenutaria di bordello, è un ambiente più che una persona, la Circe che incontra l’Autrice nella sua rilettura dell’Odissea è invece una persona vera e propria, tra luci e tenebre ma unitaria, distruttiva ma soprattutto costruttiva, capace di riportare all’umano sé stessa e Ulisse attraverso l’eros: l’eros del faccia a faccia, nell’amplesso ma più ancora nella conversazione.
Avrei trattenuto, hanno detto, Odisseo con il sesso. Vi dico invece che è rimasto – si è distratto dal compito – per la conversazione. E per la danza. E se la mia conversazione era intrisa di eros, e la mia parola e la mia danza erano seduttive, era l’arte della persuasione e della seduzione che erano in campo. Roba fine, non competenze da bordello! (p. 21)
Conversare alla pari, anche se in un linguaggio e per concetti culturalmente modellati in prevalenza dal maschile: conversazione in cui il femminile suona con un proprio accento, eccentrico.
Si alternano nel testo passi in caratteri tondi, in cui parla direttamente l’Autrice, e passi in corsivo in cui parla la Circe immaginata: è un confronto tra due voci narranti, un’autobiografia diretta e una a distanza, proiettata sulla figura omerica. Ne esce un doppio ritratto, di Circe e dell’Autrice, non come identità raggiunte, ma nel processo di una trasformazione in corso. Trasformazione delle rispettive singolarità e insieme del femminile. Ma nella Circe potente perché anche divina si proietta un’aspirazione, quella di farsi capace di produrre eventi, cose, pensiero, una condizione femminile che vuol godere della sua pienezza, che vuol superare i limiti dell’immaginario che immagina il femminile, e agire sul mondo aldilà di quei limiti («per seguir virtute e canoscenza» al pari dell’Ulisse dantesco), e al contempo si manifesta la persona che aspira alla relazione e a coinvolgersi con l’altro:
Ho scelto Circe perché trasforma: svela e coltiva. Se in lei residua la Grande Dea è nel suo essere appartata, periferica, esiliata, ma questo s’impasta con il desiderio, non solo di esserci, ma di produrre, col proprio esserci, cambiamento. L’ho scelta per polemizzare con l’immaginario che ci immagina e il suo monoteismo, a partire non da una teoria ma dall’esperienza, che ci mostra evidentemente molto più vaste, più consapevolmente vaste, di come appare allo sguardo – anche il nostro stesso sguardo – reso pigro dall’abitudine. (p. 79)
Il libro si apre con una sessione psicoanalitica:
1991. Il dottor Bianchi mi parla della figura della domina, la signora, la donna in pienezza. Insediarsi su quel seggio, assumerne il ruolo. Non ricordo a che proposito ne parla, a volte è a sproposito che parla, mostrandomi figure che piacciono a lui, e magari anche a me, ma che non posso, non so incarnare. La Madre, la Moglie, la Signora. Io sono l’Orfana rabbiosa, L’Offesa, la Mendicante. (p. 11)
Molta strada è stata fatta: la Circe con cui ora, trent’anni dopo, si confronta l’Autrice è di tutt’altra pasta:
No, non facevo quel che facevo perché offesa […]. Ma certo la mancanza di riconoscimento mi pesava, era un nervo scoperto. Perciò lui [Ulisse] mi aveva avuta, me e la mia amicizia: mi aveva riconosciuta potente. (p.16)
E, in carattere tondo, il commento:
Chiedersi “cosa le è successo, come mai fa questo, di cosa si vendica, cosa le hanno fatto?” non è in effetti il modo più proficuo per avvicinarla. E’ una dea, ed è una dea arcaica. Lo fa e basta, o meglio, lo fa perché usa il potere e il suo arbitrio, il suo capriccio, il suo eccesso. Ed è anche una donna. Né in quanto dea né in quanto donna è tenuta alla bontà e in quella domanda vi è invece il sottinteso che la donna agisca violentemente solo in quanto risponda ad un torto. Che la violenza femminile sia solo reazione. Invece Circe agisce la sua natura violenta, fa prepotenza. Vuole, può, sa e fa.
Per esempio il potere di addomesticare. Un potente desiderio femminile. Addomesticare la ferinità – nel senso più lato – è, se vogliamo, una risposta femminile alla paura di quell’ignoto altro, il maschile, la risposta maschile alla medesima paura essendo l’esclusione. Ecco, non potendo escludere i maschi da ruoli, cariche, poteri, e segregarli in zone dedicate, ecco che la risposta è di assimilarli quanto più è possibile, snaturandoli. […]
Ma può pure darsi che “addomesticare” l’uomo sia un aspetto di quella femminile «passione per l’altro» che tende verso l’inassimilabile e sempre mancante, con la seduzione e la sfida sempre presenti dell’addomesticamento.
Perché l’addomesticamento, come la civiltà, è seduttivo. E, come la civilizzazione, pota e quindi mutila la pianta naturale, forgiando la direzione del suo sviluppo. […] (p. 17-18)
La rappresentazione mitica è attivazione originaria dell’immaginazione, precede i costrutti della logica e dei concetti perché ne è la fonte e il movente. Affine al fiabesco, non si propone come reale ma come vero, o meglio come significante del vero. Il reale è mutevole, il vero è la sua sostanza duratura, il suo significante simbolico, dove si ripropongono le domande di fondo sulla verità dei rapporti: quelli tra i limiti e le possibilità, tra destino e decisione, tra necessità e libertà, tra l’essere in atto e l’essere in potenza. Attraverso racconti o figure, il mito non propone soluzioni ma paradigmi, su cui misurare la propria esistenza e comprenderne l’estensione. È una storia che presuppone una distanza di tempo e di luogo, che inibisce l’identificazione. Per questo nel mito non ci si identifica, ma piuttosto ci si rispecchia. L’inattualità dei suoi eventi ci aiuta ad allontanarci da noi stessi per riconoscerci, dislocandoci su un altro sfondo rispetto a quello sedimentato dall’ abitudine e dai pregiudizi inavvertiti della spontaneità.
In quanto racconti o figurazioni, i miti si presentano con una certa logica narrativa o realismo figurativo rendendosi accessibili all’esperienza comune. Si rappresentano in un linguaggio e nell’ambivalenza del linguaggio, cioè nella sua oscillazione tra significante e significato. Dove la parola e il segno in quanto significanti possono essere intesi alla lettera, univoci e perciò caduchi, oppure come forme espresse non direttamente esplicate, aperte alle molte interpretazioni e alternative, a seconda dei tempi.
Nell’Odissea l’incontro con Circe lo racconta Ulisse alla corte dei Feaci. È la sua versione.
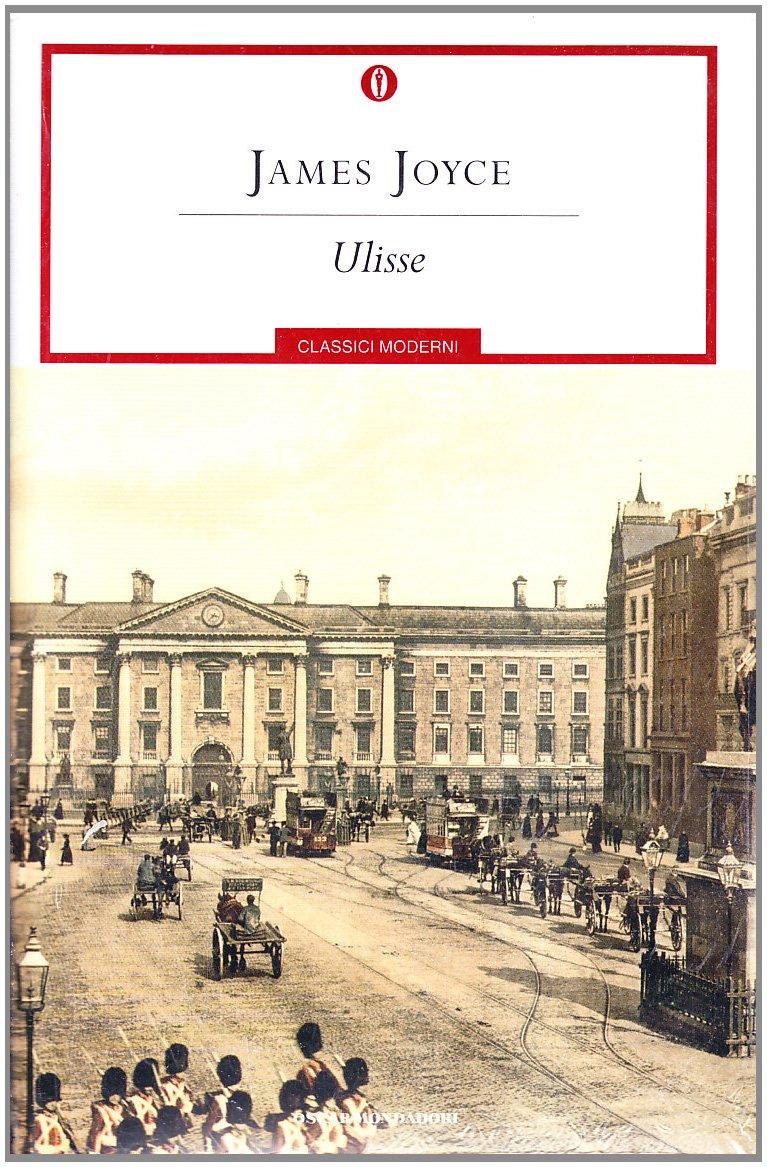
Abbiamo molto giocato a “similitudini” con Odisseo, e lui era bravo. […] quello che lui non racconterà, né ai Feaci né a Penelope, sarà la nostra conversazione, durata un anno. (p.14)
Quale storia avrebbe invece raccontato Circe? Avrebbe, intanto, messo in primo piano lo scambio, la conversazione. Il libro immagina questo cambiamento del punto di vista. Che però è anche uno sdoppiamento; è il punto di vista di chi scrive che interpreta il punto di vista di Circe immaginandola nella sua sincerità perché è vista di spalle, o meglio “a profilo rubato”.
La vedo di spalle, ma non proprio. Sguincia. E’ intenta a fare quello che fa, e se mi ha sentita non lo dà a vedere. Non teme agguati ed intrusioni, quindi non presta orecchio al fruscio di fogliame che ho prodotto, forse, avvicinandomi. Siamo vicine alla casa. Borbotta quasi fra sé, ma non proprio, parole che non capisco, e compie brevi gesti misurati.
Che non si senta minacciata e non si nasconda è la cosa che subito ammiro, ma che non mostri né riservatezza né esibizione aggiunge fascino, stile, al suo potere. Ed è il suo potere che mi ha portata a spiarla. E’ per indagare il potere che sono qui. Anche. (p. 13)
Pare non avvertire d’essere osservata, ed è quindi senza maschere. Maschere e finzioni che d’altra parte Circe sa ben usare quando non è sola ma si confronta con l’altro, con altre divinità, con Ulisse o con i compagni di Ulisse. La stessa Circe è doppia perché è una dea e una donna, come dea è più potente di Ulisse, ma finge e sente di fronte a lui il timore della sua violenza. Stirpe del Sole, nasce dea ma come donna vuole sperimentarsi, con Ulisse.
Lo spostamento del punto di vista è un procedimento già adottato da Stefania Portaccio nel suo precedente Il padre di Cenerentola (Manni 2016). Ma non ricorre alla linea dei racconti di Akutagawa o del derivato capolavoro cinematografico di Akira Kurosawa Rashomon, o del Così è se vi pare di Pirandello, o degli Esercizi di stile di Queneau nei quali, nel moltiplicarsi delle versioni, i fatti persino si dissolvono. Qui si tratta invece di punti di vista diversi su fatti che non si intendono dissolti, ma anzi sono pietra di paragone di due diverse sensibilità e mentalità che si misurano su una stessa vicenda vissuta da due lati, quello dell’uomo Ulisse e quello di Circe, donna e dea. Ma il libro corre anche su due storie parallele, quella di Circe e quella dell’Autrice, l’una a commento dell’altra. L’uno sull’altra si affacciano il mito e la vita vissuta.
Le pagine direttamente autobiografiche (le vicende di famiglia e d’ambiente sociale, le immaginazioni dell’infanzia e dell’adolescenza, i vincoli affettivi, l’essere figlia e madre), tra molte digressioni vivaci, e diverse poesie (l’autrice è poetessa) comprendono un racconto in cui, ragazza, immagina l’incontro fiabesco/mitologico con un mostro marino maschio, che suscita in lei repulsione e insieme desiderio, nella sensualità del sole estivo e dell’acqua.
Ma le diverse linee del libro si avvolgono tutte intorno ad un problema di fondo: lungo i millenni della nostra civiltà, la donna è stata ospite, gradita e disprezzata, esaltata e umiliata, del mondo dell’uomo. Perché l’uomo rappresenta il paradigma dell’umano mentre la donna è immaginata come una variante, laterale al paradigma. Con una specificazione in più che la diminuisce perché la limita, quella di essere la femmina dell’“uomo in generale”.
Nell’«immaginario [androcentrico] che la immagina», la donna ha qualcosa di straniero: è l’imbarazzante dell’indefinito, del non del tutto decifrabile, del non del tutto assimilabile, o ha il fascino e il perturbante dell’esotico nel familiare. Spesso la donna è tale anche a sé stessa: alienata, almeno in parte, entro il paradigma dominante. Ora, nella vicenda di Circe questa condizione appare rovesciata: sono degli uomini che approdano da stranieri in un regno di donna. Ma di una donna che ha poteri divini e magici, ed è dunque capace di trattare gli uomini secondo un immaginario femminile che li immagina: che negli uomini (nei compagni di Ulisse) coglie l’inconsapevolezza, l’incapacità di percepire in lei la potenza, la trascendenza nel suo aspetto di donna; un immaginario che porta al limite quello che le donne vedono spesso nell’uomo, cioè l’animale, e quello che le donne tentano di fare all’uomo, l’addomesticarlo. Circe fa appunto dei compagni di Ulisse degli animali domestici. Solo in Ulisse, che sente il timore di lei perché riconosce la sua potenza, Circe coglie la possibilità di una relazione sottratta ai paradigmi: una passione per l’altro che non rinuncia alla passione per sé.
Nel primo incontro con Ulisse Circe mostra d’improvviso di sottostare al modello consueto, al timore e al soggiacere,
Omero mostra, da maestro, la repentinità del mio cambiamento, affinché ce ne si stupisca, e infatti repentino e ingannevole sembra il mio gesto. Ma io ero sincera. Felice e grata. Sembra ch’io ceda alla spada sguainata, mi sottometta alla violenza. Sembra così, lo so. Ma io ho sentito il tremore che speravo e ne sono felice: Odisseo mi fa paura, ma anche lui ha paura, se è diffidente è perché mi vede. Mi ha vista.
[…] Siamo ad armi pari, anche se per esserlo occorre che tu sia uomo e io Dea. (p. 26)
Un’asimmetria, a compensare lo squilibro opposto, inscritto nel paradigma a dominanza maschile:
[…] la maggiore libertà maschile di esplorare orizzontalmente la tastiera umana, saggiando non tutte ma certo molte delle sue tonalità.
Invece la potenza femminile […] quando viene percepita, è verticale: divina o infera. Medea grondante sangue, Deus (Dea) ex machina, o la Vergine Assunta. (p. 26-27)
Circe è “vista di spalle”, di fronte ci parrebbe falsata, investita dagli stereotipi paurosi sul femminile potente, (la strega, la maga maestra di incantesimi, la manipolatrice che induce la regressione all’indistinto e al caos fuori dalla ragione e dai codici, che travalica le distinzioni tra le specie confondendo l’uomo e la bestia, che induce l’uomo alla bestialità e lo asservisce, lo vincola, ne inibisce la potenza o se ne appropria…). Di questo Ermete, nell’Odissea, avverte Ulisse, e gliene fornisce gli antidoti. Ma questi antidoti finiscono per non essere che rimedi a che l’incontro non sia con il ruolo e la professione della maga, ma con la Circe persona.
La maga trasforma gli uomini in animali: è una sua professione. Ma è il suo desiderio? O è la proiezione, che Circe fa sua, del timore maschile verso il femminile? Il timore di non essere all’altezza della sfida tra i sessi? Quel timore per cui l’uomo si vale della forza per subordinare la donna, per cui lo stupratore o il femminicida giustifica a sé stesso la sua aggressione come vendetta? Vendetta dell’umiliazione che la donna ha il potere di infliggere.
La maga che trasforma gli uomini in bestie è la facciata ufficiale di Circe. Vista invece dietro le quinte e senza trucco, Circe ci appare pronta alla relazione con un uomo che riconosca la sua potenza e perciò provi timore proprio di lei, e non più dei suoi sortilegi: la donna/dea è consapevole della potenza propria e dei limiti dell’altro, ma vuole Ulisse autentico e non addomesticato, perciò acconsente all’immaginario maschile che è in lui, e lascia ad Ulisse l’ingenuità di immaginare sé stesso come l’eroe che determina la situazione. Eppure Ulisse ha bisogno di sentirsi protetto dai rimedi o placebo che Ermete gli ha offerto, a disinnesco della paura stereotipa della maliarda e della sua malia. Ma gli artifici di Ermete per lei fanno parte del gioco, del suo farsi gioco degli stereotipi, anche se Ulisse li prende invece sul serio e se ne sente rassicurato: il mortale prende sul serio gli artifici rituali che Circe, che è donna e dea, prende invece per gioco.
Nel senso comune, una donna senza uomo e senza figli (qual è Circe),è una donna sola, quindi fuori ruolo, fuori controllo, sospetta. Dopo la sua storia d’un anno con Ulisse, Circe lo lascia andare, anzi favorisce la sua partenza, gli restituisce i compagni fatti di nuovo uomini, suscita venti favorevoli alla sua navigazione, gli insegna la via per accedere al mondo dei morti. Nel congedo, si volge dalla battigia per tornare all’oscurità e al rigoglio della sua isola. Dopo quel tempo di vulnerabilità, di «esposizione alle fantasie segrete» con Ulisse, lo lascia andare non offesa, sa tornare a sé stessa:
L’avrei lasciato andare – hanno detto – perché m’ero stufata, perché non ho cuore. Non piace, allo sguardo sentimentale, la sollecitudine al momento del distacco, frutto maturo di affetto e non di disinteresse. (p. 21)
Circe però non si riduce certo alla saggezza del ricomporre, del rammendare, del ricucire:
Una saggezza, volendo, femminile, ma manca ogni magia, manca l’eccesso. Manca l’urto dell’insistemato, la realtà ostica e divina dell’insistemabile, e prevale la sistemazione: il comporre domestico così caro al femminile.
Vale per le donne la mitezza come programma? No. Bisogna aver usato le armi per decidere di deporle. (p.40)
Né Atena, né Didone, né Grande Madre, né l’Assunta che rammenda i conflitti, né domina della casa, né dominata dalla passione, né rifugiata nella frigidezza, Circe è altra cosa:
Kerényi definisce Circe “etéra”, dando a questo attributo un valore di libertà dai compiti e dai ruoli, di figura della soglia tra mondi.
Sulla sua scorta io penso Circe etéra in quanto eterodossa: non ortodossa all’immagine materna, non ortodossa all’immagine dell’amante gelosa e vendicativa, non ortodossa all’immagine dell’abbandonata, l’annientata. Non ortodossa all’immaginario. (p. 32)
Cogliamo Circe nella sua vita attiva e autonoma, libera e dominante nella sua dimora, Eea, che è un’isola. E l’isola è luogo riservato, al riparo dalle influenze estranee e soverchianti. L’isola di Circe è luogo protetto di sperimentazioni pratiche e mentali. Al riparo dell’isola, Circe accoglie in Ulisse l’altro, l’estraneo, ma senza deformarlo, per coinvolgersi in una sperimentazione dell’umano. Nell’elaborare un’idea di relazione, in cui la passione per l’altro non implichi la rinuncia a sé, ma implichi al contrario, anzi sia generata, dalla passione per sé, il femminile ha ancora bisogno di un’isola
[…] Eea non è il mio luogo originario. Nel mio luogo originario ero dispiegata e qui sono avvoltolata. Ma posso svolgermi e coinvolgermi, e questo farò con Odisseo, che ho atteso, e posso tornare a me, dopo Odisseo, perché ho un luogo, che è Eea. Ma non è la mia dimora. La mia dimora, come dea e come donna, è stata colonizzata, occupata, popolata di idoli e fantasmi. La mia impronta abrasa. (p. 20)
Quella di Circe, e quella del femminile, è ancora un’odissea vagante verso approdi per ora indefiniti.
[…] è il soggetto-donna […] che ancora non si è formato, e che quindi riesco già a percepire ma non compiutamente, non a tutto tondo. Una silhouette. Qualcosa cui aspirare ma che non sappiamo ancora come sia fatto. (p.84)
Circe di spalle, una mitobiografia di Stefania Portaccio. Mimesis/Philo-Pratiche filosofiche, Milano 2022







