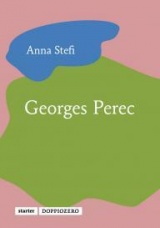Speciale
Un po' di compassione
“Difficile non essere preda di compassione davanti al mare di dolore nel quale affonda il tempo che viviamo” scrive Ferdinando Scianna. L'attualità, le tragedie di Gaza, gli orrori in Siria e Iraq, le quotidiane stragi dei migranti nel Mediterraneo, ci sollecitano ogni giorno. Eppure è proprio in questo tempo che tale sentimento, o affetto, è vissuto in modo ambivalente, e suscita diffidenza.
Abbiamo pensato di invitare studiosi, artisti, fotografi, scrittori, ad approfondire il tema, provando a restituirne la complessità e a raccontarne le implicazioni.
Susan Sontag scrive che la compassione è un’emozione insufficiente, un sentimento facile e mistificatorio che ha bisogno di essere tradotto in azione per non ridursi a una dichiarazione d’impotenza che allontani da ogni assunzione di responsabilità e, dunque, da ogni abito politico.
Ma non è forse, questa condanna della compassione, uno dei tanti segni della malattia del nostro tempo, della sua deriva individualistica e prestazionale, che pretende di cancellare la mancanza e lega alla vergogna ogni manifestazione di debolezza?
Ripensare questo sentimento potrebbe allora diventare un’occasione per riconsiderare il nostro rapporto con l’assolutamente altro rispetto all’angosciante potere dell’uomo, quello che Elias Canetti ci invitava a smettere, sdraiandoci per terra tra gli animali e guardando alle stelle come occasione di salvezza. Vi è, nelle parole di Canetti, un invito a partecipare della Natura abbandonando la pretesa di dominio su di essa. Si tratta di accettare il dolore, l’imperfezione, accettare di non poter estirpare la fragilità della nostra condizione: la compassione non può trovare posto in un sistema mondo che opera sulla base della necessità e della logica di potere.
Dare ospitalità all’altro volto dell’umano, aprire uno spazio che vada oltre il sapere e il possesso delle cose, che mostri come il contatto nasca da un’esperienza di incompiutezza.
Esisterà pur sempre un pezzetto di cielo da poter guardare, scrive Etty Hillesum nel suo diario, e questo ci deve rendere capaci di vivere anche senza libri; di soccombere; di accettare il ‘dolore’ come parte di questa vita. In una mattina presto del 12 dicembre 1941, la giovane donna – che morirà ad Auschwitz nel novembre del 1943 – racconta di essere invasa da una sorta di dolcezza: una nuova bonaccia segue i troppi pensieri dei giorni precedenti, l’affanno, una ricerca interiore intensa e faticosa. La vita, scrive, sembra filtrare più mite, e lei sente di essere tutt’uno con essa. Attraversata da enormi pretese su di sé, dalla ricerca di una forma propria, Etty sa che la propria intuizione precede di chilometri la conoscenza. La sua ansia di sapere si acquieta; vi è un ritmo, scrive, cui è necessario dare ascolto.
Leggendo le pagine del diario, meraviglioso, di Etty Hillesum, si ritrova una forma di resistenza, una forza della passività, del patire: “stare nella croce del tempo”, per usare le commoventi parole di Laura Boella, facendo esperienza della perdita del centro. Il contatto diretto con quello che accade, la capacità di lasciarsi attraversare dagli eventi che inchiodano l’individuo alla propria mancanza, non testimonia solo l’ostinata resistenza esistenziale della giovane donna. Le pagine del diario ci invitano a considerare la passività, il patire, anche come occasione di un’educazione interiore che sia, insieme, conoscenza e trasformazione del sentire e del pensare.
La compassione, in questa prospettiva, apre a una relazione con l’incomprensibile, e anticipa – nutrita com’è di immaginazione – quello che la ragione non può spiegare. C’è una verità che non mira alla conoscenza, quella che Derrida leggeva nelle confessioni di Sant’Agostino: domanda di perdono indipendentemente da ogni desiderio di dire il vero. Le lacrime, nella lettura del filosofo francese, sono la verità del testo, lacrime che, velando la vista, conducono l’uomo oltre ciò che gli occhi guardano e la parola descrive.
Si tratta, allora, di fare pace con la possibilità di pensarsi non solamente come soggetti di conoscenza. In gioco è la messa in pratica della verità, la dimensione etica, l’essere soggetto dell’azione retta: quella verità che Foucault definisce etopoietica, una verità non decifrata dalla coscienza né elaborata dallo studio, che può soltanto “essere letta nella trama degli atti che vengono compiuti e delle posture corporee che vengono assunte”.
Non si è realizzata la nuova alleanza auspicata da Isabelle Stengers e Ilya Prigogine: non si è ristabilito alcun patto tra natura e cultura capace di condurre l’uomo al di là della propria attitudine predatoria. Accanto all’esercizio della ragione deve allora essere possibile recuperare un’educazione al sentire insieme, al con-patire, al con-agire.
Io non credo, allora, che la compassione ci allontani dalla necessità di un intervento politico, non credo sia soltanto deresponsabilizzazione e riduzione dell’altro sofferente a creatura inerme. Il dolore è piuttosto la condizione del riconoscimento reciproco, capace, come scrive Antonio Prete, di farci “conoscere la provvisorietà della tenda”, ospitare l’altro, custodirlo, in una comune appartenenza alla physis, al sacro. È nella vita spoglia, nella vita esposta al dolore, sottolinea Judith Butler, che la relazione con l’altro torna a contare, e “la preoccupazione narcisistica della malinconia” può essere trasformata “nell’attenzione verso la vulnerabilità di tutti”. L’io è sempre in una relazione di dipendenza – che sia di amore o di abbandono –, ma non possiamo leggere questo come una risorsa, una possibilità di resistenza? Cogliere il volto dell’altro che ci somiglia come un’occasione?
Rosa Luxembourg sostiene la necessità di Un po’ di compassione guardando agli occhi sofferenti di un bufalo morente, stupefatto di una crudeltà che non riesce a capire, densi di uno stupore che non può essere sostenuto dalla coscienza. L’animale è spesso chiamato in causa nei discorsi relativi all’essere compassionevoli: come se fosse lecito caricare soltanto l’animale – davvero inerme, schiacciato dallo strapotere dell’uomo – del fardello di un sentimento che porta con sé l’ammissione dell’altrui fragilità. L’animale impotente rispetto all’uomo. E, come l’animale, così il bambino innocente. Ma, allora, è soltanto l’altro situato per definizione al di fuori delle aspettative prestazionali che può essere mancante? Solo per lui la condizione di dipendenza non è una colpa, non porta con sé il sentimento di un’offesa?
Se vogliamo trattenere qualcosa di quel che la compassione ci ricorda, non liquidandola come una reazione sconveniente “se non del tutto inopportuna”, dovremmo forse pensare che il risvolto politico sia in una nuova educazione al sentire: un abito etico, una nuova postura per il mondo, che apra alla possibilità della stanchezza, della vulnerabilità, dell’inadeguatezza.
Il riconoscersi simili si nutre della possibilità di immaginare le vite degli altri, e mostra tutta l’urgenza di un’educazione umanistica: come alimentare la possibilità di sentire insieme se non avendo cura della nostra capacità immaginativa, attraversando storie, le più lontane e distanti?
Quanto più saremo capaci di aprire uno spazio di immaginazione, tanto più il dolore dell’altro ci parlerà del nostro: “non si piange unicamente per il dolore come causa materiale, si piange il dolore di chi piange, si piange il dolore come stato dolente dell’esistenza. Ed è a questa condizione che il dolore si fa lutto, ossia manifestazione e oggettivazione del sentimento della mancanza” (Salvatore Natoli).
Leggi anche: