Che tipo di casa siamo? Il nuovo libro di Luca Molinari / La casa senza radici
Campagna inglese. Un luogo del nostro immaginario, dove tutto appare perfetto: pecore e greggi disposte armoniosamente, il cielo con le sue grandi nubi e i tagli improvvisi di luce, prati verdissimi e ogni stelo d’erba che sembra essere stato pettinato con cura di prima mattina. Ma interviene un elemento del tutto dissonante a ricordarci che non viviamo in un quadro di Constable, bensí nel XXI secolo: uno strano edificio, rivestito con losanghe di acciaio lucido in mezzo alla boscaglia. La forma è quella di una capanna, elementare e arcaica nella sua purezza volumetrica, che per metà della lunghezza è sospesa sul vuoto della vallata sottostante. Sembra quasi che questo piccolo edificio sia scivolato silenzioso sul prato fino a fermarsi in pericoloso equilibrio, ma non è cosí perché proprio sotto la pancia di questa casa di campagna 2.0 è agganciata un’altalena che ci riporta in maniera impudica ad Alice nel Paese delle Meraviglie e a un mondo a testa in giú.
La residenza, realizzata nel Suffolk nel 2010 dallo studio olandese MVRDV, veri e propri nipotini colti e dispettosi della fine postmoderna del secolo scorso, non a caso è stata chiamata Balancing Barn. Pare che l’abbia commissionata il noto filosofo Alain de Botton come casa di vacanze per la famiglia, ma quello che piú c’interessa è l’immagine ideata dai progettisti di Rotterdam: la metafora di una potente instabilità, una casa ironica e senza quasi piú radici che ci ricorda che tutto ormai è possibile e che ogni abitazione può diventare un oggetto radicale e interscambiabile.
È come un ritorno alle origini. Kasas nelle lingue indoeuropee significa “abitazione”, “rifugio” ma anche “tappeto”. L’inizio è stato una casa nomade, un tappeto che separava la polvere e la dura terra dallo spazio coperto e caldo.
I muri e le fondamenta sono arrivati piú tardi quando il bisogno di stare insieme e di conservare oggetti si era fatto irriducibile. Quanti significati ha l’espressione “mettere radici” in tutte le culture stanziali del mondo? Una casa fissa, una famiglia, beni da proteggere, il focolare al centro compreso da un grande camino. Nel mondo contadino è invece sopravvissuta lungo i secoli una tradizione che teneva insieme simbolicamente l’instabilità della vita dei braccianti e il desiderio della casa. San Martino, 11 novembre, prime gelate e accenni di sole in cielo, era il giorno in cui i contadini dovevano lasciare le case qualora il loro contratto di lavoro fosse scaduto. In quel giorno, lungo tutte le pianure italiane, centinaia di famiglie si spostavano da una cascina all’altra caricando gli averi e i pochi mobili (le parole non scherzano…) sul proprio carro, unica, loro vera proprietà. Oggetto prezioso e necessario perché casa temporanea e insieme ultimo giaciglio che accompagnava la salma del defunto al campo santo. Spesso questi carri erano decorati e dipinti con immagini spaventose, animali mostruosi, sirene, geometrie eccentriche che arrivavano dirette dalle nebbie del Medioevo, oggetti apotropaici contro il malocchio e le paure che nascono dalla terra.

Selgascano, Second home, Londra 2014, foto di Iwan Baan.
L’eterna lotta tra nomadico e stanziale popola le nostre case malgrado i tentativi di stabilire salde radici, e nessuno come la cultura nord-americana ha interpretato meglio questo sentimento profondo negli ultimi due secoli.
La Balancing barn è una colta variante di campagna delle motorhomes americane, Wohnmobile tedeschi, huibil svedesi, camping-cars francesi, camper italiani, sempre case in movimento, libere di conquistare territori, comporre comunità temporanee nei luoghi piú sperduti, colonizzare metri quadri ai margini dei paesaggi piú esclusivi. La casa sulle ruote, sogno di un mondo che si credeva moderno e che invece torna a essere nomadico, solo con qualche comfort in piú. Non si tratta della macchina per abitare di Le Corbusier, piuttosto dell’idea che la casa possa seguire i destini dei suoi proprietari senza alcuna restrizione. È lo spirito della frontiera montato su di un albero motore e quattro ruote, capace di esaudire tutti gli illimitati desideri dei suoi abitanti.
Buckminster Fuller – uno degli ingegneri piú visionari e ossessivi del nostro tempo – ha passato parte della sua vita a cercare la fusione alchemica tra casa e macchina.
Nel 1927 diventa famoso negli Stati Uniti con il progetto della prima Dymaxion House. Il nome è invenzione pura, un Frankenstein linguistico che combina decine di parole grandinate da Fuller a un amico copywriter, ma insieme è intuizione di un mondo nuovo, vergine, necessario per l’America e i suoi sogni di modernità selvaggia. La Dymaxion è un esagono rialzato da terra grazie a un nucleo centrale che la supporta; le pareti sono di caseina, il tetto metallico in sospensione grazie a un sistema di tiranti fissati al pilastro centrale. L’interno è libero e organizzato secondo una griglia di triangoli che ordinano lo spazio.
A partire dal 1933 segue la Dymaxion 4D Car, una macchina in acciaio su tre ruote, immaginata per brevi crociere tra cielo e terra, e progettata per ospitare fino a undici persone correndo a 90 miglia all’ora. Un missile, pura dinamica, acciaio scintillante al sole in un tempo in cui la velocità forgiava geometrie nuove. Poi il Dymaxion Bathroom pensato per condensare in un unico blocco d’acciaio lavandino, sanitari e tubature con un risparmio di spazio e materiali.
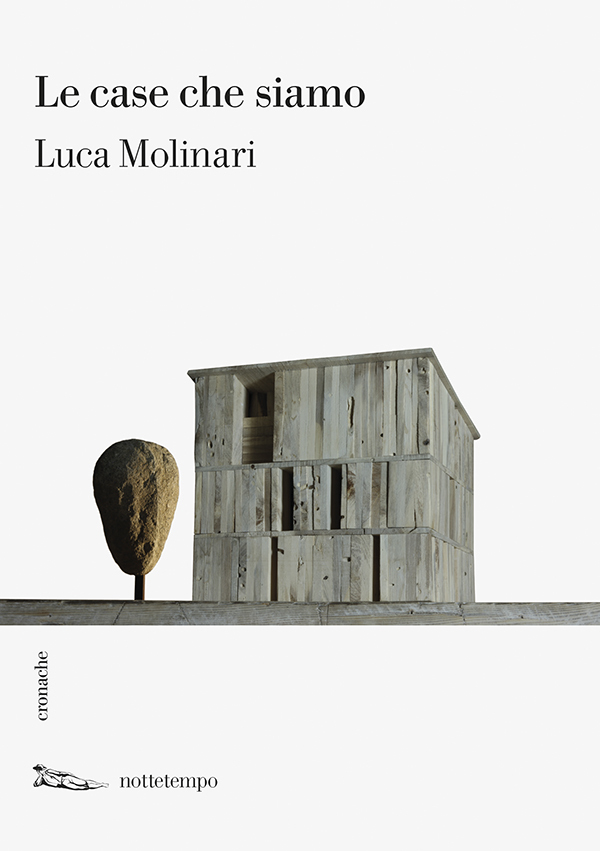
Luca Molinari, Le case che siamo.
Con la guerra il progetto della Dymaxion si fa piú sofisticato ed evoluto. Dall’esagono si passa a una poligonale che si avvicina sempre di piú al cerchio; adesso la casa è rivestita in acciaio, montabile in ventiquattr’ore e trasportabile ovunque, spazio unico aperto, finestre a fascia che abbracciano tutto il corpo, servizi essenziali centralizzati. La prima casa veramente ecologica della nostra storia, dai tempi di assemblaggio all’economia nel taglio delle lastre di metallo, fino alla capacità di fare circolare l’aria calda e fredda in tutte le ore della giornata. L’unico prototipo realizzato nella sua interezza è a Wichita, siamo nel 1944, in piena guerra si sogna il futuro nella prateria americana. Una casa di 8000 libbre di peso per 38 piedi di diametro, ogni pezzo viene prodotto industrialmente e assemblato a secco. Le immagini di quell’unità abitativa riportano al sogno americano di una casa autonoma, isolata, senza tempo e luogo. La casa non è piú una casa, è un oggetto puro, perfettamente ingegnerizzato, pronto a essere montato ovunque, prodotto di un tempo nuovo in cui la meccanica delle funzioni vince sulla sicurezza della pietra e del mattone impilato in milioni di pezzi.
“Bucky” Fuller sogna un mondo diverso, figlio di Flash Gordon e della tecnica postbellica di un paese che vuole evangelizzare il mondo con le sue visioni. Dalla Dymaxion alla prima cupola geodetica, pensata per gli ospedali da campo dell’esercito americano durante la Guerra di Corea e, a distanza di due decenni, reinventata come un gigantesco, trasparente globo per inscatolare Manhattan proteggendola dal clima e da chissà quale altro pericolo esterno. È il principio geometrico della Dymaxion che diventa una curva infinita governata da milioni di triangoli in cui inserire qualsiasi cosa: scuole, ospedali, teatri, città intere. Con questi lavori Fuller scatena le fantasie di una nuova generazione di progettisti che durante gli anni sessanta, il decennio piú radicale ed esplosivo del Novecento, comincia a disegnare case e città preveggenti.
Plug-in-City, Moving City, Walking City, Istant City nascono dalle matite degli Archigram, collettivo di architetti e ingegneri britannici, che aprono il mondo al futuro che verrà. Non esistono piú radici, fondazioni, confini prefissati, limiti dati, le città si muovono come persone, comunità che colonizzano territori spostandosi da un luogo all’altro e, una volta ferme, attivano ponti e canali sospesi che producono relazioni e collegamenti temporanei. Ogni nuovo luogo, una diversa connessione.
È già un mondo pensato in una griglia espansa di contatti e link, figlio di un immaginario influenzato dai giganteschi transistor dei primi computer IBM, e dell’idea che la città e la nostra casa sono paesaggi domestici in cui rinegoziare le relazioni sociali e la comunicazione, definendo nuovamente l’immagine stessa dell’abitare e del vivere insieme. Le case diventano Living Pod, spazi compressi a metà tra apparato digerente e capsula dell’Apollo 11, arrivando a quella prodigiosa simbiosi tra meccanica biologica e aerospaziale che anticipa i migliori incubi dell’estetica cyberpunk.

Farnsworth house by Mies Van Der Rohe, exterior.
Molto del nostro tempo e delle nostre paure è presente nei loro disegni e in quei sogni che aspettavano solo di essere realizzati. La casa non è piú solo un luogo definito ma è diventata un nuovo paesaggio, un luogo instabile e multiforme che cambia continuamente come fosse colpito da un bruco che divora la mela dall’interno senza mai toccare la buccia. La casa è il luogo abitato da oggetti che cambiano insieme ai suoi abitanti-consumatori. È lo spazio di rappresentazione della follia medio-borghese di Monsieur Hulot. La casa torna a essere un luogo di confronto politico, e il suo progetto “domestico” diventa critica violenta alla società dei consumi che continua a nutrire. Come nella mostra Italy: The New Domestic Landscape, una delle esposizioni “mitiche” nella storia del MOMA, in cui nove progettisti italiani vennero invitati nel 1972 a immaginare altrettanti ambienti domestici per rappresentare la metamorfosi radicale della casa in luogo politico di confronto nella società. L’abitazione si trasforma d’un tratto in un paesaggio, uno spazio pubblico in cui si realizzano le nevrosi e le idiosincrasie contemporanee.
Ma il mondo della casa non si ferma mai, anzi evolve.
La casa diventa essa stessa oggetto da comprare a catalogo seguendo i propri sogni, abbandonando ogni idea di città come luogo regolato e condiviso in forme e volumi. Dopo avere inondato le nostre abitazioni con i sottoprodotti eleganti del design figlio del migliore welfare state nordico, Ikea ha inserito nel suo catalogo case da acquistare on-line. Ma presto non avremo piú neanche bisogno del colosso svedese perché potremo ordinare i singoli componenti e produrli in una falegnameria di nuova generazione con stampanti 3D. Anche in questo caso si torna alla vecchia America, vera e propria macchina per abitare, visceralmente antiurbana. Basta andare indietro di quasi duecento anni per trovare i primi cataloghi di case da ordinare via posta, che tanto facevano godere gli europei appassionati di modernità a tutti i costi. La casa balloon-frame, un sistema elementare di travi e assiti in legno trasportabili nel lontano West da trasformare in casa con pochi giorni di lavoro, è l’inizio di quel fenomeno universale che chiameremo sprawl.
Una periferia infinita di case tutte uguali, con interni tutti uguali, per una popolazione nomade abituata a cambiare tra le sette e le nove abitazioni nell’arco di una vita. La casa in legno del West non è diversa nella concezione e nella tecnica dalle villette di Happy Days, La famiglia Bradford, Desperate Housewives, Happy Family, The Simpsons e di tutte le serie che hanno costruito un immaginario universale di stereotipi e cartoline di un paesaggio domestico medio, che dall’America viene riprodotto con varianti locali in Baviera passando per il Kenya, la Nigeria e la Cina.
Si tratta di case fragili, provvisorie a dispetto dell’apparente eternità di finta pietra, legname sintetico e finiture d’alluminio. Un po’ come in One Week di Buster Keaton: un sogno di durevolezza scardinato dallo scherzo del cattivo di turno; una home sweet home destinata a girare su se stessa alla prima folata di vento primaverile; una casa sghemba montata sul retro della Ford T4 (la prima machine à habiter!!) e travolta da un treno in corsa. Premonizione divertita di un mondo che non sa ancora se riprendere il cammino nomade o se immaginare case temporanee in cui sognare, per un attimo, la stabilità. E se, invece, il tappeto della kasas si trasformasse nel pad del computer? Se la casa scomparisse a poco a poco, decretando per i nostri figli un consapevole destino nomadico a portata di clic?
Luca Molinari, Le case che siamo, nottetempo edizioni.







