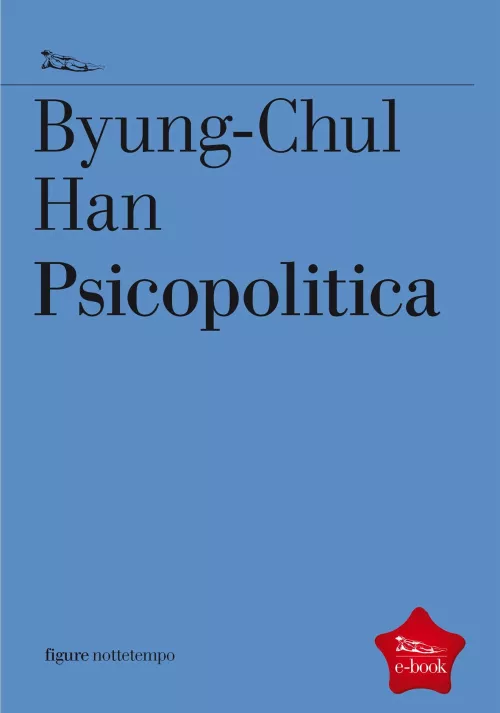Un’apocalisse integrata / Psicopolitica di Byung-Chul Han
«La libertà sarà stata un episodio» (p. 9). Con questa sentenza lapidaria si apre l’ultimo libro tradotto in italiano del filosofo coreano di lingua tedesca Byung-Chul Han, Psicopolitica.
Il libro di Han, poco più di 100 pagine, diviso minuziosamente in 13 sottoparagrafi, si pone come una disamina del tema della psicopolitica, che ad avviso dell’autore sarebbe l’impensato delle politiche che – dall’inizio dell’età moderna, secondo il dettato di Foucault – nel mondo contemporaneo fanno dei corpi degli uomini il loro oggetto principale, e che sono state chiamate dagli interpreti “biopolitiche”.
Per prima cosa Han sottolinea come, nel regime neoliberale, si sia attuato un superamento del paradigma individuato da Marx, secondo cui – riducendo – ci sarebbe una classe di sfruttatori e una di sfruttati: per Han nel neoliberismo «ciascuno è un lavoratore che sfrutta se stesso per la propria impresa» (p. 14): non averlo capito sarebbe il grande errore di teorici come Toni Negri, che sarebbero, secondo Han, rimasti attaccati a un paradigma descrittivo delle modalità di produzione vecchio e non più al passo coi tempi: «Le attuali forme di produzione non sono determinate dalla “Moltitudine” cooperante, che Antonio Negri innalza successore del “proletariato”, ma dalla solitudine dell’imprenditore isolato in sé, che lotta con se stesso e si sfrutta volontariamente» (p. 14).
Si vede qui il primo punto che caratterizza tutto l’andamento del testo: Han elenca una serie di posizioni di teorici (tra gli altri: Michel Foucault e Gilles Deleuze, Toni Negri e Giorgio Agamben, fino ad arrivare a Bernard Stiegler), al fine di dimostrare come i paradigmi da loro adottati siano insufficienti e non siano altro che prodromi o malcomprensioni del paradigma autenticamente descrittivo della nostra contemporaneità: quello di psicopolitica nell’accezione da lui stesso trovata, e che andremo di seguito a vedere.
Prima di passare all’analisi della psicopolitica è però interessante riportare un campione di queste critiche, e al contempo dello stile e del modus argomentandi di Han. Questo si può trovare in frasi come le seguenti: «Al contrario di quanto sostiene Marx, la contraddizione tra forze di produzione e rapporti di produzione non può essere superata per mezzo di una rivoluzione comunista: essa è infatti insuperabile» (p. 13). «Foucault parla espressamente di “biopolitica della popolazione”. La biopolitica è la tecnica di governo della società disciplinare. Essa, però, non è affatto adeguata al regime neoliberale, che sfrutta soprattutto la psiche» (p. 31). «La stessa analisi del potere agambeniana non dà accesso alle tecniche proprie del regime neoliberale» (p. 33). «Stiegler […] manca senza appello la psicopolitica neoliberale» (p. 36).
Han si pone, quindi, come colui che ha capito i punti di impasse di Marx, Foucault e Deleuze, colto il fallo nelle proposte di analisi biopolitica della società di Negri e Agamben, e migliorato l’errore di Stiegler: quest’ultimo, quanto meno, ha avuto il merito di incominciare un’analisi della psicopolitica, per poi – però – “mancarla”, dando troppa importanza al fenomeno-televisione e troppa poca ai nuovi media. Per questo – per avendo Stiegler già avanzato il paradigma della “psicopolitica” (come tecnica politica che mira alla standardizzazione delle coscienze tramite il medium-televisione), egli, per Han (che non prende in considerazione almeno una decina di libri scritti dal francese sul tema), non coglie il fatto che la psicopolitica sia perpetrata in massima misura dai media digitali.
Al lettore avvertito di filosofia, ma anche a chi abbia quanto meno letto qualcosa degli autori sopra citati, le analisi di Han non possono che dare un’impressione: quella di una incredibile superficialità. Sfogliando anche solo velocemente la bibliografia del testo non si può non notare che di Agamben vengono citati appena due libri, di Stiegler uno, di Negri nessuno (Moltitudine viene evocato solo in corpo testo), di Marx tre. A Deleuze e Foucault va leggermente meglio con rispettivamente 5 e 10 testi citati. Sempre troppo poco, però, ci sembra, per operare un superamento di questi autori, tenendo anche conto delle enormi produzioni di questi ultimi proprio in oggetto alle tematiche che Han analizza.
Troppo poco, soprattutto se si considera lo stile specifico dell’argomentazione di Han. Come le citazioni sopra riportate mostrano a livello di esempio, le frasi di Han hanno un andamento paratattico, estremamente assertivo, assolutamente non-argomentativo. Non esistono confutazioni e argomentazioni critiche di altrui tesi, nel testo di Han, che superino le 5 righe, righe di solito spezzettate in frasi molto brevi. Tantomeno Han indulge al close reading di frasi o argomentazioni altrui. Questo fatto stupisce ancor di più se si considera che la lingua in cui scrive Han è il tedesco, che a livello scientifico si avvicina molto di più ai barocchismi prosastici italiani, ricchi di subordinate, che alla paratassi del lessico universitario anglosassone (che tra l’altro Han non apprezza). Forse – come ho avuto modo di ascoltare dalla viva voce della traduttrice italiana di Han, Federica Buongiorno, in un’occasione informale, e proprio per questo ancor più degna di credibilità – la paratassi di Han è da ricondurre al modo di pensiero asiatico: Han sembra, in effetti, più concatenare degli haiku che procedere secondo un ritmo discorsivo-argomentativo a cui il lettore di filosofia è abituato. I suoi contenuti, quindi, sarebbero più narrativi che filosofici strictu sensu.
Per questo, a rigor di termini, il testo di Han – e i testi di Han più in generale, per lo meno quelli tradotti in italiano – difficilmente vengono apprezzati dai filosofi che li leggono: perché essi rifiutano le “regole del gioco” del gioco della filosofia, senza però fondarne delle altre, come ad esempio – è il caso più famoso – accade per Friedrich Nietzsche, che distrugge con il suo modus scrivendi gli stilemi classici del genere, creandone di autonomi.
Si potrebbe allora essere tentati di leggere il testo di Han come un’analisi di sociologia dei media con un taglio critico-politico. Han, infatti, analizza quelli che presenta come gli strumenti dello sfruttamento dell’uomo di se stesso, vale a dire i social media e la presunta (idea di) “libertà” che essi veicolano: «La società del controllo digitale fa un uso massiccio della libertà: essa è possibile solo grazie all’autoesposizione, all’autodenudamento volontari» (p. 18). In questa società di spettatori l’unica forma di reazione del “pubblico” (che ha sostituito il popolo) è l’indignazione, che però è per Han una passione inattiva, impolitica, da voyeurs, che non conduce all’atto politico.
Pur tralasciando le potenti analisi sul valore politico dell’indignazione portate avanti nello scorso decennio da Peter Sloterdijk (che nel suo Ira e tempo, pubblicato esattamente dieci anni fa, ha ricostruito proprio il nesso tra le passioni-contro, come l’indignazione, e la politica, utilizzando – tra l’altro – il termine “psicopolitica”), e il fatto che, come ricordava Philip Roth nel suo bellissimo Indignazione (pubblicato in Italia da Einaudi), lo stesso inno nazionale cinese si richiami proprio all’“indignazione” del popolo per muoverlo alla rivoluzione, quello che sembra mancare nelle analisi di Han a livello di media è il soggetto che unisce media e politica: se, infatti, viviamo in un “panopticon digitale”, chi è il soggetto che lo ha costruito, che ne approfitta, che ci osserva? Han offre una risposta che appare – quantomeno – stupefacente: «Proprio là dove il potere non viene tematizzato, il potere è indiscusso; più grande è il potere, più silenziosamente agisce. Esso accade» (p. 23). Il potere non ha soggetto, “accade”. Come un temporale, un incidente automobilistico e la decostruzione per Derrida.
 Psicopolitica di Byung-Chul Han.
Psicopolitica di Byung-Chul Han.
È questo che appare impensabile e inaccettabile al lettore che voglia capire le analisi di Han. Il fatto che l’apocalisse tecnologica ci sia e che nessuno sia responsabile. Che non ci siano impianti di sapere e di potere da analizzare in relazione all’insorgenza delle forme storiche della virtualità, che – in una parola – la storia sia dimenticata. Han vorrebbe sbarazzarsi di Foucault, senza però averne “digerito” la lezione più importante: non esiste “il” potere, esistono le configurazioni storiche dei poteri, le loro cause, lo loro forme di datità. Se si perdono queste si perdono i nessi storici, e con questo il valore dell’indagine si riduce a mera denuncia dello status quo, alla ripetizione in toni miserabilistici delle miserie dell’esistente. Lo stesso “neoliberalismo” è agitato come soggetto-spauracchio, ma non indagato da Han: quale rapporto ha lo sfruttamento dei corpi con quello della psiche (è questo il “passo in avanti”, per Han, della psicopolitica rispetto alla biopolitica)? Come è accaduto storicamente? Chi ha messo in atto questa rivoluzione mediatica? Queste domande restano evase.
L’ultima parte del testo di Han – forse quella più interessante – è dedicata al Quantified Self. Con questa definizione viene indicata una serie di pratiche di automisurazione dei propri dati corporei e prestazioni (di solito relative alla propria fitness e/o ad attività sportive) che poi vengono condivise dagli utenti di apposite comunità virtuali tramite social media, specifici siti internet e apps. L’analisi di Han si apre con due premesse: che il Quantified Self sia la forma estrema delle “tecnologie del sé” analizzate da Foucault negli anni ’80 e che questo sia un’estrema forma di espressione di quello che egli chiama “dataismo”, ossia un’ideologia tecnocratica basata sulla raccolta di dati, la loro manipolazione e vendita da parte di enti statali e privati.
Quest’ultima tesi, e l’analisi dei Big Data fornita da Han nel terzultimo capitolo del testo, appaiono forse le più interessanti del libro. Qui Han non offre superficiali analisi di altri autori con l’intento di “superarli”, né si batte contro il mostro informe del “neoliberismo”, ma offre un’analisi mediologica e critico-culturale del fenomeno dell’immagazzinamento di dati da parte di grandi compagnie tecnologiche (come la americana Acxiom), e il loro possibile utilizzo per la previsione verosimile dell’andamento futuro delle elezioni politiche (come rappresentato in maniera magistrale nell’ultima stagione della serie televisiva House of Cards) o dei mutamenti economici. La tesi di base è quella famosa formulata da Chris Anderson su Wired nel suo celeberrimo articolo The End of Theory?: con i nuovi sistemi di elaborazione, analisi e immagazzinamento dati non ci sarebbe più bisogno di teorie e previsioni, perché è possibile elaborare modelli statisticamente vicini alla realtà per quel che concerne i comportamenti dei soggetti singoli e collettivi.
Discutendo questa tesi, e sviluppando qualche slogan tanto d’impatto quanto poco comprensibile («Il sapere-totale-dei-dati è un assoluto non-sapere al punto zero dello spirito» [p. 83]), Han fornisce un’interessante analisi di un fenomeno della contemporaneità, aiutando il lettore interessato a comprendere come gli sviluppi dall’accumulazione di dati possano influenzare l’andamento sia dei modelli teorici che degli andamenti pratici che sono dietro ai grandi collettori socio-politici.
L’ultimo punto del testo che vale la pena analizzare, come detto in precedenza, è quello del Quantified Self come tecnologia del sé. Qui Han mostra, ancora una volta, di non aver capito Foucault: la pagina 37 del testo di Han è paradigmatica di questo misreading. Qui Han cita le “tecnologie del sé” di Foucault, sostenendo che «La tecnica di potere attuata dal regime neoliberale costituisce il punto cieco dell’analitica foucaultiana sul tema: Foucault non riconosce che il regime di dominio neoliberale monopolizza integralmente la tecnologia del sé, che l’auto-ottimizzazione permanente come tecnica neoliberale del sé non è altro che una forma più efficace di dominio e di sfruttamento» (p. 37).
Appare quasi incredibile, ai limiti del paradigmatico, quanto ciò che sostiene Han sia assolutamente inadeguato a descrivere ciò che a sua volta sostiene Foucault (citato letteralmente poche righe prima): Foucault chiarisce, infatti, come le tecnologie del sé siano sempre da analizzare assieme alle tecnologie del potere, da cui non sono mai indipendenti, pur racchiudendo un potenziale critico al loro interno.
Foucault ci dice che siamo corpi che si muovono, che esercitano condotte e che queste condotte sono all’incrocio tra scelta autonoma e contesto socio-politico-culturale in cui ci troviamo. I soggetti che diveniamo sono il risultato di queste condotte, e della loro sommatoria con le tecnologie di potere che ci strutturano dall’alto. Tra l’altro lo stesso Han, successivamente (p. 92) fa ricorso a un concetto foucaultiano “gemello” a quello di “tecnologia del sé”, vale a dire quello di “arte di vivere”, che Han operazionalizza come via di uscita dalle maglie della psicopolitica.
Sembra però non essere considerato dallo scrittore coreano il fatto che il concetto stesso di “arte di vivere” di Foucault altro non sia che la traduzione in francese del greco “techne tou biou”, e che la stessa – tanto demonizzata – “techne” sia proprio quell’arte che Foucault ricercava nel dare uno “stile” personale alle regole di esistenza, altrove e altrimenti chiamate “tecnologie del sé”.
In conclusione, il testo di Han lascia insoddisfatto sia il filosofo che lo studioso di media, soddisfacendo e solleticando però il palato (ci permettiamo: grossier) degli apocalittici tecnofobi critici della società, per cui tecnologia e decadenza sono una coppia oppositiva irrinunciabile. Alfiere di quella Kulturkritik tanto in voga tra i migliori esponenti della Scuola di Francoforte (non si capisce Han senza Adorno), ne subisce in pieno gli effetti di ritorno negativi: si pone, infatti, come un apocalittico, senza particolari proposte costruens (si veda a questo proposito l’intervista rilasciata per Doppiozero), esercita un genere di critica culturale ormai invecchiato, per cui tutto quello che ha a che vedere con la democratizzazione delle tecnologie di massa equivale a un istupidimento di massa e a un relativo asservimento di massa, e finisce per adottare un tono più adatto a un Savonarola tecnoapocalittico che a un analista della società.