Poemetti / Furio Jesi, L’esilio
Nelle ultime righe dell’introduzione a Esperienze estatiche, Martin Buber, un autore molto caro a Furio Jesi, scrive: “Ma è davvero un fantasma, il mito? Non è invece disvelamento della realtà ultima dell’essere? Non è forse l’esperienza dell’estatico l’emblema dell’esperienza originaria dello spirito del mondo? Non sono queste entrambe esperienze viventi? Noi ascoltiamo attentamente ciò che è dentro di noi – e non sappiamo di quale mare stiamo udendo il mormorio”.
Lo Jesi mitologo non avrebbe probabilmente esitato a rispondere che sì, il mito è in certa misura un fantasma e che la mitologia è “la scienza di quello che non c’è”. E che no, il mito non è disvelamento della realtà ultima dell’essere. Buber si poneva lungo una linea di pensiero sul mito che risale al romanticismo tedesco. La sua frase riecheggia una celebre affermazione di Friedrich Creuzer secondo cui il simbolo, che traspare attraverso il mito, è come “un raggio che giunge dalle profondità dell’essere e del pensiero”.
Nella fase più matura della sua riflessione attorno al mito, quella inaugurata nei primi anni ’70 con l’elaborazione del modello della macchina mitologica, Jesi non solo si rifiuta di dare una definizione del mito, ma rinuncia persino a dire se il mito esista oppure no, se la macchina impegnata incessantemente a produrre mitologia contenga al suo interno il “mito” oppure se sia assolutamente vuota, come il Qodesh ha Qodashim del Tempio di Gerusalemme. Per Jesi la scelta di non definire il mito non è dettata dalla volontà di “abbandonarsi con deliberata cecità, o magari con appassionata cecità, al godimento di presunte esperienze mitiche personali” che l’indagine scientifica minaccia di dissolvere. Si tratta invece di riconoscere che il mito “non costituisce un oggetto definibile con strumenti scientifici, e non dispone di una realtà che possa essere detta esistente o non esistente, a meno che non si voglia trasferire il discorso dal piano della scienza a quello della mistica o della teologia – cosa che non sono disposto a fare, non possedendo e non volendo possedere alcuna fede, convinzione o esperienza di carattere religioso” (F. Jesi, Esoterismo e linguaggio mitologico, Quodlibet, Macerata 2002, p. 43).
Allo studioso non è concesso accostare le labbra alla sorgente della mitologia, per usare un’espressione cara a Károly Kerényi, il maestro di Jesi. Coloro che invece hanno il privilegio di bere l’acqua pura del mito genuino sono i poeti “veggenti”. Per il mitologo ungherese solo questi Dichter (tra cui egli annoverava Thomas Mann e Rilke) sono capaci “di vedere e – paradossalmente – al tempo stesso creare le ‘figure’ (Gestalten) disponibili all’uomo per sua natura quali modalità di conoscenza del suo ‘essere fuso’ (Verwobenheit) con il mondo” (F. Jesi, Materiali mitologici, Einaudi, Torino 1979, p. 8). I poeti “veggenti” partecipano direttamente, senza mediazione e senza distanza, al meccanismo genetico della mitologia. Ma a differenza del suo maestro, che non ha mai voluto farsi “veggente” e si è limitato, da studioso, a vedere nei poeti la forza creativa della mitologia in atto, Jesi da parte sua ha cercato di accostarsi alla mitologia non solo girandoci intorno per delimitarne i confini, ma sperimentando direttamente e, per così dire, dall’interno i meccanismi della creazione mitopoietica. Se quindi negli anni ’70 Jesi intendeva mantenere il proprio discorso “sul piano della scienza”, nel corso degli anni ’60 la sua posizione restava aperta ad altri “piani” e accanto al discorso “scientifico” trovava spazio anche quello della scrittura poetica.
Il risultato di questa scrittura è una raccolta di poesie o piuttosto di poemetti scritti tra il 1963 e il 1969, intitolata L’esilio e uscita nel 1970 presso l’editore Silva. Ora la casa editrice Aragno la ripropone, mirabilmente curata da Giacomo Jori. Nell’introduzione al volume Jori chiarisce il clima culturale in cui opera Jesi negli anni ’60, delinea i suoi rapporti con personaggi come Albino Galvano, impegnati nella ricerca di una “via non reazionaria all’irrazionale”, mostra la continuità e contiguità di temi tra la produzione saggistica e quella poetica di Jesi, situa L’esilio in rapporto alla Neoavanguardia e a poeti come Zanzotto, ne indica i modelli più importanti, soprattutto Pound, l’unico poeta, secondo Jesi, che sia stato “negli ultimi decenni (…) capace di scrivere un poema epico” (p. xxiv). L’epica – intesa come poesia capace di includere la storia, di nominare la storia universale – è infatti il genere a cui l’autore esplicitamente ascrive L’esilio. Il commento di Jori alle singole poesie cerca di rintracciare i numerosissimi e inestricabili riferimenti intertestuali, siano essi poetici, filosofici, religiosi o mitologici, che costellano i versi di Jesi conferendo loro un apparente carattere di “oscurità” e di difficoltà. Se si resta impressionati dal paziente lavoro filologico e esegetico di Jori e si è grati all’editore Aragno di aver ridato alle stampe un testo pressoché dimenticato, ci si chiede anche se questa edizione commentata, con tanto di versi numerati e apparato di note, non rischi di “museificare” il libro contro l’intenzione stessa dell’autore. Jesi avrebbe voluto che il lettore ascoltasse “in purezza di spirito, senza propositi eruditi, senza riserve, il ritmo di poesia che è sgorgato delle macerie e le ha trascinate con sé”.
Quest’ultima citazione, che si riferisce al modo in cui Jesi suggeriva di leggere i Cantos di Pound e “accogliere entro sé quell’estasi” che determina il fluire del canto, può essere intesa anche come un’indicazione di lettura per L’esilio. Allo stesso modo l’analisi che nella “Lettura del Bateau ivre” Jesi propone dei “luoghi comuni”, delle “macerie”, che sostanziano la poesia di Rimbaud, è anche una definizione puntuale della poetica di L’esilio. Nel comunicato stampa che accompagnava la prima edizione della raccolta, Jesi giustifica in questo modo la decisione di non aver messo note alle sue poesie a differenza di quanto aveva fatto Eliot nella Terra desolata: “L’Esilio non ha alcuna nota, poiché l’autore intende sottolineare l’usufruibilità di ogni ‘precedente’ poetico quale repertorio di anonimi luoghi comuni – i quali possono apparire bizzarrie estremamente soggettive, ma in realtà sono proprio anonimi luoghi comuni di una koiné che – in termini cronologici – principia con Ugo Foscolo e si chiude con Ezra Pound”. È proprio maneggiando e assemblando i luoghi comuni, i topoi, messi a disposizione dalla tradizione che il poeta mette in moto la propria macchina mitopoietica: “Così come i miti, essi [i luoghi comuni] sono innanzitutto qualcosa di cui un’esperienza creativa insiste nel farci credere l’esistenza, tenendocene al tempo stesso ben celata l’essenza” (F. Jesi, Il tempo della festa, Nottetempo, Roma 2013, p. 51).
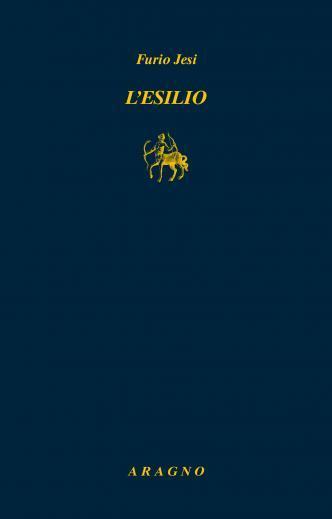
Perché Jesi intitola la raccolta L’esilio? Il senso del titolo è chiarito nel già citato comunicato stampa: “Il titolo di questa raccolta di poesie può essere ricollegato ai singolari sviluppi del concetto di ‘esilio’ nella tradizione culturale e religiosa ebraica. Specialmente nell’ambito della mistica, l’esilio apparve come un’esperienza dapprima redentrice, poi sempre più catastrofica e apocalittica, fino alla morale antinomica di Shabbetày Tzevì (‘Lodato sii tu, o Dio, che permetti ciò che è proibito’). Analoga situazione di ‘esilio’ in termini di cultura, di religione, di morale si configura nel linguaggio e nella metrica di queste poesie”. Si sente qui l’eco della lettura di Scholem, che influenzerà Jesi anche nell’elaborazione di Mitologie intorno all’Illuminismo (1972). L’esilio è sì l’esilio del popolo ebraico, ma è nello stesso tempo l’esilio del Dio oscuro che si è ritirato dal mondo dopo la creazione sprofondando nel proprio nulla, ed è l’esilio esistenziale dell’uomo moderno, espulso dal mondo autentico del mito. Nel poemetto eponimo che fa da proemio alla raccolta, troviamo compendiati tutti i temi che si dispiegano nelle altre otto composizioni: il fanciullo orfano esiliato dall’infanzia e dalla famiglia (“Da molte stagioni, forse dall’ora in cui nacque, / egli dura in esilio.”), l’adulto esiliato dal mito (“Nulla valgono a lui (…) / le persone divine con cui, sole, parlò nelle stagioni trascorse.”) che diventa “incantatore”, ossia poeta “solo per far cessare il dolore” e rievoca con “canti inariditi” le presenze divine, in particolare la figura di Kore-Psyche, la “vergine antica” che “dorme con l’ali piegate, colei che la lampada più non solleverà”.
L’evocazione di uno di questi dialoghi di Jesi con “le persone divine”, una vera e propria esperienza di commozione estatica, si può leggere in “Dodona: il feudo sacro di Zeus”, un dattiloscritto rimasto inedito e pubblicato da Schiavoni in F. Jesi, “La ceramica egizia” e altri scritti sull’Egitto e la Grecia (1956-1973), Aragno, Torino 2009, p 363-364: “Ricordo d’aver atteso, un giorno, a Dodona vicino all’oracolo il buio della notte. Tutto intorno, monti e colline avevano raggiunto la vibrazione opaca e intensa delle cose vive, pronte ad immergersi nel mistero notturno. Una lunga ondata di commozione interruppe il discorso logico e quanto mai scientifico che avevo iniziato: una sorta di monologo a voce alta nella penombra di Dodona (…). La risposta venne dal cerchio delle colline silenziose: “Cosa ti fa restare qui in attesa della notte? Cosa ti incanta lo sguardo sulla pianura e sull’orizzonte deserto?”.
Altro elemento tematico ricorrente in L’esilio è quello della battaglia, che svolge un ruolo capitale anche nel romanzo vampirico, L’ultima notte, la cui stesura è coeva a quella delle poesie. Nel poemetto proemiale ritroviamo inoltre il tema dell’esilio dalla vita e dalla morte, che costituisce il nucleo centrale del poemetto “Ahasvero” in cui Jesi riprende la leggenda cristiana medievale dell’ebreo errante condannato all’immortalità, a un eterno peregrinare, a un esilio senza fine per aver offeso Gesù durante la passione. Nei versi di Jesi, Ahasvero diventa l’emblema, come osserva Jori, del poeta in esilio, creatura sospesa fra due mondi, troppo umano e troppo separato dall’uomo.
In L’esilio, come s’è visto, la centralità dei temi ebraici è affermata fin dal titolo. Se è vero che Jesi si è occupato di ebraismo anche nella sua produzione saggistica fin dal suo primo libro, Germania segreta, tuttavia nei poemetti di L’esilio egli fa i conti in modo più diretto con il Dio oscuro della tradizione ebraica e dà voce alle tensioni religiose che lo animano, a un ateismo “che diventa sempre più esitazione a dare un nome all’oscurità che noto nelle profondità dell’essere”, come egli scrive in una lettera del 1966 a Gershom Scholem, in cui sorprendentemente Jesi chiede allo studioso se la propria posizione teologica sia compatibile con l’ebraismo ortodosso. Nel libro di versi di Jesi l’ebraismo non è solo esplorato come serbatoio di immagini mitiche. Esso è anche retaggio familiare e legame con la memoria del padre. Nel testo più intenso di tutta la raccolta, Katabasis, Jesi rievoca la figura del padre Bruno, volontario in una legione di camicie nere in Africa Orientale. Gravemente ferito e mutilato a una gamba durante una battaglia, venne rimpatriato e congedato nel 1939 benché fosse stato “arianizzato” per meriti militari. Morirà nel 1943 quando Furio ha soli due anni. Il figlio descriverà con lucidità, in un saggio pubblicato postumo, la situazione degli ebrei fascisti, in particolare quelli torinesi, le cui posizioni erano espresse nella rivista La nostra bandiera fondata da Ettore Ovazza, a cui Bruno Jesi era molto vicino. Ma nella poesia non c’è nulla di tutto questo, non c’è alcun riferimento esplicito al fascismo del padre né alla sua origine ebraica. Vi è solo l’evocazione di un bambino, di un orfano che cerca di riportare il padre dal regno dei morti:
Quante notti, quante lunghe quieti notturne
– La stufa s’era spenta e nel salone durava
l’alto gelo dei morti –,
quanti inverni, la mia mano si spingeva fuori
dal caldo letto per cercare la tua,
e poi ritornava nel buio
solitario, delle coperte ben rimboccate
per non svegliarti.
Come l’Euridice di Rilke, altro fondamentale riferimento insieme a Pound, “chiusa nella propria morte” non può riconoscere l’amato che è sceso nell’Ade per riprendersela, così il padre di Jesi, quand’anche il figlio potesse raggiungerlo nel regno dei morti, sarebbe incapace di riconoscerlo:
Ora so
davvero che non dovevo svegliarti.
Poiché nella casa dei morti
non si conosce il proprio volto, e tu,
se t’avessi destato,
con breve e gentile stupore avresti guardato il bambino
ignoto che ti cercava la mano.
Non sappiamo se dopo L’esilio Jesi scrisse altre poesie. Di certo non pubblicò altre raccolte nei dieci anni che gli restavano da vivere. È difficile stabilire le ragioni che determinarono la fine della sua stagione poetica. Forse la pubblicazione di L’esilio significò per lui la chiusura di una fase della propria ricerca intellettuale ed esistenziale. I versi erano il documento di qualcosa che nel 1970 egli sentiva come “superato”. Significativamente il silenzio poetico coincide con l’elaborazione del modello della macchina mitologica e un nuovo orientamento nella sua attività di studioso, in cui prevarrà la volontà di sottrarsi al potere fascinatorio della macchina mitologica analizzandone il funzionamento dall’esterno, “sul piano della scienza”. Questo comportava necessariamente la rinuncia a farsi “incantatore”, a evocare il fantasma del mito, ad alimentare con il carburante delle sue personali visioni ed esperienze estatiche la macchina che produce mitologia.







