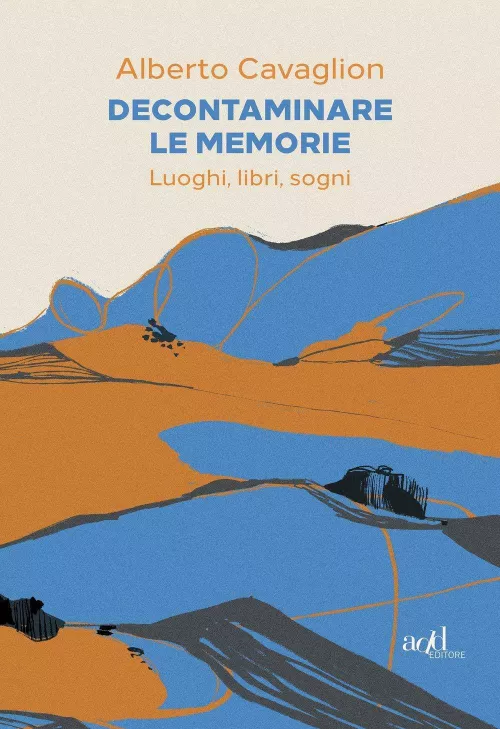Un libro di Alberto Cavaglion / Decontaminare le memorie
Decontaminare le memorie di Alberto Cavaglion è un libro che si pone molti obiettivi: alcuni più diretti e manifesti, altri più profondi. Credo che sia un testo “palestra” su cui convenga fermarsi e sulle cui proposte prendere le misure, non tanto di ciò che abbiamo davanti, ma come spesso capita negli esercizi che implicano un rapporto con la memoria, di ciò che abbiamo alle spalle.
I giorni della memoria, dice Cavaglion, sono da tempo in crisi. Prendiamone uno per tutti: il 27 gennaio. Quello del 27 gennaio è in crisi per i contenuti, per le modalità. Lo è perché non corrisponde a un progetto culturale (aggiungo io) o forse semplicemente perché è fondato su un principio “altruista”: quello di riflettere sui morti provocati in tempi precedenti, credendo che quella pratica di rievocazione sia la terapia di uscita. In ogni caso lo è come progetto: intolleranza, odio, antisemitismo, razzismo sono in crescita e quella giornata, che spesso è una settimana, talvolta un mese, non è capace di arginarli.
In realtà, ma questo lo scriveva già molti anni fa Giovanni de Luna, quel calendario fondato sul dolore non consente di pensare un progetto, di declinare un futuro, ma spesso si accontenta di riscrivere il passato. Come tale non parla, ma solo urla, o invoca attenzione. Ma non si costruisce nessuna religione civile, nessun patto di futuro su qualcuno che costantemente rivendica la centralità della propria memoria di dolore.
Come si fa dunque memoria e allo stesso tempo, come si ritrovano i luoghi, gli oggetti, le storie, le tracce, in breve i contesti e i paesaggi di quelle memorie, sussurrate, consumate, spesso anche declassificate e accantonate?
All’inizio, scrive Cavaglion, sta l’attenzione verso i luoghi secondi, o minori, comunque quegli spazi densi di storia, ma che spesso sono rimasti muti o che a lungo sono stati trascurati. Per ritrovarli occorre trovare le parole, i gesti, di coloro che li hanno attraversati, ma spesso di coloro che poi ci sono tornati, fisicamente o anche con le parole, con la creatività artistica. E dunque non solo le persone, ma anche
la letteratura, l’arte, i documenti.
Non solo. Insiste Cavaglion che occorre non entrare direttamente nei luoghi, ma fermarsi sulla soglia per poi farsi accompagnare e capirne il senso. Qui Cavaglion si riferisce in particolare alla didattica e alle scuole: «non servono studenti con il trolley che viaggiano verso Auschwitz», ma persone con un percorso conoscitivo e per così dire spirituale costruito sui testi che ci sono arrivati.
La proposta è dunque quella di dare forma a una possibile «ecologia della memoria» che mette a confronto paesaggio naturale e paesaggio o memoria dell’uomo. In questo, per esempio, rientra la riflessione che Cavaglion propone a partire da Gli aquiloni di Roman Gary e soprattutto intorno all’idea di museo che lo accompagna. Un’idea di ripensare il racconto della storia, spiega Cavaglion (ma questa prima bozza di riflessione Cavaglion l’aveva anticipata alcuni mesi fa in un’audio conferenza coinvolgente che si può ascoltare qui), offre l’occasione di ripensare oggi ai cosiddetti luoghi di memoria: i memoriali, i musei della storia contemporanea, della Shoah, del fascismo.
Suggestione interessante, ma che nella memoria del XXI secolo non limiterei ad Auschwitz; perciò direi: cosa è oggi andare a Budapest: quale memoria vediamo in scena? Oppure che cosa è andare non solo a Varsavia sulla soglia dello spazio urbano di dove si trovava il ghetto? E allora perché, se vogliamo capire che cosa sia quel mondo scomparso che ci ha documentato fotograficamente da Roman Vishniac un attimo prima della eclissi, non andare a fare un percorso che porti le persone sui molti luoghi della presenza ebraica in Polonia (e non solo dei luoghi dello sterminio) per cercare di capire cosa è “un mondo scomparso” e non solo dove quel mondo è stato ucciso, sterminato o bruciato?
E ancora siamo certi che i viaggi di memoria siano solo con il trolley e non ci siano percorsi didattici, di emozione dove entrano in gioco anche altri fattori (per chi volesse approfondire alcune suggestioni le può trovare in un volume curato da Bruno Maida e Elena Bissaca che prova a raccontare non solo delle esperienze di viaggio di memoria, ma anche quale pedagogia è connessa con quel tipo di attività). Appunto perché i viaggi di memoria non siano (e in alcuni casi già non sono) “studenti con il trolley”, bensì esperienze in cui le emozioni diventano anche alfabeti per costruire linguaggi di consapevolezza e non solo particelle staccate di atti che poi restano “senza storia”. In quelle pratiche e in quelle esperienze, come auspica e chiede giustamente Cavaglion, sono già state attivate le parole della letteratura o dell’arte, e non solo. Accanto e spesso prevalente, un serio lavoro riflessivo avviene non sui film integrali, ma su clip di “immagini in movimento”, ovvero su “sequenze”. Perché appunto sono le sequenze o le unità di narrazione filmica a promuovere emozione, azione, reazione, riflessione e poi a restituire deliberazione, crescita, inquietudine.
Cavaglion presenta dei percorsi della memoria che riguardano le persecuzioni degli ebrei da parte dei fascisti e dei nazisti, ma parla anche di come quella memoria (ma anche altre storie collegate con quelle storie perché i luoghi e i temi della memoria sono tanti) sono state raccontate nel tempo, di come i paesaggi si sono modificati senza cancellare la contaminazione che li ha colpiti.
Dunque i luoghi della memoria. Un’espressione che quando compare a metà degli anni’80 ha il pregio di innovare la sensibilità degli storici e di fornire nuove strade di riflessione.
Insieme di avvicinare le inquietudini e le passioni degli storici alla dimensione civile di un pubblico che avverte il bisogno di racconto storico e, insieme, il disagio di una storia paludata, ingessata, santificata. Una storia che soprattutto identifica con i soggetti forti (gli eroi, i protagonisti…) ma nel cui racconto non le persone non si trovano e dunque lentamente avvisano come estranea, perché il proprio mondo non compare mai trova così come sono sotto traccia le relazioni tra persone, la storia del paese e del villaggio. C’è il mondo alto in quelle storie, ma non la sua “vita”.
Quaranta anni dopo, a che punto siamo?, si chiede Cavaglion.
E si risponde dicendo che anche i luoghi della memoria non sono inquieti, che inquieta continua ad essere una sensazione di estraneità, che nel frattempo, proprio perché non si riconosce nella memoria celebrata, resta tale anche quando celebra e ricorda le vittime vere. Perciò va a trovare “conforto e rifugio” in altre memorie, nella controstoria, nella storia di chi allora era dalla parte del torto, e che oggi riprende ed esercita fascino, perché il paradigma vittimario trionfante non consente crescita, ma solo consolazione.
Un paradigma che prima ancora che nella memoria vince nella satira, oggi, il linguaggio dissacrante che è più forte tra gli affascinati del suprematismo o dei nuovi radicalismi di destra, piuttosto che nel pensiero riflessivo democratico che stenta a trovare le forme radicali di dare consistenza e profilo alle inquietudini e che dunque rischia di regalarle completamente a quei radicalismi che quaranta anni fa si diceva che “stavano nelle fogne”.
Come se ne esce? Certamente seguendo varie suggestioni e percorsi che Alberto Cavaglion suggerisce in questo suo libro, e che considero necessarie, anche se a mio avviso aprono un percorso che va ancora costruito più che consegnarci una cassetta definita di strumenti, di tecniche, di procedure. Provo a spiegare perché.
Prima una breve considerazione preliminare intorno al processo di ciò che chiamiamo memoria.
“Il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe, lo dimenticò”. È un verso del testo biblico che mi ha sempre inquietato. Si trova in Genesi, cap. 40, v.23, laddove il testo chiude la storia della interpretazione dei sogni che Giuseppe in prigione fa al coppiere e al panettiere del faraone.
La tradizione dei commenti ha come regola che la ripetizione nel testo biblico non è una riconferma ma chiede al suo lettore di capire la differenza, comunque di incrementare i significati. Perché Dio non spreca le sue parole e dunque se apparentemente ripete, è perché chiede al suo lettore/auditore di spiegare aumentando la dimensione del significato. Perciò mi chiedo: non bastava dire che lo dimenticò? Perché è scritto anche “non si ricordò”? E mi rispondo: Perché l’oblio non è mai solo l’effetto di un processo naturale (“lo dimenticò”), ma anche di un atto volontario (“non si ricordò”). Così anche per la memoria: non è solo ciò che non dimentichiamo, ma anche ciò che decidiamo di ricordare.

Perché è importante questa distinzione? Perché a mio avviso le politiche della memoria non sono riparative, ma sono invece deliberative. Ricordare non è sapere ma è, soprattutto, decidere, scegliere e, auspicabilmente, raccontare il profilo del percorso che ha mosso, motivato, e alla fine assunto forma in quell’atto. Non necessariamente per correggere o integrare, ma perché quella scelta dice del profilo culturale di chi agisce. Ovvero mette a nudo le sue motivazioni.
Qui credo stia uno dei punti che stanno a cuore a Alberto Cavaglion. Per questo introduce la categoria di «quarto paesaggio» che elabora riprendendo la riflessione avviata da Gilles Clemet nel suo Manifesto del terzo paesaggio.
Spiega così Cavaglion:
«Il primo paesaggio è quello della natura incontaminata, non toccata dall’intervento dell’uomo. Il secondo è il paesaggio delle arti figurative, della pittura, della poesia, della letteratura. Con «terzo paesaggio» Clément intende i «luoghi abbandonati dall’uomo» i parchi e le riserve naturali, le grandi aree disabitate del pianeta, ma anche spazi più piccoli e diffusi, quasi invisibili come le aree industriali dismesse dove crescono rovi e sterpaglie; le erbacce al centro di un’aiuola spartitraffico. Tali sono stati per lunghi anni i luoghi abbandonati dove si è commesso un crimine, un eccidio, una strage, spazi nascosti dove innocenti sono stati reclusi per via dei loro orientamenti politici o per la loro diversità. Questa la ragione che ci induce a immaginare per loro la definizione di “quarto paesaggio”».
La nozione di “quarto paesaggio” muove dunque dalla condizione preliminare di «luoghi abbandonati», a partire da un criterio che l’ecologia storica ha fatto suo da tempo: quello per cui il paesaggio non è più espressione delle relazioni tra la società e l’ambiente naturale, bensì quello delle relazioni tra il presente e l’eredità del passato, soprattutto laddove quell’eredità sia spesso un luogo mentale taciuto, o silente.
Partendo dal fatto che il paesaggio, come del resto lo spazio, somiglia sempre più spesso a quelle locande dove si trova solo ciò che uno vi porta, si tratta allora di costruire un diverso percorso, per cui a ragione la risposta di Cavaglion è di riscrivere quella condizione ereditata e intervenire per provare a scriverne una nuova.
Alberto Cavaglion ne indica vari in questo suo libro: il destino del «Blocco 21», ovvero del memoriale italiano di Auschwitz, una storia molto interessante di come non si produca memoria pubblica; Villa Emma; il campo di Fossoli; la piazza dove si affaccia la Torre della Ghirlandina a Modena, da dove nel novembre 1938 si lanciò nel vuoto Angelo Fortunato Formiggini, una figura di editore che ha dato l’impronta all’editoria e all’idea di libro novecentesco.
In alcuni casi (Villa Emma, il Campo di Fossoli) si tratta di luoghi poi “ritrovati”, ma al prezzo di uno sforzo che non ha molti riconoscimenti o che deve fare un percorso pubblico di riappropriazione.
Ogni volta il problema non è ritrovare la memoria, ma produrre e rintracciare un filo di storia perduta. Un’esperienza che riguarda non la prima generazione, bensì soprattutto la seconda generazione che succede a un evento traumatico, oppure a un evento che ha marcato definitivamente un prima e un dopo senza che l’attraversamento di quel confine sia stato registrato.
Perché invece venga registrato, non è sufficiente ritrovarlo, oppure riscoprirlo, ma occorre lavorare sul quella fonte, fare in modo che quella fonte (che sia una traccia, un percorso riflessivo, un luogo) consenta di ricostruire una scena, alluda a un gesto, e attraverso quel gesto si vedano relazioni tra individui. Storie di vita, insomma.
Tra i molti paesaggi e luoghi di memoria che Cavaglion propone di «rivisitare» ne scelgo due diversi. Entrambi hanno a che fare con la costruzione di memoria e riguardano l’offerta di contenuti per la seconda generazione, ovvero di coloro che sono nati dalla generazione dei sopravvissuti. Rispettivamente Villa Emma e il Memoriale italiano di Auschwitz (o meglio che fino al 2010 si trovava ad Auschwitz ed ora sta ricomponendosi a Firenze).
Villa Emma, dunque.
Quella di “Villa Emma”, una storia di salvataggio di bambini nell’estate del 1943, è una storia che ha stentato molto ad affermarsi.
Si potrebbe dire che quell’esperienza di solidarietà e di salvataggio a cui partecipano tutte le figure essenziali del paese (il maresciallo dei Carabinieri che consente la rottura dei sigilli prima del permesso da parte del Prefetto, il dott. Giuseppe Moreali, sanitario del Comune di Nonantola; poi i sacerdoti del Seminario di Nonantola che ospitarono buona parte dei giovani; poi i vari mezzadri che ospitarono i ragazzi;
gli artigiani, come il falegname Erio Tosatti che ne ospitò parecchi. Ma La protezione non fu solo ospitalità e nascondimento, ma anche preparazione di documentazione falsa. Perciò i sacerdoti, per esempio don Tardini e don Beccari per la consegna di false carte di identità; la firma di Giuseppe Moreali, podestà di Larino [un comune in provincia di Campobasso, al di là della Linea Gustav e dunque impossibile da verificare]; Primo Apparuti, specialista in strumenti di precisione, che prepara un timbro a secco con lo stemma del Comune di Larino.
Insomma la storia di Villa Emma ha molto a che fare con una idea di villaggio, forse meglio con una «rete di villaggio». Riguarda certamente un luogo preciso e una idea di comunità che è propria dell’Emilia tra Età moderna e contemporanea; di una struttura sociale ed economica, in gran parte fondata su un sistema di paese in cui al centro stanno i legami sociali che costituiscono reti di comunità nelle campagne emiliane tra ‘700 e ‘900.
Conta anche molto una tradizione culturale definita intorno alle pratiche sociali del mondo rurale.
In breve, si può dare il senso di quella storia senza ripercorrere e ricostruire quel quadro che significa definire una rete, una comunità di villaggio, una storia di relazioni?
Non dico che quella struttura e quella storia non potevano produrre altro che quello (ritroveremo quel modello di patto agrario e di sistema di relazioni di villaggio in gran parte della realtà centrale italiana ma non ritroveremo in quella vasta macroregione fondata sul patto agrario mezzadrile lo stesso tipo di evento). E tuttavia quel modello è significativo, da non trascurare: racconta molte cose, se «fatto parlare».
Considero ora la questione del Memoriale italiano della deportazione, più noto come «Blocco 21», costruito nello spazio espositivo di Auschwitz negli anni ’70 e rimosso nel 2010 su richiesta del Museo di Auschwitz perché considerato non rispondente ai criteri espositivi e museali di quel museo.
Nella discussione che in Italia si sviluppò, molte erano le questioni delicate e complicate. Quella discussione del Memoriale si risolse allora in una difesa di ufficio di ciò che c’era, scelta sbagliata perché oltre a non rispondere, evitava di affrontare due tematiche che ancora oggi abbiamo davanti e irrisolte.
Il Memoriale rappresenta la sintesi e il risultato di una riflessione storica e culturale che ha marcato il secondo dopoguerra e è entrata in crisi negli anni ’70. In seconda istanza ciò che è emerso da quella crisi è una distinzione e poi un primato dello sterminio ebraico sulla esperienza della deportazione che ha riscritto i criteri e le categorie con cui è stata analizzata l’esperienza del Lager.
Il sistema concentrazionario è diventato essenzialmente la macchina dello sterminio e si è perduta o è stata accantonata la realtà del lager come macchina schiavistica di lavoro. Queste due realtà non sono state la stessa cosa, hanno coabitato nel complesso di Auschwitz, e hanno distinto e definito l’universo concentrazionario. Ma distinguere non significa privilegiare, bensì comparare e significa sapere che quelle diverse realtà erano legate da una funzionalità che rispondeva allo stesso principio. Questo presupposto non possiamo dimenticarlo, né considerarlo un particolare trascurabile.
Si potrebbe osservare come i luoghi di memoria legati allo sterminio non siano dei posti “quieti” dal punto di vista interpretativo, anzi concentrino su sé stessi molte conflittualità, non solo tra esperienze diverse di deportazione, ma anche tra memorie nazionali e memorie ebraiche. Ci dovremmo chiedere tuttavia perché la questione del doppio livello della deportazione, che pure non è meno dirimente in altri contesti nazionali, produce in Italia un’esasperazione del confronto tra quelle memorie, rendendolo più marcato e sofferto. Talora fino a dividerle.
La risposta più fondata mi sembra questa: queste due ultime memorie, al di là di quali agenzie abbiano trovato a rappresentarle, non hanno compiuto un processo di elaborazione che le riguarda singolarmente e reciprocamente rispetto alla storia nazionale. Non è cresciuta in Italia una consapevolezza pubblica, ma anche storiografica, capace di confrontarsi con gli strumenti della comunicazione di massa, in primis le forme espositive e museali.
Soprattutto non si è definita una riflessione sull’Italia fascista. L’Italia fascista continua ad essere un argomento storiografico trattato dal punto di vista dell’antifascismo, Non esiste significativamente in Italia un museo dell’Italia fascista, capace di descrivere e di affrontare la storia italiana e della società italiana durante il fascismo, soprattutto con un fine didattico, in cui trovi uno spazio adeguato e una trattazione congrua, la storia delle minoranze (oppresse e represse) e tra queste la storia degli ebrei in Italia durante il fascismo attraverso la lente delle diverse fasi della loro presenza nella società italiana: integrazione e consenso al regime, il sofferto distacco dopo il varo della legislazione razziale, fino ai percorsi del ritorno. In breve uno o più luoghi pensati come laboratori, aventi un fine formativo e didattico, rivolti non solo al mondo della scuola, ma anche rispondenti alla necessità di produrre un’educazione civica per gli adulti.
Siamo ancora molto lontani da questo in Italia.
Credo che lo sforzo riflessivo di Cavaglion sia anche volto a mettere al centro questo problema che non è, ripeto, solo una questione relativa alle competenze professionali, ma alla costruzione di una educazione civica. Che ancora non c’è. Decontaminare le memorie è anche, forse, un percorso per rendere possibile la definizione di una sensibilità pubblica, un modo diverso di «fare cittadinanza».