I Fondamentali di Frank Wilczek / La fisica che tocca il fondo
Se c’è un vizio comune alla nutrita messe di congetture cui per comodità ci si riferisce con “pensiero occidentale” è la fascinazione per il fondamento. L’ancoraggio solido a qualcosa che ha il carattere tangibile della permanenza. Qualcosa che non sia soggetto alle dinamiche distorsive della sensorialità e dell’esperienza prospettica, in cui la percezione è aggravata dal sospetto costante che quel che ci sta sotto il naso abbia dell’ingannevole. La fisica, la scienza più dura delle scienze naturali, non è insensibile a tale fascinazione. All’opposto, ha ricevuto in eredità dalla screditatissima metafisica tradizionale il compito di giungere al fondamento, vale a dire a quella posizione ben salda in cui il mondo si dà a vedere così com’è – obiettivo che persino la filosofia, solitamente incline a un’ambizione senza pudore, da Kant in poi ha volentieri demandato ad altre discipline. C’è quindi chi, nel pantheon dei fisici contemporanei, declina la ricerca del fondamento nel senso di una ricerca dei principi ultimi, detti appunto i fondamentali, capaci di superare i limiti prospettici degli esseri limitati che già sempre siamo e di restituire un punto di vista da cui “le cose” possano abbracciarsi “nella loro interezza” (p. 119).
È così che scrive in I Fondamentali (Einaudi, 2021) Frank Wilczek, le cui ricerche nel campo della cromodinamica quantistica gli valsero nel 2004 il premio Nobel assieme a Hugh David Politzer e David J. Gross. La fisica contemporanea, nell’ottica di un suo praticante così insigne, può essere raccolta in un insieme di lezioni fondamentali, dieci in tutto, che si propongono, senza alcuna professione di umiltà, di dire quello che c’è nel mondo fisico, come lo si può conoscere e cosa ci manca per farlo appieno. Chi, come la scrivente, ha a cuore eresiarchi sconfitti dalla storia come David Bohm, che di questa concezione della fisica non saprebbe cosa farsene, non è forse la più adatta a offrire un quadro sintetico di tale prospettiva. Ma qui siamo, e a questo punto non possiamo esimerci.
Il testo è suddiviso in dieci capitoli, raccolti in due parti. La prima ha il compito di chiarire quali sono gli ingredienti che, in base allo stato attuale della fisica, entrano in gioco quando si ha a che fare con l’universo. Si tratta allora di spazio e tempo, particelle e forze elementari, materia ed energia. Il tutto condito da un ampio apparato di esempi di carattere storico e considerazioni generali sul futuro della disciplina. La seconda parte affronta alcuni temi di frontiera, che si interrogano su come l’universo abbia raggiunto la configurazione attuale e quali aspetti di tale configurazione rimangono ancora carichi di mistero. Ecco allora un’agile presentazione su Big Bang, teoria dell’inflazione, materia ed energia oscura, gravità quantistica, nonché su quel che Wilczek denota come complessità dinamica – il progressivo emergere e il successivo evolvere, in opportuni regimi energetici, di fenomeni macroscopici di varia natura.
Ora, in questo assortimento così variegato – d’altra parte i fondamentali richiedono una tale abbondanza – alcuni indizi consentono di situare la prospettiva teorica di Wilczek nel solco di una tradizione che vanta tra le sue fila un’ampia schiera di fisici illustri, tutti intenti alla derivazione di una “teoria del tutto”. E non è un caso se tali indizi sono affidati ai capitoli, il terzo e il quarto, che, ad avviso di chi scrive, risultano i più convincenti per struttura, finalità e chiarezza espositiva. I capitoli in questione si occupano di offrire un affresco del cosiddetto modello standard, i cui ingredienti di base sono denominati particelle elementari. Perché tale modello possa funzionare, esso deve tenere conto di alcuni principi che, ad avviso di Wilczek, consentono di giungere a fenomeni lontanissimi dagli oggetti cui l’esperienza comune ci dà accesso. Si tratta di quattro principi-guida, nel senso che offrono una mappa orientativa nella formulazione di leggi che, come si dirà poi, possano andare ancora più a fondo – principi che quindi hanno da intendersi come strumento funzionale anziché come descrizione adeguata del mondo.
Il primo principio, del cambiamento, sostiene che le leggi fondamentali descrivono l’evoluzione degli stati fisici (si rammenti questo passaggio, perché dovremo tornarci). In luogo di chiedersi perché l’universo sia strutturato in un certo modo, è più proficuo indagare il modo in cui l’universo evolve.
Il secondo principio, di universalità, postula che gli esperimenti condotti in condizioni analoghe conducano a risultati analoghi, in virtù del fatto che le leggi fondamentali valgono ovunque e in qualsiasi momento. Il terzo, di località, asserisce che le leggi fondamentali hanno natura locale. Sicché non è necessario tenere conto dell’universo nella sua interezza per controllare i parametri che interessano uno specifico contesto d’indagine. Il quarto, di precisione, afferma che le leggi fondamentali sono del tutto accurate, esprimibili sotto forma di equazioni matematiche che non ammettono eccezioni. Questi quattro principi costituiscono una strategia operativa cruciale nella messa a punto di qualunque teoria fisica e, in particolare, del modello standard e della sua versione più completa, che Wilczek chiama core theory.
La core theory, che riassume quanto al momento sappiamo delle quattro forze fondamentali (elettromagnetica, nucleare forte, nucleare debole, gravitazionale), si concentra sul comportamento microscopico della materia, le cui proprietà primarie sono individuate in massa, carica, e spin. Propone quindi una tassonomia in termini di particelle elementari, che non vanno pensate tanto come entità dotate di una dimensione o di una forma intrinseche, quanto piuttosto, scrive Wilczek, quali punti privi di struttura, dotati di specifiche proprietà primarie.
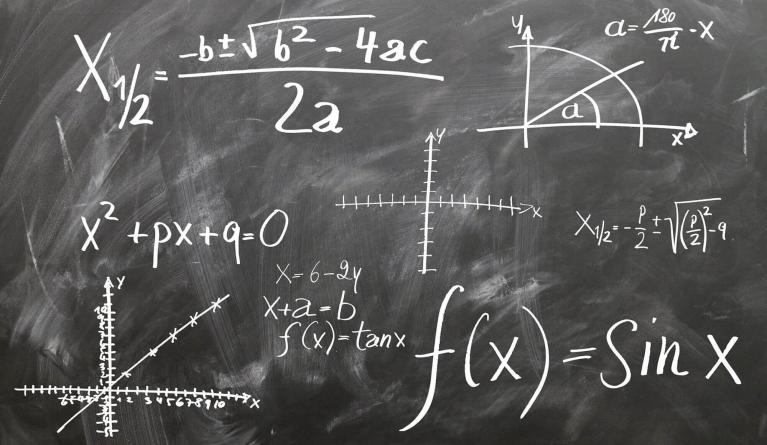
Naturalmente, ne esistono di varia natura, e possono pertanto essere distinte, in ragione del tipo di statistica cui rispondono, in fermioni e bosoni, e quindi ulteriormente classificate a seconda del tipo di interazioni che le contraddistinguono.
Ed è proprio in questo ambito che il contributo di Wilczek si è rivelato decisivo. Come si diceva sopra, il modello standard descrive tre delle quattro forze fondamentali. Tra queste, la forza nucleare forte è stata oggetto di uno studio intensissimo per gran parte del Novecento. A partire dai modelli sulla struttura dell’atomo, si arrivò infatti a ipotizzare – con la proposta originariamente avanzata nel 1911 dal fisico Ernest Rutherford – che la carica positiva di quest’ultimo dovesse essere concentrata in una sua porzione molto piccola, denominata nucleo. Tale nucleo, si scoprì poi, è a sua volta composto da due tipi di particelle, i protoni e i neutroni. Serviva allora una forza che spiegasse come la repulsione tra particelle con carica identica (i protoni) potesse comunque tenere assieme i nuclei atomici. Essa venne detta forza forte. Ben presto si capì che, per poterne comprendere la natura, era necessario guardare all’interno dei protoni con tecniche sperimentali adeguate.
Alcune delle ricerche di Wilczek hanno avuto come oggetto lo studio di tali strutture interne. Assieme a David Gross, giunse nel 1973 alla formulazione di una teoria che spiegava come alcune particelle, tra cui quelle che costituiscono le componenti dei nuclei atomici, siano caratterizzate da una proprietà denominata libertà asintotica: la loro forza attrattiva è estremamente intensa per grandi distanze, sino a divenire arbitrariamente debole per distanze molto piccole, asintoticamente nulle. Per offrirne una visualizzazione intuitiva, Wilczek propone l’immagine delle forze prodotte dagli elastici: se si prendono due estremità di un elastico, la forza di rientro tra esse cresce proporzionalmente con la distanza, per diminuire man mano che le due estremità si riavvicinano. Tale scoperta valse loro il succitato premio Nobel.
Ma fin qui, il problema del fondamento ha ancora dell’understatement. Sembra si parli di “fondamentali” nel senso di ipotesi sulla struttura di base dell’universo, che hanno appunto carattere di costrutto teorico volto a dar senso a una specifica proposta teorica. Anche la stessa nozione di “particelle prive di struttura”, d’altro canto, ha tutti i tratti distintivi di un concetto astratto, utile alla costruzione della teoria, se è vero che in fisica si tende oggi a concepire la particella come precipitato transitorio di un campo anziché entità puntiforme – argomento teoricamente denso, con cui qui si preferisce non importunare chi legge. L’understatement però svanisce via via che la core theory lascia trasparire una suicida aspirazione all’autosuperamento: si tratta appunto di un rampino utile nella discesa ripidissima verso il fondamento. Altro che principi funzionali utili nell’approssimazione a una visione comprovabile del reale: la fisica deve afferrare il reale, persino oltre le capacità limitatissime dell’essere umano. La traccia di un tale progetto grandioso, di tale aspirazione a un fondamento aprospettico e quindi assoluto, la si trova nell’esergo al paragrafo conclusivo del quarto capitolo (p. 118), a firma del grande matematico tedesco Hermann Weyl: “Il mondo oggettivo è semplicemente: non accade.
Soltanto allo sguardo della mia coscienza, il movimento lungo la linea d’universo che rappresenta la vita del mio corpo, una sezione di questo universo può offrirsi come una immagine che fluttua nello spazio e che cambia continuamente nel tempo”. Questa professione di atemporalità offre la chiave di decrittazione di un progetto, quello di Wilczek e dei modelli fisici cui si ispira, che si carica di una pretesa epocale: a dispetto del primo principio menzionato sopra, quello per cui le leggi fondamentali descrivono l’evoluzione delle cose, la fisica deve aspirare alla cattura del fondamento, la prospettiva sub specie aeternitatis da cui l’universo può concepirsi per come è – ben oltre la visione, dimidiata e liminale, delle cose che evolvono.
Quindi, la fisica è chiamata a rimuovere la scorza gelatinosa dell’accadere, che appanna la vista e dà l’idea tutta transeunte di una realtà che evolve e muta, per giungere così “alle caratteristiche durature del mondo” (p. 118). I principi discussi da Wilczek, quindi, sono la scala di Wittgenstein: una volta usata, dobbiamo presto disfarcene. E giunti così in alto, si respirerà l’aria rarefatta delle cose per come sono. Detto altrimenti, la core theory, con i suoi principi, è da intendersi come il più efficace distillato interpretativo disponibile al momento, capace di indicare la strada più sicura per giungere a qualcosa che, ad oggi, non sappiamo cogliere. L’ambizione della fisica, una volta intrapresa questa strada di tenace e progressivo dissodamento degli strati che ci separano dal reale, è quella di svelare le leggi “eterne” (p. 118) dell’universo.
A chiusura: le perplessità che pur emergono in questa breve sintesi di un libro tanto denso, e tanto utile, non intendono mettere in questione l’utilità euristica di un approccio fondato sull’idea di giungere agli “elementi fondamentali”, quanto sottolinearne l’utilità, per l’appunto, euristica. Se invece l’idea della fisica che se ne ricava è una sorta di “disvelamento del segreto”, dell’apertura di una scatola nera, dell’esumazione dei tasselli ultimi e delle leggi immutabili, si rischia di presentare una disciplina così carica di pensiero creativo come una linea di ricerca unidirezionale, tesa alla giustificazione completa di una teoria fisica ultima, che si rivelerà presto superiore alle altre. La fisica come campo di produzione concettuale, all’opposto, almeno al modesto avviso di chi scrive, si nutre dell’ebrezza che si ricava dal costante superamento di ciò che nel qui e ora si crede erroneamente possa essere “il fondamento”.
Per questo, come si accennava sopra, rimaniamo assai più avvinte, fosse anche solo per la lirica più intensa, all’idea bohmiana dell’infinità della natura e dei livelli del reale. L’idea cioè che qualunque discorso teorico attorno all’universo non possa che esprimere in forma parziale la complessa rete di relazioni che caratterizzano la realtà fisica e quindi non possa che perimetrarla, racchiuderla in confini angusti, renderla un po’ meno complessa e identificare così elementi ultimi e fondamentali che tali sono solo nel quadro che del reale offre la teoria.
Questo non comporta alcun congedo dal realismo, neppure del tipo più ingenuo, che vede nella teoria un modo di “acciuffare” la realtà. Comporta piuttosto un consapevole esercizio di provvisorietà metodologica a tenere ferma la consapevolezza che quel che qui e ora si intende come il “fondamentale” molto probabilmente si rivelerà presto come un livello che rimanda ad altri livelli. Questa è l’idea di una fisica certo più modesta, che ammira con sincerità chi, come Wilczek, ritiene di poter trovare il fondamento, eppure a principio di base mette non quest’ultimo, bensì l’“approssimazione” – la convinzione cioè che il reale non si lasci mai agguantare nella presa di poche leggi e che lo si possa toccare sempre solo per gradi, su livelli, in intrichi provvisori. L’idea quindi che si debba rinunciare per sempre alla pur agognata solidità del fondamento, come meglio di noi scrive Anna Maria Ortese nella sua lettera a Massimo Bontempelli: “Non creda che io non senta l’‘approssimativo’, l’incompleto di questa impressione: ma credo che ancora per molto tempo io andrò per ‘approssimazione’, che sempre – forse – io sarò oscura e intimidita di fronte ad opere come la Sua, così sfavillanti, innanzi a una tale indipendenza fantastica, che per me rimarrà sempre un desiderio” (A. M. Ortese, Da Moby Dick all’Orsa Bianca, Adelphi 2011, p. 141).







