Il ritorno del panteismo / Il dio sensibile
Emanuele Dattilo ha scritto un grande libro. Si intitola Il dio sensibile, e come dice senza giri di parole il sottotitolo è un Saggio sul panteismo.
La prima scoperta che si fa, man mano che si avanza nella lettura, è che il panteismo è il tema dei temi, uno dei sentieri filosofici sui quali gran parte dei contemporanei si sta avventurando, specialmente negli ultimi anni. Solo che in tanti lo imboccano senza saperlo, senza dominare la materia, prendendo strade secondarie, andando in palestra o coltivando fiori esotici, cambiando idea a metà percorso, usando splendide parole di tradizioni altre, ma ignorando quelle studiate a scuola – va detto che in tanti casi sono impronunciabili e geniali locuzioni latine altomedioevali. Il panteismo, dunque, è pienamente in linea con lo spirito del tempo: è di moda, ed è persino utile per appassionarsi agli algoritmi di ricerca e alla questione ecologica, peccato che lo sanno in pochi.
La seconda scoperta che si compie divorando queste pagine è che Neri Pozza non poteva scegliere una copertina migliore di Tramonto a Turners Cove. Perché, le rivelazioni che Dattilo ci accompagna a vivere con una pazienza e una cultura rare, producono in noi una sensazione simile a quella che secondo la leggenda sperimentò il pittore inglese Turner quando si fece legare all’albero maestro di una nave per osservare la tempesta come nessuno l’aveva mai vista. Cioè intuire che la comprensione più completa del mondo – di una tempesta o di un tramonto se sei William Turner – alle volte è inconciliabile con la distinzione, con la pretesa di isolare un cielo da un mare, per esempio. Saper dominare la luce nella pittura, al più alto grado possibile, non significa usare la propria tecnica per chiarire o per individuare, ma per confondere. Significa notare che in certe ore del giorno e della notte persino il paesaggio più complicato da dipingere non è altro che una regione indefinita di luce diffusa. E che questa rappresentazione rivoluzionaria non solo non è astratta, ma è la più concreta e verosimile. È allora che diventa visibile come “tutto è in tutto”, che è uno dei pochi adagi diffusi e noti del panteismo.
«Il panteismo è una corrente che attraversa come un vento il pensiero» si legge quasi in apertura, e lo attraversa come un vento perché come un vento lo sconvolge. Nelle prime pagine Dattilo mostra che non c’è quasi filosofo panteista che non abbia suscitato antipatie illustri, che non sia stato equivocato, censurato, esiliato, o addirittura ucciso. Perciò, nonostante il suo sia un saggio senza spinte romanzesche, per le prime duecento pagine ci si trova dentro a un giallo. La tensione narrativa, volontaria o meno, è fortissima. Non si procede nella lettura solo per abbeverarsi all’intelligenza dell’autore, ma anche per curiosità, per sapere come mai gli scritti di Davide di Dinant (1160-1217) sono sopravvissuti a stento, o perché Almarico era considerato eretico.
E in breve si scopre che, aderendo in maniera più o meno travolgente alla visione panteista del mondo, non c’è quasi niente di ciò che è stato costruito dal potere religioso, politico o intellettuale che resti in piedi – dopotutto è un motivo più che ragionevole per aver fatto fuori tutti i panteisti, fino a quando si è potuto: scongiurare un grandissimo caos. Tra le prime zone di comfort della metafisica tradizionale a venire sbaraccate in una prospettiva panteistica ci sono l’idea di creazione, del rapporto personale tra Dio e le anime, i dualismi di corpo e spirito e di materia e di forma, la conoscenza per come l’abbiamo sempre intesa, ovviamente l’io, ogni forma di individualismo e di specismo. Sono questi gli effetti benefici del vento: «proprio questo disorientamento, questo improvviso cedere del terreno sotto ai piedi, è il primo respiro del pensiero, il primo sogno di liberazione da una zavorra terrificante, che rendeva l’aria irrespirabile». Non è un caso che Emanuele Dattilo sia uno studioso di Giordano Bruno. Tutto il libro è inscritto in una precisa idea della filosofia come un gusto del coraggio, un invito a liberarsi dalle forme precostituite, e a vedere sempre l’alternativa o l’indizio logico di una alienazione in corso, in un esercizio costante e limpido di libertà. Ed è così, all’ombra di questa promessa di libertà, che la tentazione di saperne di più della cospirazione e dei cospiratori diventa fortissima.
Dattilo non sceglie l’ordine cronologico, ma affida la guida del libro a una serie di domande che sgorgano di ragionamento in ragionamento, di frammento in frammento. Il suo raffinato edificio di rimandi e rincorse ventose si appoggia proprio su un primo testo di Davide di Dinant, uno dei protagonisti indiscussi del dramma panteistico, dove si isola bene il concetto di mente. La meravigliosa verità che viene a galla, prendendosi il tempo di dragare le parole, è che se la materia e il pensiero coincidono nella mente, allora l’immortalità è uno stato di cui tutti facciamo esperienza e «per essere eterni bisogna avere un corpo», dunque il divino corrisponde «a questa assoluta intelligibilità del reale». La novità più elettrizzante qui dietro è che la concezione panteistica del mondo è una continua raccomandazione a scardinare qualsiasi gerarchia di importanza attribuita erroneamente alle creature o agli oggetti del sapere.
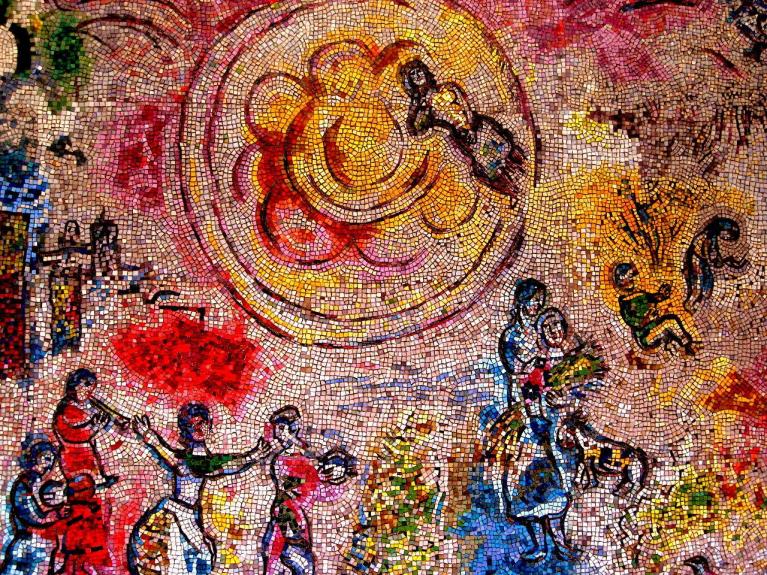
Se è vero che la mente pervade ogni cosa, è vero anche che ogni elemento possiede una sorta di immaginazione. Detto in altri termini, se sei panteista, la pensi come Schelling: «Di che cosa posso vantarmi? – Dell’unica cosa che mi fu data, di aver cioè annunciato la divinità anche del singolo, la possibile uguaglianza di ogni conoscenza a prescindere dalla differenza di oggetto, e pertanto l’infinitezza della filosofia». È con affermazioni come questa, strappate ai vari interpreti con precisione stellare, che Emanuele Dattilo provoca nel lettore la sensazione di esserci già passato ma di non essere stato in grado di dirlo meglio. Improvvisamente, per la durata di qualche pagina, un semplice saggio si trasforma in una buona novella: viene voglia di convertirsi a questa filosofia che spiega in un modo del tutto nuovo alcuni dei nostri sentimenti e conferma alcuni dei nostri sospetti. Per primo quello che la piramide sia un modello gnoseologico e biologico fallimentare.
Tra gli altri pregi, Il dio sensibile è una miniera di aforismi folgoranti che non provengono soltanto dagli esponenti del genere, ma anche dai letterati, con una particolare predilezione per Franz Kafka. Di tanto in tanto poi, alle sentenze degli altri si aggiungono quelle di Dattilo, secondo il quale: «L’ontologia è una sorta di stratigrafia predicativa», o il divino è «una pellicola trasparente avvolta attorno a ogni cosa, mai separata in una forma particolare». La sua chiarezza è esemplare persino nei momenti di esegesi, sempre conserva una certa leggerezza e una spennellata di entusiasmo.
Tra i momenti più alti di felicità della penna di Dattilo ci sono i paragrafi dedicati a occupare il vuoto della creazione. Se Dio non è l’architetto del cosmo e il modello che descrive l’origine del mondo non è quello della nascita, allora che cosa si mette al suo posto? La risposta non arriva in maniera univoca in un solo punto del libro, la fatica di ricomporre il quadro spetta al lettore, però a una certa altezza emerge dal discorso una parola chiave: metamorfosi. Le cose del mondo, più che nascere e morire, si trasformano. Ma non mutano per rispondere al disegno di qualcuno, mutano perché lo desiderano.
Se c’è un discorso che attraversa il libro dall’inizio alla fine, è proprio quello che riguarda la figura del desiderio.
Dattilo ha il merito di condurre una spassionata riabilitazione della parola, che dopo aver letto il libro si può riprendere a usare in una maniera più tecnica e meno ingenua. «Se, cioè, il desiderio fosse l’incominciamento della forma nella materia, piuttosto che la privazione e la mancanza di essa?».
Per completare la risposta alla domanda, si intraprende una memorabile cavalcata nelle terre d’amore, in uno dei capitoli più belli del saggio, verso la fine: sono pagine dove Ludwig Feuerbach tiene testa a Platone e il pensiero di Freud diventa incredibilmente più chiaro. In più, quando dalla trattazione sul desiderio erompe quella sulla conoscenza, allora scopriamo che per secoli la vista ha condizionato la nostra rappresentazione di qualsiasi percezione, convincendoci che al cuore di questo processo sia possibile tracciare una linea netta e inequivocabile tra soggetto e oggetto. Ma il gusto, per esempio, offre un modello molto più raffinato di come i nostri sensi si espongono al mondo: senza la mediazione dell’aria o della distanza, a contatto col resto. Una sensazione che è tutt’uno con l’organo di senso. Soggetto e oggetto che si confondono, proprio come i rimbalzi di luce sul cielo e sul mare di Turners Cove.
A furia di svelare e demistificare, si potrebbe credere che in questo libro prevalga la pars destruens, invece è assolutamente il contrario. Dall’inizio alla fine le raffiche più o meno impetuose del vento panteista non fanno altro che restaurare e ripulire il nostro sistema di comprensione delle cose e il conseguente panorama del mondo, fino a restituircelo più funzionante e terso. Così, nelle ultimissime pagine, il piano di Emanuele Dattilo si rivela in tutta la sua saggezza: in ultima analisi inseguire il mistero del panteismo è semplicemente un’altra strategia per trovare la felicità. Una strategia liberatoria, che per una volta non equivale a un fare. La felicità «è eterna, non acquisita attraverso uno sforzo costruttivo» e non va perseguita con un esercizio estenuante e privativo, ma solo accorgendosi di ciò che siamo: di fatto, è una modalità di ascolto del mondo in noi e di noi nel mondo.
Nonostante la cova del sapere di vento sia da tempo in atto dentro alle cose, il libro riesce a procurare in noi un sentimento gioioso di attesa che l’uovo si rompa. O, per dirlo in termini panteistici, che la sua metamorfosi si compia fino in fondo. E poi ancora.







