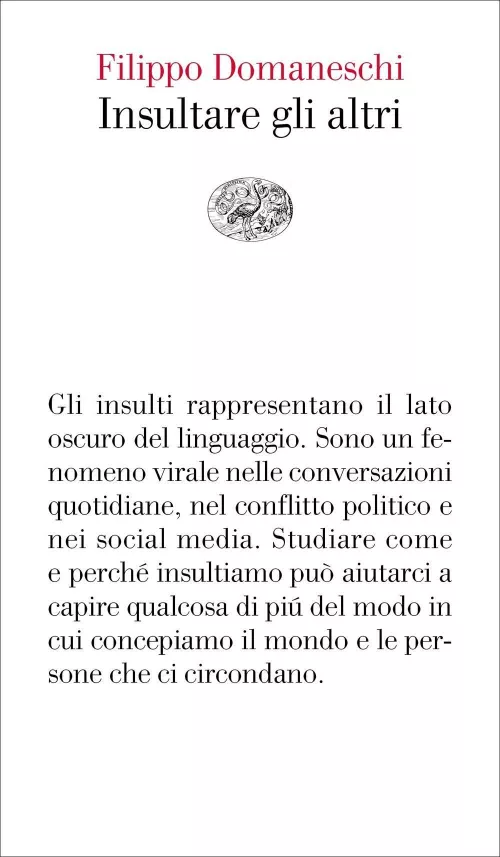Maleducazione / Insultare gli altri: perché?
Gadda insultava Mussolini definendolo “sanguinolento porcello”, “fezzone”, “super balano”, “naticone ottimo massimo”. Era il suo vertiginoso modo di ingiuriare il dittatore e, come spregio ulteriore, lo faceva senza nominarlo mai. Un maestro, anche in questo. D’altro canto chi meglio di lui: l’insulto, come ogni oggetto d’invenzione umana, non ha, perché non può avere, limiti di sorta. Noi siamo fatti anche di insulti, questo è il punto. Le nostre relazioni sociali sono “condite” dagli insulti, più o meno intenzionali. Sono un ingrediente della gastronomia sociale, linguistica e non, che si realizza in circostanze particolari, e riesce tanto meglio quanto maggiore è l’abilità inventiva di chi lo prepara. Non solo, la pratica dell’insulto ci è famigliare fin da bambini, e ciò che va compreso è che “dell’insulto non possiamo fare a meno”, come dice il linguista Filippo Domaneschi nell’introduzione a Insultare gli altri (Einaudi 2020). La sua è una scrupolosa analisi dei guizzi linguistici e comportamentali che noi usiamo per affermare le nostre ragioni o per difenderci dalle aggressioni altrui, ma soprattutto uno studio delle ragioni per cui si insulta, delle identità istituzionali o psicologiche dell’insultante e dell’insultato, condotto con la precisa consapevolezza che “la definizione di linguaggio insultante e offensivo non è in alcun modo perspicua” (p. 9). Troppe, infatti, e troppo lontane sono le culture e le lingue (oggi settemila nel mondo!) delle comunità umane per cui uno stesso comportamento qui offende e lì no. E diventa ancora più difficile spiegare il fenomeno se pensiamo alla rete e alla sua capacità combinatoria dei linguaggi. Freud diceva che gli uomini quando hanno imparato a insultarsi invece di lanciarsi pietre hanno fondato la civiltà. Dunque, altro che questione di bon ton, l’insulto è uno dei fronti su cui si elabora e si esplica l’aggressività umana.
Nel percorso proposto da Domaneschi ci si rende conto della variegazione non solo linguistica dell’insulto: si va dalle parolacce agli epiteti denigratori, dalle volgarità che tutti conosciamo alle espressioni “carine” che fanno leva spregiativamente sulla provenienza geografica delle persone, sulla loro identità sessuale, sull’appartenenza sociale, etnica, politica. Studi e repertori nazionali e internazionali (vedi la vasta bibliografia) documentano la costante attenzione che è stata riservata in tutto il mondo a questo “lato oscuro del linguaggio”, come lo definisce l’autore. C’è una grammatica dell’insulto che lo rende estremamente malleabile: un solo esempio (una scelta affettiva, perdonate) con la parola genovese belín – l’organo genitale maschile –, da cui possono derivare verbi o sostantivi o modi di dire che rendono la “parolaccia” una radice linguistica vera e propria (belinare, abelinare, abbelinare, desbelinarsi, imbelinarsi, imbelinare oppure belinn-a, belinàta, belinone oppure ancora avèine u belín pin, menimbelino) in grado di intervenire in ogni registro emotivo/affettivo (p.32).
Qualunque teatro sociale è una specie di sagra degli insulti, a questo è dedicata la curiosa docuserie americana Storia delle parolacce appena uscita su Netflix e condotta, un po’ alla maniera di Pico de Paperis, dall’attore Nicolas Cage. Ma se pensiamo alla politica l’immagine si esalta al massimo grado. Ciascuno di noi ha in mente intere enciclopedie dell’insulto politico a cui poter attingere, non ultimo l’insulto istituzionale della spettacolare uscita di scena, dopo la sconfitta elettorale, del presidente americano (che gaddianamente non nomino) il 6 gennaio 2021, ispiratore di una specie di finto putsch autenticamente antidemocratico ai danni del parlamento statunitense, messo in scena da strani personaggi, suoi elettori da lui convocati, tanto bizzarri e improbabili quanto pericolosi. Il mondo per qualche ora sotto shock, un delirio social, un fiume enorme di insulti provenienti dai vari schieramenti, e quelli che lanciavano insulti ce l’avevano con quelli che avrebbero voluto ricominciare a lanciare pietre.
Pare che tutto cominci dall’amigdala, la parte più primordiale del nostro cervello, quella che gestisce le emozioni, e quindi anche lo stato emotivo fondamentale per la conservazione della specie, cioè la paura. Questo almeno per quel che riguarda le nostre reazioni insultanti impulsive (pp.71-73). Poi viene una sorta di “educazione” specifica, un itinerario che comincia dall’infanzia con i classici quattrocchi, ciccione e nano scagliati ai primi “nemichetti” che non ti passano il pallone, fino alla messa a punto di una vera “capacità denigratoria” che, dice Domaneschi, “è un tassello formativo essenziale proprio di ogni autore competente” (p. 82).

È l’apprendimento del linguaggio del combattimento sociale. Dice l’autore, con Michel Foucault, che ogni discorso è “l’espressione di una trama di rapporti di potere che regolano ogni società” (p. 94); e dal potere sono stabilite le cose ammissibili, ciò che è accettabile e ciò che è irrispettoso del buon costume sociale. Ma gli insulti o le bestemmie possono metterlo in discussione, e produrre parole offensive che, come un atto di forza fisica, possono generare rapporti di potere, perché “l’offesa è un dispositivo di dominio” (p. 95). Pensando a certe campagne elettorali è facile vedere dispiegate queste dinamiche dell’inquietudine politico-sociale del nostro tempo.
Altro è la maleducazione, un territorio limitrofo a quello degli insulti, nel quale noi troviamo la possibilità non solo di aggredire l’altro, ma anche di metterne in discussione i valori, le consuetudini. Non è ovviamente una semplice questione di possesso o meno delle buone maniere, del codice minimo della buona creanza (averla è sempre comunque fattore di gradevolezza per tutti). Si tratta piuttosto di capire che la maleducazione, nel nostro tempo, si è trasformata in istanza “culturale”, in contenitore valoriale non più vincolato a specifiche condizioni sociali. Non è più il segno di appartenenza e distinzione sociale di un passato, non lontanissimo, in cui regnava la diffidenza di ceto, di quando davanti al parvenu a Napoli si diceva Fidate d’‘o signore ‘mpuverito, ma nun te fidà d’‘o pezzente sagliuto. Anche la maleducazione, pertanto, non è fenomeno facilmente circoscrivibile perché la sua complessità ha a che vedere con i modi che gli uomini scelgono, nelle diverse epoche, per aggregarsi, e per rivedere di continuo le regole di questo loro stare insieme, cioè di aderire alla “normativa” di un certo progetto di vita. Ne parla diffusamente Sergio Tramma (a cui devo il detto napoletano di prima) in Sulla maleducazione (Raffaello Cortina 2020), chiarendo il fatto che la materia oggi è resa ancora più sdrucciolevole dall’irrompere sullo scenario sociale del populismo con le sue “maleducazioni liberate dalla fine delle grandi narrazioni democratiche e progressiste, dalla sostanziale scomparsa delle organizzazioni intermedie”; con il risultato che “il plebeo che emerge è trasversalmente presente in ogni gruppo o classe sociale e si diffonde anche grazie alle nuove possibilità di comunicazione, e alla mancanza di sufficienti credibilità di alternative educative” (p.11).
La maleducazione, scrive Tramma, “è densa di valori “altri” rispetto all’educazione, non di disvalori, ed è con questa alterità che è necessario confrontarsi”, sapendo che l’educazione in sé “è un mero processo che genera apprendimenti riguardanti le diverse dimensioni della vita individuale e collettiva” (pp. 23-24). Naturalmente è il vivere quotidiano lo scenario in cui agisce la maleducazione (ne parlavo qui in La piccola cattiveria): le modalità dello stare con le persone, nei luoghi, tra uomini e donne, tra grandi e piccoli, il saper tenere a bada le proprie pulsioni caratteriali. E c’è anche una maleducazione “positiva”, quella della trasgressione culturale, la “maleducazione del rock” e dell’arte contemporanea, per esempio. Di sicuro il confine tra mal- e ben- educazione e sempre sfumato, vacillante, basta che ti sposti e le cose le vedi in tutt’altra maniera. Per questo, dice l’autore, “la ben educazione non si insegna […] in quanto tale, emerge, se emerge, dal lavorio critico di analisi delle norme, ricostruendone la genesi, mostrandone tutte le contraddizioni, prestando attenzione in termini di malessere/benessere e vantaggi/svantaggi per sé e per gli altri”. Piuttosto, conclude, occorre “dire e fare in modo che la ben educazione, quella vera, possa essere scelta, anche da parte di chi staziona nell’area della maleducazione, e non perché costituisce un dovere, bensì uno dei piaceri possibili delle vite normali” (p.180).
Una società “liquefatta”, si direbbe, più che liquida, in cui è sicuramente opportuno e urgente riflettere su insulti e maleducazione perché non sono un nostro lato semplicemente cialtrone, ma aspetti serissimi della nostra convivenza. Tra il tipo tutto-gentilezza-e-rispetto e il sopraffattore, c’è “il casino del mondo”, la sterminata zona grigia degli umani portatori di ogni difetto e pregio, declinati in infinite gradazioni e combinazioni. E oggi in questa zona grigia si è pressoché persa la fiducia reciproca basata sulle relazioni fondamentali di dare-ricevere-ricambiare, come ha ben mostrato l’antropologo Adriano Favole (La reciprocità è la risorsa da riscoprire, Corriere della Sera – La Lettura, 29.11.2020). Ecco perché, nell’arcipelago delle sottoculture fatto di depauperamento linguistico-lessicale, di vuoto logico-critico, se non di vera atrofia mentale (presente l’immagine dello “sciamano” Jake Angeli?), è bene non dimenticare che la chiave di tutto sta ancora prevalentemente nella gentilezza e nel rispetto umano, nel fatto che le modulazioni dell’educazione – il “processo che genera apprendimenti riguardanti le diverse dimensioni della vita individuale e collettiva” –, sono alimentate da energie affettive.
“Noi nella vita perlopiù ci sentiamo smarriti”, diceva l’avvocato Frank Galvin (Paul Newman) nell’arringa finale di Il verdetto, grande film di Sidney Lumet del 1982. Ed è una sensazione decisamente forte che tutti abbiamo in questo momento storico (e, aggiungiamo, una formidabile spinta a produrre quel salvifico “paesaggio oltre umano” che Ugo Morelli indicava qui lo scorso 9 gennaio). Da quando la creazione della rete Internet fa sì che qualunque contenuto immateriale possa circolare, nonostante il presidio dei servizi di sicurezza dei vari Paesi, anche i contenuti più scabrosi riescono a girare tra le persone. Figuriamoci gli insulti e la maleducazione: che cosa c’è di più soft tra le “armi” sociali? Sono diventate delle vere ossessioni, le manifestazioni autentiche della materialità aggressiva con cui viviamo (e mettiamoci anche il politically correct, con la sua bontà non meno violenta).
D’altro canto la sostanza delle nostre esistenze coscienti è perlopiù dedicata alla materialità, le risorse di idee tendono a piegarsi, marxianamente, alle forze dell’utile economico. Il mondo della competizione neoliberista (costruito sulle diseguaglianze e, si direbbe, per le diseguaglianze) riconosce l’individuo come unico soggetto, l’unica volontà accettata dalla macchina produttiva planetaria. Peccato che l’individuo, nel senso di persona singola, ne sia solo il destinatario commerciale, non l’artefice. Date un occhio a Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff (Luiss University Press, 2019) dove si spiega molto bene come il web si impossessa dei nostri dati e quanto le nostre menti siano per questo radicalmente cambiate. Per individuo, in economia, si intendono le company, i veri attori decisori in un mondo in cui tende a svanire una comunità di appartenenza portatrice di istanze estranee all’economia. Tutto il resto è una società “vittimaria ed emozionale”, come è stata definita, in cui l’esercizio multiforme dell’insulto e della maleducazione scorre nel delta del grande fiume capitalistico per sfociare nell’immenso mare dell’incertezza.