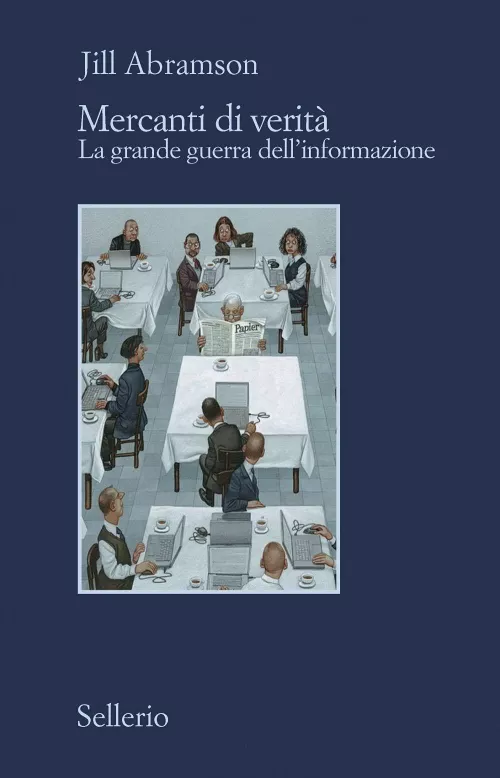Mercanti di verità
Leggere Jill Abramson è come attraversare gli ultimi vent’anni della nostra vita, almeno nel rapporto con i giornali, o meglio, con l’informazione. E c’è una data precisa che come l’anno zero segna non simbolicamente il cambiamento di fase: l’11 settembre 2001. “I giornali distribuiti quel martedì mattina – scrive Abramson – diventarono obsoleti non appena si schiantò il primo aereo e l’intera popolazione degli Stati Uniti si trovò a dipendere dalle trasmissioni televisive e dalle notizie online”. Ognuno ha il suo ricordo, di quei momenti. Io ero alla Fnac di place d’Italie a Parigi, stavo comprando un televisore per l’ufficio di corrispondenza di La Stampa. Ero di fronte a un’intera parete di schermi accesi, ognuno collegato con una diversa emittente dal mondo. E su quella parete, nel giro di pochi minuti, attraversata da un unico impulso, proveniente da un unico punto del pianeta, come in un domino elettronico, gli schermi si sono messi a lampeggiare a catena riproducendo infinite volte lo schianto sulle Twin Towers.
L’istinto mi diceva di correre al giornale e far la mia parte nel racconto di quella giornata. Ma di fronte a quelle immagini, alla storia, alla vita, alla morte qual era esattamente la mia parte? Tutto si stava consumando su quegli schermi che in quello stesso momento centinaia di milioni di persone stavano guardando come me nelle case, negli uffici, nei bar, nei negozi di apparecchi televisivi, di giorno o di notte in ogni parte del pianeta. Il web registrò un record assoluto di consultazioni, molti siti andarono in tilt. Da quel momento e per i mesi successivi il New York Times dispiegò sul terreno il massimo delle forze giornalistiche. Uno stuolo di cronisti e di analisti che con i loro servizi in un solo anno conquistarono il record di ben sette premi Pulitzer, il massimo riconoscimento giornalistico del mondo. E l’editore Sulzberger, per quanto il giornale fosse da tempo in crisi sotto l’incalzare di Internet e la redazione avesse già subito pesanti tagli, decise comunque di aggiungere un dorso quotidiano, “A Nation challenged” (una nazione sotto attacco), senza un briciolo di pubblicità, per alimentare con storie e analisi il racconto di quella che sembrava a tutti la notizia del secolo. Ma intanto tutto stava cambiando.
Jill Abramson, 67 anni, oggi insegna giornalismo alla Harvard University ed è editorialista del Guardian; ha lavorato al Wall Street Journal e al New York Times, di cui è stata – prima donna – direttrice esecutiva (executive editor) tra il 2011 e il 2014. Da allora ha lavorato a un libro che si può leggere come un saggio sulla rivoluzione nell’informazione, ma che è soprattutto un reportage molto personale dentro la macchina del giornalismo americano. È uscito due anni fa negli Stati Uniti con il titolo Merchants of truth suscitando varie polemiche. Abramson era stata licenziata dal NYT, accusata dalla redazione per l’eccessiva durezza e dalla proprietà per l’incapacità di convivere con la necessità di trovare nuove fonti di ricavo. Il libro è uscito ora in Italia per l’editore Sellerio tradotto da Andrea Grechi e Chiara Rizzuto con lo stesso titolo americano Mercanti di verità. Sottotitolo: “la grande guerra dell’informazione”. Una lettura avvincente di quasi 900 pagine attraverso questi anni nei due storici quotidiani, NYT e Washington Post, e nei due media più emblematici della rivoluzione digitale, Buzz Feed e Vice.
Ma torniamo a quell’11 settembre perché è quel giorno che cambia il paradigma. Il “vero vincitore” di quella battaglia di informazioni – scrive Abramson – fu Google dove un ricercatore trentunenne di origini indiane, Krishna Bharat, cominciò a mettere a fuoco un nuovo servizio che si sarebbe chiamato Google News a partire dai milioni di domande che il pubblico stava rovesciando sul portale di ricerca. Bharat mise a punto un algoritmo che gli permetteva di estrarre notizie e storie da migliaia di testate in tutto il mondo visualizzandole sulla sua pagina che veniva aggiornata ogni 15 minuti. Un furto? Sì e no, perché in realtà metteva a disposizione e in ordine informazioni di cui non solo si citava la fonte ma delle quali veniva fornito anche il link per accedere ai siti dei media che avevano prodotto quelle informazioni. E va ricordato che allora i giornali usavano banalmente internet mettendo in rete gratuitamente i contenuti pubblicati sulla carta, considerando questa – e ancora per molti anni a venire – il più vero e autorevole supporto all’informazione. Ne nasceva una controversia tuttora in atto tra Google e gli editori che tuttavia ricevevano da quel “furto” anche il beneficio di accessi ai loro siti. Da un atto di pirateria, stava nascendo un modello di business che però andava principalmente a vantaggio di Google.
Ma il fenomeno che avrebbe cambiato il rapporto delle persone con l’informazione fu il fatto che il pubblico stava prendendo confidenza con Internet e scoprendo che la rete gli permetteva di socializzare. Un geniale avventuriero dell’informazione, Jonah Peretti, intuì che i contenuti sarebbero diventati una forma di conversazione, ma perché questo avvenisse, i media dovevano diventare “contagiosi”, rappresentando news e idee nella forma più semplice, se possibile con una sola frase da afferrare e da cliccare in 10 secondi, non si poteva chiedere di più all’attenzione del sistema nervoso degli esseri umani contemporanei. La chiave di volta era cedere la scelta dei contenuti e la loro diffusione al pubblico stesso: la domanda produceva l’offerta. Era il rovesciamento del ruolo e della funzione del giornalismo com’era stata storicamente intesa: dare notizie e interpretarle. In questa tempesta di segnali si affermava il modello di Peretti secondo cui l’informazione per essere riconosciuta, doveva acquisire le caratteristiche di un “oppiaceo”, il medium doveva diventare “appiccicoso”, innescando una reazione a catena tra i lettori, un fenomeno simile alla ripetitività dei friniti dei grilli nei campi (Peretti era rimasto folgorato dalla lettura del saggio di un entomologo), l’obbiettivo era quello che ogni titolo potesse innescare un processo virale. Ne nacque il sito Buzz Feed con il quale Peretti “contagiò” l’Huffinghton Post.
Contemporaneamente ad Harvard Mark Zuckerberg stava lanciando The-Facebook.com tra i suoi compagni di studi e poco dopo tra tutti gli studenti universitari. Attraverso la funzionalità “News Feed” il nuovo sito consentiva agli utenti di leggere e condividere contenuti scelti dagli amici, non da un editore (come nel caso di un giornale tradizionale) o da un robot algoritmico (come nel caso di Google). E intanto anche Twitter si stava affermando con principi simili (a parte l’emblematico limite di 140 caratteri nelle conversazioni) e trasformandosi in una rassegna stampa globale composta sulle preferenze delle persone che ciascuno aveva scelto di “followare” o di “cuorare”, mettendo un cuore ai tweet.
“Ma – scrive Abramson – il dispositivo che cambiò per sempre il modo in cui si svolgevano quegli eventi e quelle conversazioni venne lanciato il 9 gennaio 2007: l’iPhone”. Magico e rivoluzionario, quel computer tascabile, in anticipo di almeno cinque anni rispetto a qualsiasi altro telefono fino allora progettato, soddisfaceva “una brama smodata di informazione e di svago per la Rete degli Annoiati dal lavoro, come la chiamava Peretti”. Ed è il paradigma che – varianti tecnologiche a parte – si è affermato e tuttora funziona ogni volta che prendiamo in mano il nostro smartphone.
Il grande paradosso di questo fenomeno era che i protagonisti non erano produttori di contenuti originali, ma semplicemente aggregatori dei contenuti prodotti dai vecchi giornali. I quali si trovavano al tempo stesso svuotati e delegittimati, non più fonti primarie ma fonti derivate, non più riconosciuti come istituzione.

La situazione richiedeva un salto di dimensione e di visione che nessuno fu davvero in grado di fare. I vecchi e storici giornali “avrebbero dovuto pensare l’impensabile”, come scrisse allora in un saggio di riferimento Clay Shirky, docente di giornalismo alla New York University (Newspapers and Thinking the Unthinkable) dove l’impensabile era proiettarsi in un futuro prossimo in cui non sarebbe più esistita l’edizione di carta stampata. Shirky, che Abramson cita ampiamente, considerava la nascita di Internet “un’entusiasmante e profonda rivoluzione che come l’introduzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg cinque secoli prima rendeva più democratico il flusso dell’informazione”. I siti internet dei giornali erano invece la riproduzione elettronica delle loro edizioni di carta, nessuno fu capace di progettarli come entità digitali. E nemmeno il modello di business venne adeguato alla nuova realtà nonostante che in un certo momento le traiettorie di Google e di Facebook si siano incrociate a quelle del NYT e del Washington Post, ma né l’uno né l’altro seppero concludere un’alleanza che avrebbe probabilmente cambiato la loro storia.
Nei suoi anni al Times, caporedattrice, responsabile della redazione di Washington e infine direttrice (dopo il 2011) il giornale ha vinto ben 24 Pulitzer che lei si appunta come medaglie. Nel 2014 Jill Abramson è stata licenziata con modalità brutali (ma questo è abbastanza frequente nei giornali, anche da noi). Arthur jr. Sulzberger, erede della storica famiglia proprietaria del Times, si giustificò accusandola di aver negoziato l’assunzione di Janine Gibson, social media editor del Guardian, senza avvisarlo. Ma le ragioni erano molteplici, non solo caratteriali. Jill lo spiega così: “Non ero disposta a sacrificare i miei punti fermi etici per esigenze commerciali, non pensavo che il cambiamento tecnologico dovesse comportare un cambiamento di valori. Forse per salvare il Times i vecchi vincoli dovevano essere allentati”. Troppo “pushy”, aggressiva, la direttrice che nel libro racconta anche i suoi terapeutici allenamenti settimanali in una palestra di boxe. Il mattino dopo il suo licenziamento si fece fotografare dalla figlia mentre prendeva a pugni i guantoni del suo personal trainer. La foto venne pubblicata su Instagram e divenne virale: Jill-Pushy simbolo della riscossa per ogni donna licenziata.
Ma al di là dell’aneddotica il senso dello scontro e dello strappo era chiaro. Il mondo di riferimento di Jill Abramson era quello in cui un direttore del NYT come Joe Lelyveld protestava semplicemente perché il capo della divisione pubblicitaria aveva attraversato la redazione per andare a trovarlo, come se fosse un gesto sacrilego, un’intollerabile confusione tra il sacro mandato costituzionale della libertà di stampa e le contingenti necessità venali dell’azienda. E si racconta che un altro storico direttore del Washington Post, Leonard Downie, avesse l’abitudine di abbandonare le riunioni quando si affrontavano le questioni commerciali. La transizione tecnologica e la crisi del 2008 avevano demolito l’immagine istituzionale del giornale, messo in crisi i fondamenti della loro affidabilità e oltretutto li avevano privati della principale fonte di risorse, la pubblicità che per oltre il 70 per cento si era riversata su Facebook e Google, grazie ai loro sistemi di raccolta automatizzati.
Inoltre lo smantellamento dell’informazione locale era stato uno degli sviluppi più devastanti dell’era internet. Un quotidiano come il Denver Post con 125 anni di storia e nove Pulitzer in archivio venne acquisito insieme ad altri da un fondo investimenti la cui principale preoccupazione è stata quella di tagliare i costi. Tra il 2009 e il 2015 più di un terzo dei giornalisti dei quotidiani disseminati negli States è stato licenziato. L’effetto negativo sulla fisiologia del sistema democratico però va ben oltre perché, come ha scritto il direttore del Denver Post Chuck Plunkett nel suo editoriale di commiato, “i giornali locali assomigliano ormai a inserti pubblicitari, inframezzati da contenuti provenienti da altre fonti”. I redattori sopravvissuti alle stragi di posti di lavoro sono diventati a loro volta aggregatori di aggregati, le “sezioni investigative” (fiore all’occhiello del giornalismo americano) ridotte all’osso o addirittura azzerate, capiredattori licenziati per aver promosso inchieste scomode e così via. La “Trump nation” nasce anche da questo fenomeno.
Nel racconto di Jill Abramson della sua avventura al NYT si intreccia anche la parabola dell’altro grande quotidiano americano, il Washington Post, fino ad allora legato allo scoop simbolo della sua storia, il Watergate e la sua popolarizzazione dovuta alla versione Hollywoodiana di Tutti gli uomini del presidente nell’interpretazione di Dustin Hoffmann e Robert Redford nei panni dei due reporter Carl Bernstein e Bob Woodward. Fino al 2013 negli uffici del giornale campeggiava ovunque la riproduzione della storica prima pagina di quarant’anni prima che annunciava le dimissioni di Nixon in seguito all’inchiesta del quotidiano. Ma in quell’anno il vecchio editore Donald Graham vendette il giornale al patron di Amazon Jeff Bezos, e all’ingresso della redazione fu affisso il mantra del nuovo corso: “L’unico pericolo è non evolversi”. E ovunque sulle pareti, come in un negozio tv della Fnac apparvero monitor a schermo piatto che però visualizzavano in tempo reale le statistiche di quanti lettori stavano guardando ciascun articolo.
Peraltro Jill Abramson non risparmia ironia al monumentale Woodward, ricordandogli la figuraccia fatta al Larry King Live quando alla vigilia dell’attacco all’Iraq si disse certo che le famose armi di distruzione di massa di Saddam sarebbero state sicuramente scoperte. Ma proprio su quella guerra neppure i super reporter del NYT furono capaci di alzare il minimo dubbio. Ed è una défaillance che pesa nella storia recente dei due grandi giornali quasi quanto il non aver capito e anticipato il fenomeno Trump che con i suoi tweet ha “presidenzializzato” le fakenews in un’opera sistematica di delegittimazione dei grandi quotidiani e dei loro giornalisti universalmente accusati di essere “nemici del popolo”. Il NYT ne ha enormemente beneficiato per reazione diventando il rifugio per i lettori democratici rispetto all’incontenibile ondata populista che sgorgava a ogni ora dalla Casa Bianca.
Pochi giorni fa l’editore ha trionfalmente annunciato di aver raggiunto un milione di abbonamenti digitali fuori dagli Stati Uniti.
Ma non per tutti è stato così, tutt’altro, e la vera questione di fondo per nuovi e vecchi media è la credibilità che un tempo veniva automaticamente affidata alla testata e che oggi si deve conquistare giorno per giorno. Fiducia e autorevolezza restano gli obbiettivi pur sapendo che il successo di una piattaforma dipende dai click e da un flusso di gradimento che viene orientato ora per ora da ingegneri del web. Come per il modo in cui si è vissuto l’11 settembre, ognuno darà la sua risposta, niente è scontato, la varietà e la ricchezza del web non permettono più di classificare buoni e cattivi, l’ultimo Pulitzer l’hanno vinto i nuovi barbari di Buzz Feed con un’inchiesta sulla repressione dei musulmani nella regione cinese dello Xinijang. La reporter Meghan Rajagopalan, 29 anni, di origine indiana, è stata la prima a entrare in un campo di detenzione degli Uiguri, come avrebbe fatto il migliore inviato del NYT, adempiendo così al più elementare principio editoriale: raccontare bene una storia vera. Cosa si può chiedere di più a un giornalista?