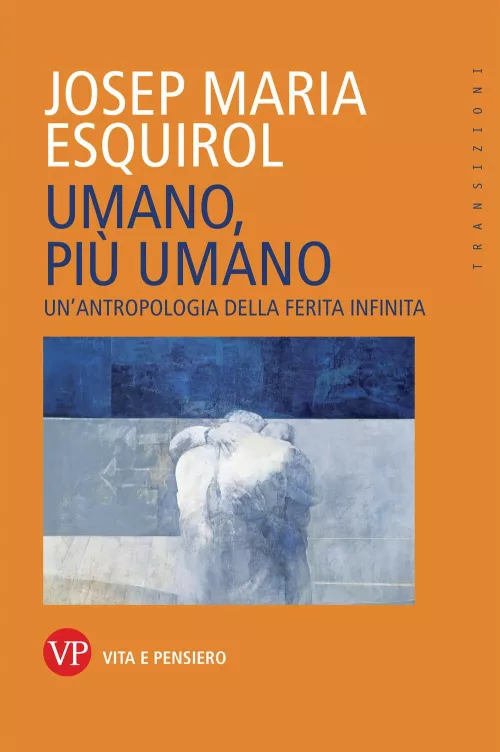Sentire-pensare la ferita
Come a volte capita alcuni piccoli libri sono grandi libri. Questo di Josep Maria Esquirol è un grande libro nella sua scelta di concisione: un andamento aforistico che non si disperde, anzi svela di pagina in pagina un argomentare strutturato, alla fine stringente, dove il sentire non offusca il pensare e il pensare non ottunde il sentire. Già il titolo annuncia con precisione una scelta di campo: Umano, più umano. Un’antropologia della ferita infinita (Vita e Pensiero, Milano 2021). L’umano non è troppo, anzi è troppo poco: le vie di fuga superomistiche non sono un’opzione convincente, il nietzscheanesimo a poco prezzo, trasformato in enfasi letteraria senza la tragedia esistenziale del suo autore, e senza le implicazioni di un modo di vivere che lo voglia prendere sul serio, sono lo sfondo dal quale si differenzia con nettezza questa linea antropologica alternativa.
È come se l’autore applicasse alla scrittura quel che dice della vita, del gusto e del sapore della vita, del buon sapore del sentirsi in vita, del sentirsi vivo (p. 72). Dice di essere “d’accordo con la saggezza popolare: ‘bisogna essere felici con poco’. Ebbene, sono d’accordo purché questo poco si accentui e venga interpretato in modo consono. Bisogna essere precisi e capire che, in realtà, questo poco è molto. È un poco che non significa quasi-nulla, bensì l’essenziale. Il contrario di questo poco è il troppo, che più che riempire la vita, la satura, la appesantisce.” Sembra di sentire Epicuro quando diceva che “nulla basta a colui al quale pare poco ciò che basta” (Sentenze Vaticane n. 62). Ora Epicuro non è certo uno degli autori presi in considerazione in questo libro, ma l’antropologia filosofica di Esquirol (p. 14) ha certamente a che fare con la filosofia come modo di vivere, con la vita filosofica. Parlando di Foucault e del suo paragone tra francescanesimo e movimento dei filosofi cinici, Esquirol dice un tratto decisivo della sua opera: “Per loro [per i cinici] filosofia e vita erano la stessa cosa”.
Poiché le opere di Foucault che riguardano la filosofia antica dipendono in gran parte, come lui stesso riconosce, dalle ricerche di Pierre Hadot, possiamo dire che l’antropologia filosofica di Esquirol è ispirata da questa stessa tensione: filosofia come modo di vivere, vita come sentire che si “piega”, si riflette in sé stesso. Potremmo quindi dire: sentire che si sente. “L’abbraccio della vita è lo stesso ripiegamento del sentire: è l’abbraccio che includerà tutte le cose della vita: io con il mosaico delle relazioni della situazione fondamentale”.
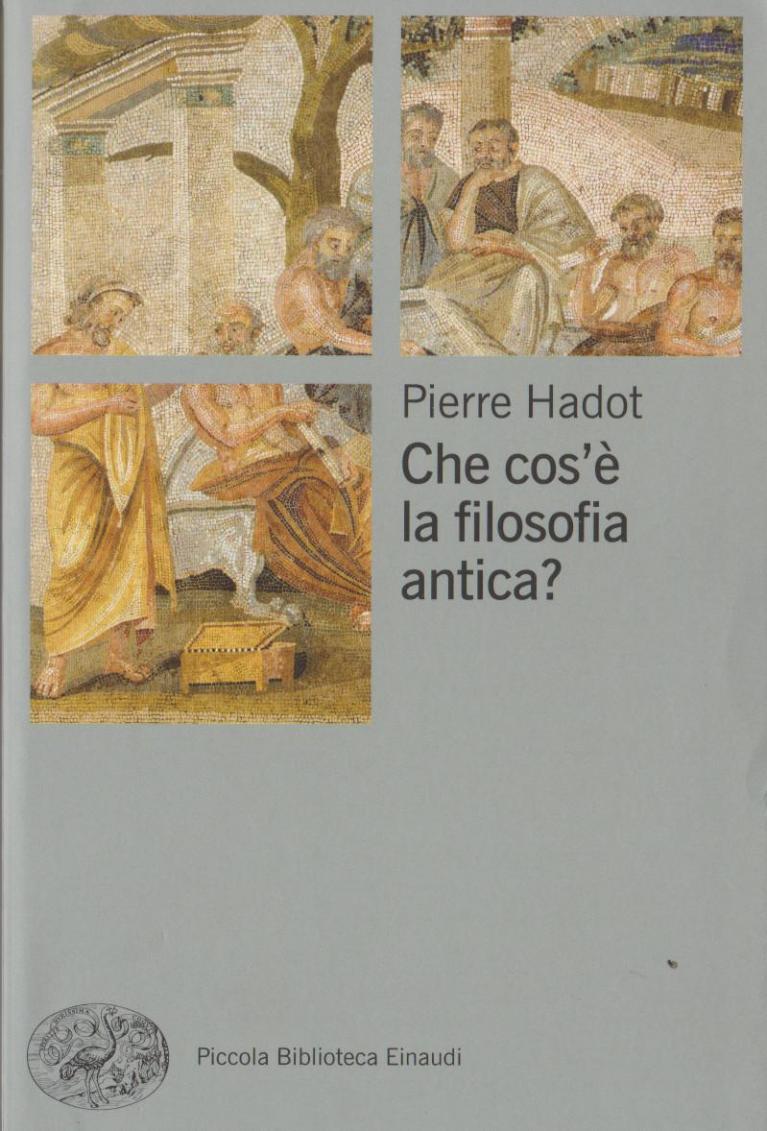
Anche qui qualcosa risuona con un passo di Aristotele “sentire che si vive è un piacere” (Etica Nicomachea, 9.1170b1). Ma vivere, commenta Hadot “è precisamente sentire. Bisognerebbe quindi dire ‘sentire che si sente è un piacere’”. E continua: “C’è, per Epicuro, una sorta di presa di coscienza dell’essere sensibile riguardo a sé stesso. Si tratta, per l’appunto, del piacere filosofico, il puro piacere di esistere” (P. Hadot, Che cosa è la filosofia antica? (1998), Einaudi, Torino, 2010, p. 188).
Ma questo che Esquirol chiama “gusto e godimento della vita” è ciò rispetto al quale si definisce ogni sofferenza: “è la prima figura della ferita infinita”, il ripiegamento-abbraccio che “vibra e fa vibrare quanto è alla sua portata” (p. 72).
Questa è la prima delle quattro ferite-affezioni infinite (pp. 66-7): l’abbraccio della vita nel gusto di vivere, lo sfioramento della morte; l’amore come presente del tu e l’adombramento del mistero del mondo. “È a partire dal gusto e dal godimento della vita che si definisce ogni sofferenza […] La morte e la paura della morte si proiettano nel gusto di vivere e definiscono una delle più emblematiche tensioni drammatiche. Se l’incidenza è troppo forte, allora quasi non si vive. Tuttavia, se qualcuno vuole allontanarsi da tale tensione, finge che non vi sia, allora la vita diventa una caricatura, e se ne perdono aspetti preziosi. Imparare a vivere è perciò imparare a morire e al contrario” (p. 82). Anche qui l’eco dell’esercizio spirituale della morte e del tempo presente è evidente. Un esercizio peraltro caratterizzante, oltre che della filosofia antica greco-romana, anche di molte altre tradizioni sapienziali e religiose.
Nel testo di Esquirol è sempre sottolineato il nesso intimissimo con la dimensione biografica che, se fosse priva del sentire-pensare la ferita infinita, scivolerebbe pericolosamente verso un ottundimento dello stesso sentire di sentire, del sentirsi vivere. “Nel taglio a forma di croce della ferita infinita, si incide sempre il canovaccio singolarissimo di ciascuna vita umana”. La drammatica della ferita nella prospettiva temporale è una “biografia con singolari sequenze di esasperazioni […] è la drammatica della vita” (p. 83). E qui Esquirol, di nuovo, segna la sua vicinanza con la filosofia antica seguendo il nesso tra ferita e cura. La cura è l’accompagnamento necessario, ciò che la ferita evoca e richiede. Una cura che attraversa e scompagina ogni partizione disciplinare e professionale. Il tipo di terapeutica che, di nuovo con Pierre Hadot, chiamerei “filosofica” o “spirituale” (intendendo con “spirito” il nesso sempre elusivo che allude all’uno del corpo-anima-mondo).
Una parola metafora-concetto che tesse in ordito e trama l’intero libro è quella di orientamento-senso (pp.168 e seguenti), avvicinata alla parola “trascendenza”.
Ma non si può non nominare il confronto che dal titolo all’ultimo capitolo pervade il testo: il dialogo con Nietzsche e con il suo messaggio di oltrepassamento superumano dell’umano (pp. 11-12). Non a caso il frammento 125 di La gaia scienza che annuncia la morte di Dio è l’annuncio del più rabbrividente disorientamento, del fondersi e confondersi e rovesciarsi della notte e del giorno, del basso e dell’alto, del precipizio senza fondo e dello sfondo: il non-senso, il caos è la nuova mappa, stracciata in infinitesimali frammenti, del senso smarrito. Zarathustra evocherà la nascita di una stella danzante da questa esplosione del “cosmo” (dell’ordine ammirevole) annientato insieme al Dio morto. Una stella danzante che non sembra essere ancora nata.
Qui Esquirol evoca, già dalla forma di croce della ferita infinita, figure del racconto cristiano (pp. 77, 85, 126, 174,177) per salvare il senso. Giovanni della Croce e la sua mistica poetica ne portano testimonianza, ma la figura per eccellenza della proposta di vita orientata a un poco – infinito – “più di senso” è quella del diventare “minimi”, essere sempre “sorelle e fratelli minori” degli altri e del cosmo, espressa nella vita di Francesco d’Assisi (pp. 97, 119-123).