Sulla fine dell’estetica / Conversazioni con Arthur C. Danto. Che cos’è un’opera d’arte?
Gli interrogativi sullo statuto dell’opera d’arte che la riflessione di Arthur C. Danto solleva potrebbero coinvolgere tutta la storia dell’estetica, pur nascendo da un singolare e fortunato incontro avvenuto a Manhattan nel 1964. È qui che, nei locali della Stable Gallery, veniva esposta per la prima volta Brillo Box, l’opera iconica di Andy Warhol, una delle più note dell’artista americano e fenomeno inaugurale di un nuovo modo di pensare l’arte. Da questa novità, incarnata da banali scatole di detersivo esposte in una galleria, trasfigurate in opere d’arte, prende avvio la filosofia dell’arte di Danto, che ruota, com’è noto, attorno a una domanda chiave: che cos’è un’opera d’arte? O meglio, che cosa rende un’opera d’arte tale, quando dal punto di vista estetico e percettivo nessuna differenza sostanziale permette di distinguerla da un altro oggetto banale, di uso quotidiano? E quindi che cosa differenzia, non da un punto di vista estetico, bensì essenziale, ontologico, le comuni scatole di detersivo Brillo (seppur disegnate, com’è noto, dall’artista James Harvey) vendute nei supermercati americani, dalle Brillo di Warhol, trattandosi in apparenza di oggetti indiscernibili?
Se è vero che la filosofia è fatta di domande ben poste, è subito chiaro che quella di Danto, occasionata dall’incontro con l’opera di Warhol, nasconde dietro la sua semplicità una complessa valenza filosofica: la riposta è tutt’altro che scontata, come testimoniano i dibattiti attorno alla sua teoria; la problematica che essa solleva lungi dall’essere evasa. Davanti all’opera di Warhol, davanti a un ready-made duchampiano, in una sala qualunque di un qualunque museo di arte contemporanea non è poi così insolito che qualcuno si chieda “perché questa cosa qui è un’opera d’arte”? Accanto a questo interrogativo, più specifico e più noto, ne emerge un secondo che, come si accennava all’inizio, riguarda più in generale la storia dell’estetica e del rapporto che la filosofia può intrattenere con l’arte. Qual è dunque questo rapporto e che cosa differenzia l’estetica come disciplina filosofica da una filosofia dell’arte, che Danto dice di voler praticare a scapito appunto della prima, seguendo una traiettoria che da Hegel lo porta fin dentro il dibattito analitico contemporaneo sull’essenza dell’opera d’arte?
Se le opere d’arte sono per Danto sempre a proposito di qualcosa (aboutness), se esse sono significati incarnati (embodied meanings), per identificarle e definirle non occorre, secondo il filosofo americano, ricorrere all’estetica e ai suoi classici canoni, primo tra tutti la bellezza, o almeno non più: nel caso emblematico delle Brillo, per esempio, nessuna qualità esteriore le definisce in quanto opere, ma è solo una catena di rimandi tra significato e interpretazione che ne sancisce l’ingresso nel “mondo dell’arte”. Quest’ultimo è un aspetto della particolare torsione che Danto fa subire all’idea di matrice hegeliana di fine dell’arte (sebbene nelle sue lezioni di Estetica Hegel parli più di bella arte come qualcosa di passato, piuttosto che di morto o di finito): essendosi la pratica artistica affrancata da ogni ricerca estetica attorno alla bellezza, se nulla di bello potrà ancora esistere, che ne è dell’opera d’arte oggi? Se l’arte non basta più a se stessa, se essa ha bisogno di molto pensiero per essere compresa e definita, qual è il rapporto che con essa può avere la filosofia?

Andy Warhol, Brillo Box, 1964 acrilico su legno, 33 Å~ 40,7 Å~ 9,2 cm ˝ Andy Warhol Foundation, SIAE 2020 Collezione privata.
Questi temi, filosoficamente densi, sono tutti diffusamente affrontati nei dialoghi e nelle interviste che Demetrio Paparoni, storico dell’arte e critico, fondatore della rivista Tema Celeste, ha intrattenuto con Danto nel corso di diversi anni, prima di pubblicarle nel volume Arte e Poststoria. Conversazioni sulla fine dell’estetica e altro (Neri Pozza, 2020). Scambi a due o tre voci (in due delle quattro conversazioni presentate sono coinvolti anche l’artista Mimmo Paladino e il filosofo Mario Perniola), che permettono di gettare ancora uno sguardo sugli ultimi sessant’anni della produzione artistica contemporanea, attraverso il sodalizio intellettuale e l’amicizia che legava Paparoni al filosofo statunitense. Della filosofia e della postura critica di Danto, Paparoni fornisce un accessibile e sintetico resoconto nel saggio di apertura (“Nella stanza di Judy”), avendo cura di mettere in prospettiva l’apporto del filosofo statunitense rispetto alla sua postura di critico d’arte e illuminando, col potere rivelatore della “presa diretta”, importanti nodi concettuali del pensiero di Danto. Le tappe comuni di un percorso tutto interno al mondo dell’arte contemporanea (condiviso con altri intellettuali, critici e artisti, come Sean Scully, amico comune) vivificano, infatti, le conversazioni contenute nel volume, un lungo e ininterrotto dialogo cui il lettore è di volta in volta invitato a prendere parte, pur beneficiando dello statuto dell’osservatore esterno, o di chi sbircia dal buco della serratura: come quando Paparoni racconta che Danto e la moglie Barbara Westman possedevano in casa una Brillo Box, “la versione su fondo bianco, la più nota […] La tenevano nella stanza in cui ricevevano gli amici nell’appartamento dell’Upper West Side, davanti al fiume Hudson”. Tuttavia, continua Papaproni, “non si trattava di una Brillo Box di Warhol, ma di un rifacimento di Bidlo (Brillo Soap Pads Box/Pasadena Version, 1969, data di esecuzione 1991)”. Quest’aneddoto è quanto mai significativo per tematizzare due punti chiave del pensiero di Danto, che il volume curato da Paparoni solleva, quello di post-storia e quello di fine dell’estetica.
Attraverso lo sviluppo intrinseco dell’arte – afferma Danto in una delle conversazioni – è emersa la vera forma della questione filosofica riguardante la natura dell’arte, vale a dire: perché un oggetto (per esempio la Brillo Box) è un’opera d’arte, mentre un altro oggetto assolutamente identico al primo dal punto di vista percettivo (per esempio una scatola di Brillo) non lo è? Pensavo che ciò riguardasse solo il caso di Warhol, ma la medesima questione si è sollevata lungo tutto il fronte dell’arte più o meno nello stesso momento (1965). Preferirei quindi dire che, a un dato momento, l’arte in quanto sforzo collettivo, attraverso il suo sviluppo interno, portò a coscienza la propria questione filosofica. (p. 61)
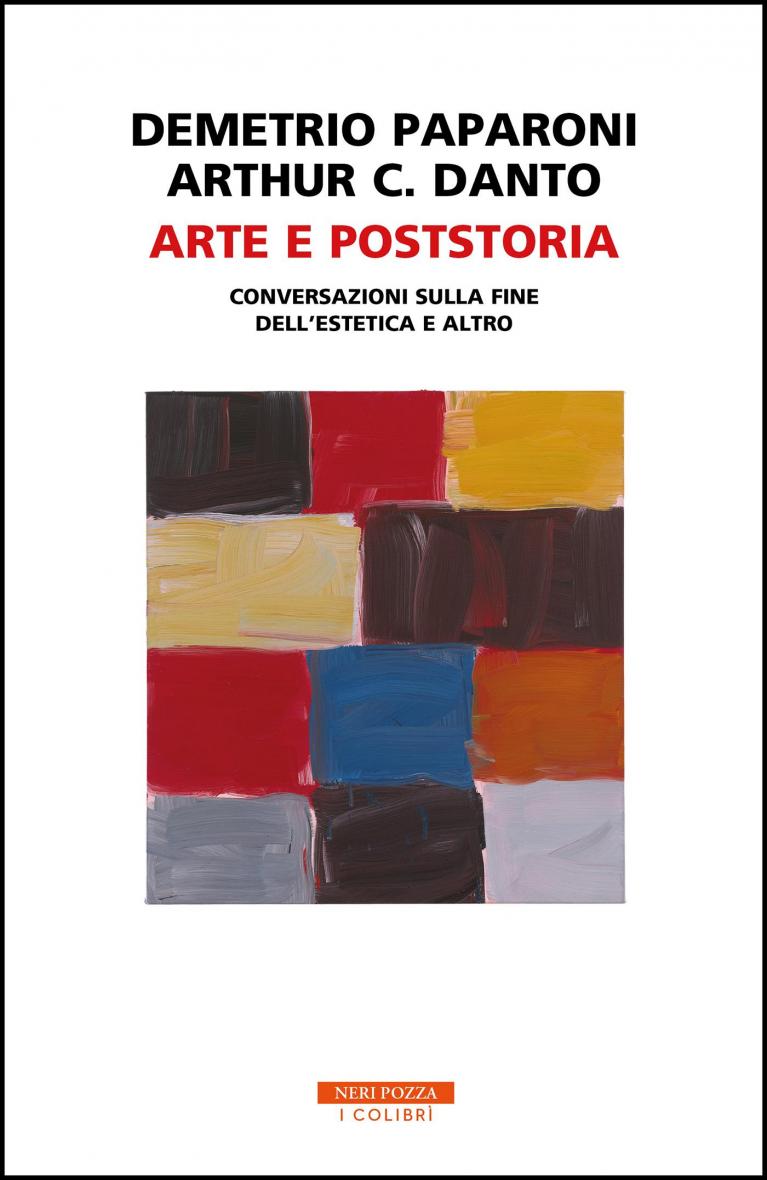
Se la storia dell’arte, intesa come progressione lineare, culmina con la rottura provocata dalle Brillo di Warhol, se è Warhol, più di Duchamp, a sancire il carattere di passato dell’arte (la differenza è da ritrovarsi, per Danto, nel diverso scarto che i due artisti producono tra l’oggetto e l’opera d’arte), a decretare la fine dell’estetica e l’inapplicabilità dei suoi concetti; se, quindi, la storia dell’arte come ricerca formale della compiuta bellezza dell’opera finisce, quali scenari si profilano, che cosa diventa l’opera d’arte?
Una volta terminata la narrazione, non esiste più una direzione storica privilegiata. Ciò corrisponde all’estremo pluralismo tipico della fase poststorica dell’arte. A tale livello di separatezza, può esistere qualcosa che equivalga a uno stile? Credo che questa sia veramente una domanda difficile; basti pensare ai problemi sollevati dall’arte dell’appropriazione. Credo che questa sia veramente una domanda difficile; basti pensare ai problemi sollevati dall’arte dell’appropriazione. Pensiamo a Mike Bidlo o a Sherrie Levine: ogni stile è a disposizione degli artisti nel momento in cui essi decidono di avvalersene. (p. 62)
L’opera d’arte diventa allora un “oggetto non stabile”, come suggerisce Perniola nella conversazione cui prende parte (p.67), plurale da un punto di vista stilistico ma anche temporale, storico: la fine dell’arte non coincide affatto con la sua morte o la sua scomparsa, ma con una trasformazione, un’apertura. Paparoni ricorda, a tal proposito, un’altra opera che ha nutrito la riflessione di Danto, il video Judy’s Bedroom (1994), di David Reed, che dà il titolo al suo saggio. L’opera di Reed è una manipolazione digitale della scena del film di Hitchcock, Vertigo (1958), in cui Judy è nella sua stanza da letto, alle sue spalle è ben visibile un quadro, una natura morta. Reed sostituisce il quadro presente nella scena originaria con un suo dipinto astratto, realizzato nel 1990, creando così, dice Danto, una “impossibilità storica”: mentre una natura morta, indeterminata nello stile e nell’epoca non suscita alcun problema, un dipinto astratto degli anni ’90 non potrebbe mai essere davvero presente nella scena del film.

David Reed, Judy’s Bedroom, 1992 Installation view at Museum für Moderne Kunst, Frankfurt. In the permanent collection of Museum für Moderne Kunst, Frankfurt. ˝ David Reed. Courtesy dell’artista.
Il video di Reed, rileva Paparoni, mostra dunque un tempo storico ibrido, figlio di due momenti temporali diversi e distanti, incompatibili in una visione lineare e progressiva del tempo (p. 31), ma compatibili con la teoria di Danto secondo cui essenzialismo – ovvero la necessità propria di una filosofia analitica di trovare una definizione universalmente valida di opera d’arte – e storicismo, ovvero la presa in carico della storicità delle opere d’arte, intesa come possibilità storica della loro esistenza, non sarebbero tra loro in contraddizione : è proprio il fatto che ci sia, credo, un’essenza dell’arte – afferma Danto in un altro suo testo – che rende possibile il pluralismo artistico. Se, in tal senso, ci riferiamo a un altro momento cruciale dell’arte contemporanea spesso citato da Danto, l’affermazione dell’Appropriation Art – tornando quindi alle Brillo di Bidlo che il filosofo possedeva in casa, o pensando ad altre opere spesso citate, anche in queste conversazioni, come le fotografie di Sherrie Levine – vediamo come si produca uno scarto rispetto alla domanda iniziale, un salto che però ne è una diretta conseguenza. Se la differenza tra un banale oggetto e un’opera in apparenza indiscernibile risiede nella capacità di quest’ultima di incarnare un significato e quindi di richiedere interpretazioni, storiche e filosofiche, che cosa differenzia invece altre opere, per esempio quelle appropriazioniste, dalle semplici copie, che cosa conferisce loro lo statuto di opera d’arte originale? La copia della copia, per scimmiottare il gergo platonico, diventa opera d’arte nel momento in cui si fa carico di esigenze storicamente determinate e suggerisce nuove domande sullo statuto dell’opera, forzandone i limiti. Pur essendo simile o identica a un’opera del passato, dice Paparoni, “essa esprimerà comunque il suo momento storico grazie al suo significato incarnato, grazie al fatto cioè che essa porta con sé le motivazioni che hanno spinto l’artista ad appropriarsi di un’opera realizzata in precedenza da altri, con la differenza che non sarà il suo valore visivo a definirne il significato ma le motivazioni filosofiche che porta con sé.” (p. 32). Ecco quindi uno dei punti più interessanti che queste conversazioni permettono di sollevare: non tanto una riflessione sull’essenza dell’opera d’arte, quanto piuttosto un’interrogazione sulla sua storicità e sul rapporto che essa può stabilire con la storia (dell’arte), con il proprio tempo e col concetto stesso di tempo. Questo è forse il lascito più interessante della filosofia dell’arte hegeliana, che la filosofia dell’arte di Danto ci permette di raccogliere.







