Speciale
Sciascia Trenta / Gli zii di Sicilia
Sono trascorsi 30 anni da quel giorno di novembre in cui Leonardo Sciascia ci ha lasciati, trent'anni in cui il paese, che lui ha così bene descritto, è profondamente cambiato, eppure nel profondo è sempre lo stesso: conformismo, mafie, divisione tra Nord e Sud, arroganza del potere, l'eterno fascismo italiano. Possibile? Per ricordare Sciascia abbiamo pensato di farlo raccontare da uno dei suoi amici, il fotografo Ferdinando Scianna, con le sue immagini e le sue parole, e di rivisitare i suoi libri con l'aiuto dei collaboratori di doppiozero, libri che continuano a essere letti, che tuttavia ancora molti non conoscono, libri che raccontano il nostro paese e la sua storia. Una scoperta per chi non li ha ancora letti e una riscoperta e un suggerimento a rileggerli per chi lo ha già fatto. La letteratura come fonte di conoscenza del mondo intorno a noi e di noi stessi. De te fabula narratur.
Ci sono vari motivi per riprendere in mano Gli zii di Sicilia, tutti eminentemente semiotici. Si tratta di una raccolta di racconti pubblicata nel 1958, relativa, quindi, alla primissima fase della produzione dello grande scrittore di Racalmuto. Il testo può addirittura essere annoverato come un esordio se lo si considera dal punto di vista del suo genere d’appartenenza – la narrazione di fiction – così fecondo nell’attività del suo autore.
Una prima questione problematica riguarda già il suo titolo. A voler essere precisi, l’unico racconto dei quattro – La zia d’America, La morte di Stalin, Il quarantotto, L’antimonio – che compongono la raccolta a trattare di zii è il primo. Rimane, quindi, da chiarire chi siano davvero gli zii di Sicilia evocati nel titolo e, fuor di metafora, quale possa essere il filo conduttore che lega questi racconti.
Una prima risposta può essere avanzata rilevando come i quattro testi siano accomunati dal fatto di essere racconti politici. Ognuno di essi evoca la grande storia, ne richiama il suo passo inesorabile oltre ogni possibile resistenza, pone il problema del cambiamento epocale.
Già questo gesto, è indicativo di una peculiarità della scrittura di Sciascia rispetto allo stereotipo dell’irredimibilità siciliana. In Gli zii di Sicilia non c’è lo strano compiacimento – camuffato da disprezzo – del principe Fabrizio Salina (anche il Gattopardo è del 1958!) di fronte al sonno dei siciliani, né alcuna indulgenza verso il loro straccione senso di superiorità. La scrittura di Sciascia, in questo caso, può essere posizionata agli antipodi di quella di Tomasi ed essere assunta come controcanto alla sua narrazione. I protagonisti dei racconti della raccolta rappresentano, infatti, l’altra faccia della medaglia, sono l’opposto matematico dei personaggi lampedusani. Raccontano lo stesso mondo, a volte gli stessi eventi (Il quarantotto), rovesciandone pervicacemente il punto di vista.
Gli eroi di Gli zii di Sicilia sono contadini, odiano i nobili, detestano la loro immobilità, pregustano il sole dell’avvenire, il momento in cui il mondo di ingiustizia nel quale sono costretti a vivere verrà rovesciato in nome di una presa del potere dei loro emissari che sia fondata sulla ragione. Ed è proprio la ragione, nel duplice senso di visione fondata sulla logica razionale delle cose e di essere dalla parte del giusto, a cui essi affidano, illuministicamente, la speranza del loro riscatto, contro ogni aristocratico sdilinquimento per una Sicilia tutta irredimibilità e buone maniere. Anzi, una volta sentita la loro versione dei fatti, si capisce come essi pensino che sia proprio il muro di gomma costituito dalla raffinatissima ossessione per le cerimonie dei nobili a rappresentare il nemico da abbattere. Il nichilismo indolente, il suo dotto relativismo è, secondo gli umili protagonisti di Gli zii di Sicilia, la migliore garanzia di tutela degli interessi del più forte e del soddisfacimento dei suoi più bassi istinti. Ecco, allora, che dietro l’eleganza e il prestigio di facciata del barone Graziano – al centro delle trame di Il quarantotto – si riveli uno squallido e irresponsabile rovinafamiglie. Si può notare come la postura gattopardesca di questo tipo di personaggi, sospesa fra l’ammiccamento di chi la sa lunga e l’indolenza funzionale alla perpetuazione del potere, possa essere riconosciuta nella successiva prosa di Sciascia. A ereditare questo passo, a sguazzare nel gioco retorico delle mille verità, sarà la mafia, sarà il padrino, sarà Mariano Arena...
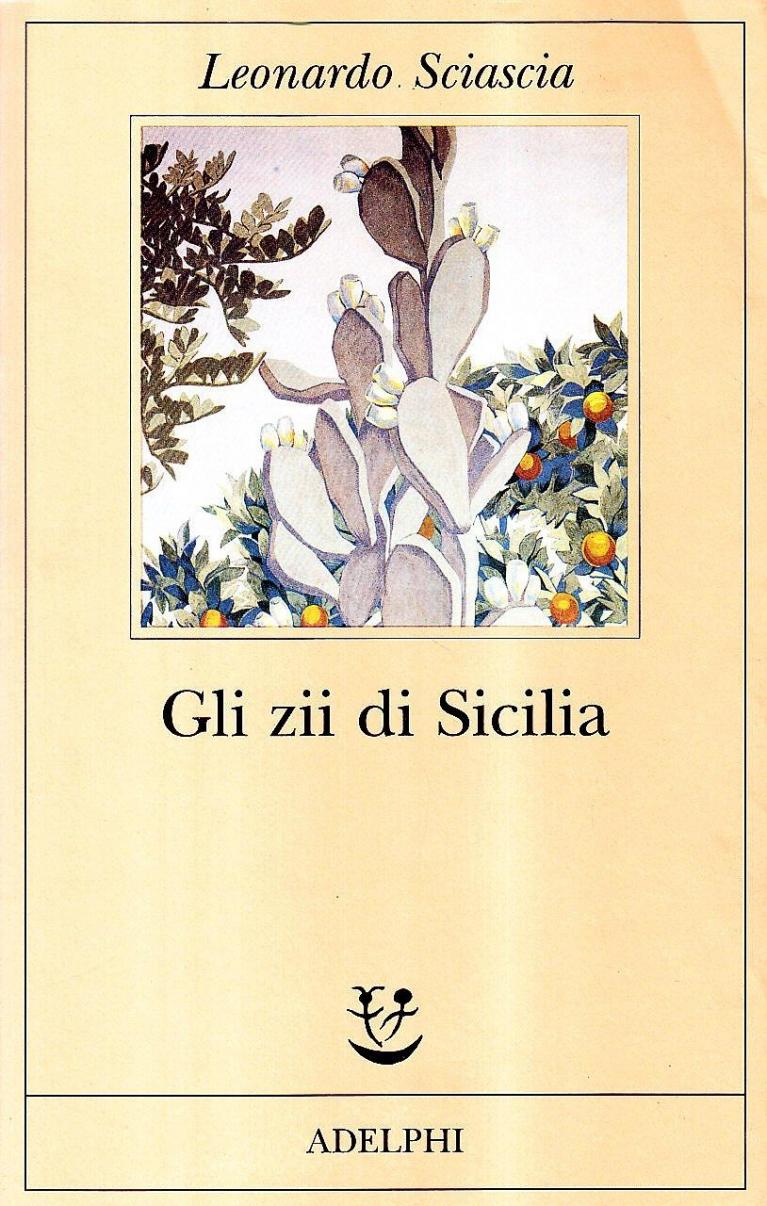
Contro tutto ciò, Sciascia propone il suo antidoto, tracciando un suo modello eroico peculiare. Sono i tanti ragazzini che animano i racconti di Gli zii di Sicilia, figli di nessuno che vogliono studiare nonostante la loro condizione gli precluda un tale cammino: per emanciparsi, per liberare se stessi e la Sicilia. Essi aspettano il tempo di Chevalley con fiducia e mai si sarebbero sognati di respingerlo. Gli umili eroi de Gli zii di Sicilia – come il significativamente anonimo ragazzino protagonista di La zia d’America – prefigurano Bellodi, l’ingenuo, il bacchettone, il filologo, il razionalista che, impudentemente, accetta la sfida di mettere ordine nella matassa, con rigore e metodo.
Un’altra caratteristica notevole che ci permette di rispondere alla domanda su chi siano gli zii di Sicilia evocati nel titolo della raccolta è legata a un certo topos siciliano che ancora una volta interseca la rappresentazione del mondo lampedusiana, chiamando in causa, stavolta, la dialettica centro-periferia. Se è vero che la Sicilia rappresenta un luogo geograficamente periferico nei nuovi destini del mondo (che si giocano in America, in Spagna, in Russia), i siciliani dei racconti in esame mostrano una particolare propensione a pensarsi come parti in causa, ossessionati da avvenimenti lontani che essi vogliono avvicinare il più possibile. I siciliani di Sciascia sognano il campo di battaglia, vogliono partecipare, si arrovellano per comprendere i giochi strategici che animano la grande politica, discutono di massimi sistemi, intervengono nonostante la loro marginalità, tanto geografica quanto esistenziale. Perfino la figura mitica di Stalin può diventare così inaspettatamente prossima per uno come Calogero Schirò. Egli, calzolaio di uno sperduto paesino di Sicilia, dialoga, in sogno, con il leader sovietico, si interroga sui vantaggi e i limiti del patto Molotov-Ribbentrop, gioisce e patisce di ogni minimo accadimento politico del suo beniamino, scommette che la vittoria del grande liberatore degli oppressi libererà anche lui. E, perciò, costituisce la sua lercia bottega come un laboratorio politico in cui prendere in considerazione le sorti del mondo, confrontandosi con l’arciprete, a cui spetta di rappresentare, in questa commedia, le ragioni del liberalismo. Si tratta del medesimo orizzonte, raccontato in termini farseschi da Guareschi ma, d’altra parte, è proprio così l’Italia di quegli anni.
Un’Italia dimenticata in cui il dibattito politico è capillare, in cui le botteghe degli artigiani, le sezioni dei partiti così come le parrocchie o ancora i circoli di paese sono incluse dalle grandi narrazioni politiche ma soprattutto rappresentano luoghi di intervento e critica a partire dai quali potersi elevare dalla particolarità dei propri interessi, in nome di qualcosa di più alto, più generale. Nelle botteghe, nelle sezioni, nelle parrocchie, nei circoli, l’infinitamente piccolo, sebbene consapevole della sua marginalità, può realizzare il miracolo di proiettarsi nell’infinitamente grande. Ed è proprio in questo gioco di corrispondenze, fra piccolo e grande, centrale e periferico, che entra in gioco la famiglia, filtro attraverso cui ogni avvenimento della grande storia viene interpretato. Stalin per Calogero Schirò è uno di famiglia, è perfetto zio di Sicilia, con cui mettersi in relazione anzitutto affettivamente. Lo stesso può dirsi della zia d’America, grazie alla quale il nuovo mondo può assumere una qualche riconoscibilità (“E l’America per me era lo storo grande di mia zia”). Anche il fascismo viene incarnato da uno zio – siamo ancora nel primo racconto – uno scialacquatore senza arte e né parte, frustrato dal mancato riconoscimento di sé in famiglia ma pronto a rinnegare la sua fede politica nel nome della zia d’America e di un matrimonio fortunato. È la sua persona il filtro attraverso cui il ragazzino protagonista della storia può (insieme al lettore) comprendere il senso del ventennio: nei suoi confronti, proprio perché si tratta di un altro zio di Sicilia, lo sguardo non può che essere pietoso. Ancora, è la familiarità con l’antimonio (termine con cui i vecchi minatori siciliani si riferivano al grisou) a orientare l’umile zolfataro siciliano, dell’ultimo racconto della raccolta, nell’inferno della guerra civile spagnola. Egli conosce i suoi nemici antifranchisti, per il fatto di trovarseli contro in battaglia. Dei suoi nemici, non potrà che apprezzare la somiglianza fisica – segno di un’ulteriore affinità di spirito fondata sull’appartenenza di classe – con la sua gente. Sarà proprio questa somiglianza il viatico per comprendere come egli, arruolatosi, per denaro, da volontario delle legioni fasciste, si ritrovi a combattere dalla parte sbagliata, contro i contadini, contro la povera gente.
Ma, infine, anche il filtro dell’analogia, della corrispondenza fra grande e piccolo, fra lontano e vicino, non potrà che mostrare la sua insufficienza di fronte alla volontà di potenza degli eroi popolari sciasciani.
Ci penserà il progresso a liberare il protagonista di L’antimonio, ormai mutilato di guerra. A lui, proprio in virtù del suo handicap, viene assegnato un posto di bidello. Un posto statale che lo porterà a prendere servizio in un’altra città.
Ecco stagliarsi all’orizzonte l’occasione della sua vita: andare in una grande città là fuori. Perdersi nell’anonimato folla, sperimentarsi individuo, senza termini di paragone, senza il filtro degli zii di Sicilia è per lui l’unica possibilità di essere davvero libero e di “vedere cose nuove”.







