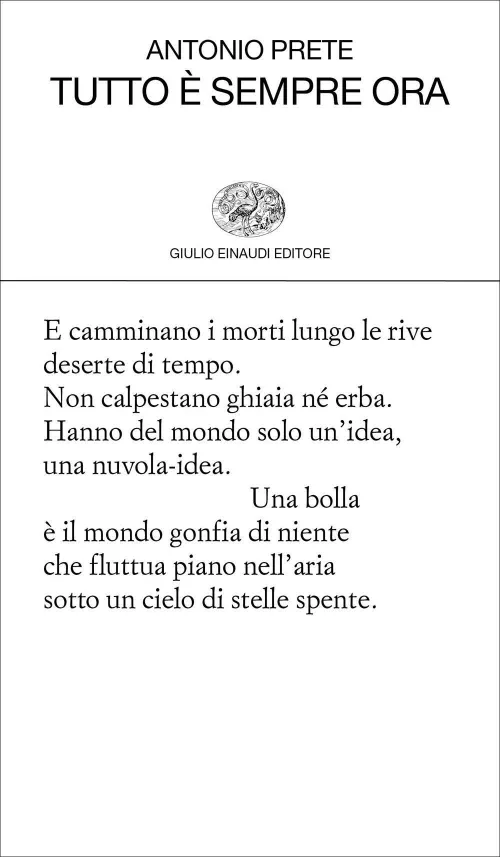Materia e canto / Antonio Prete, Tutto è sempre ora
Della poesia si privilegia spesso l’ineffabile, l’invisibile, a discapito di tutto ciò che di materico c’è nei versi. E quando si parla del materiale, lo si fa per dire dello scarto tra il quotidiano – oggetti, gesti, sguardi – e quel tanto di astratto a cui di fatto la poesia d’un tratto accede. La siepe, per intendenderci, e l’infinito. La siepe è la barriera materiale grazie o a causa della quale, suggerisce Leopardi, poi si prende il volo. Lì, la poesia.
Eppure c’è un dato materico che precede la siepe, ed è la parola che la dice, il gradino cioè sopra il quale il lettore sale per superarla con lo sguardo. È composto di cinque lettere, segni sopra un foglio, fonemi nella bocca, cioè concretezza pura. La concretezza di una combinazione di alfabeto scelta tra le tante, moduli verbali visibili a occhi nudo, poi composti in una frase o in un verso e tenuti insieme dalla malta del silenzio.
È, questa del linguaggio, la prima matericità della poesia. La lingua che batte sulla consonante, la cadenza di una metrica precisa, l’eco che fa la rima dentro il silenzio teso di due versi, o le assonanze, quei richiami dispersi dentro il bosco cieco di una strofa. È quello il sasso caduto nello stagno di un sonetto o di un’ottava, sono le parole i primi cerchi che poi vanno a sparire in quell’astratto a cui poi il lettore accede, come per miracolo, a ciò che è spogliato di materia.
La siepe leopardiana, in definitiva, è prima di tutto quel muretto di parole ammonticchiate davanti al poeta, quei quindici versi accatastati contro il panorama, innervati dalla musica degli endecasillabi che, pur sciolti, compattano la celebre poesia. Leopardi fa questo: sale sul muretto che ha innalzato con le sue parole. L’ha costruito perché l’immaginazione ci montasse sopra e accedesse a ciò che altrimenti sarebbe stato vago.
Antonio Prete è un leopardiano dichiarato, prima di tutto perché da studioso ha dedicato a Giacomo Leopardi testi imprescindibili (La poesia del vivente e Il pensiero poetante, per citarne solo due – si aggiunga, fuori registro, un appello perché quest’ultimo venga reso di nuovo reperibile, editori farsi avanti). Il che significa che porta avanti – da teorico – quella salutare ossigenazione che, sola, salva la poesia dalla morte certa delle interpretazioni standard, dalla condanna a morte delle interpretazioni snocciolate a scuola in trance.
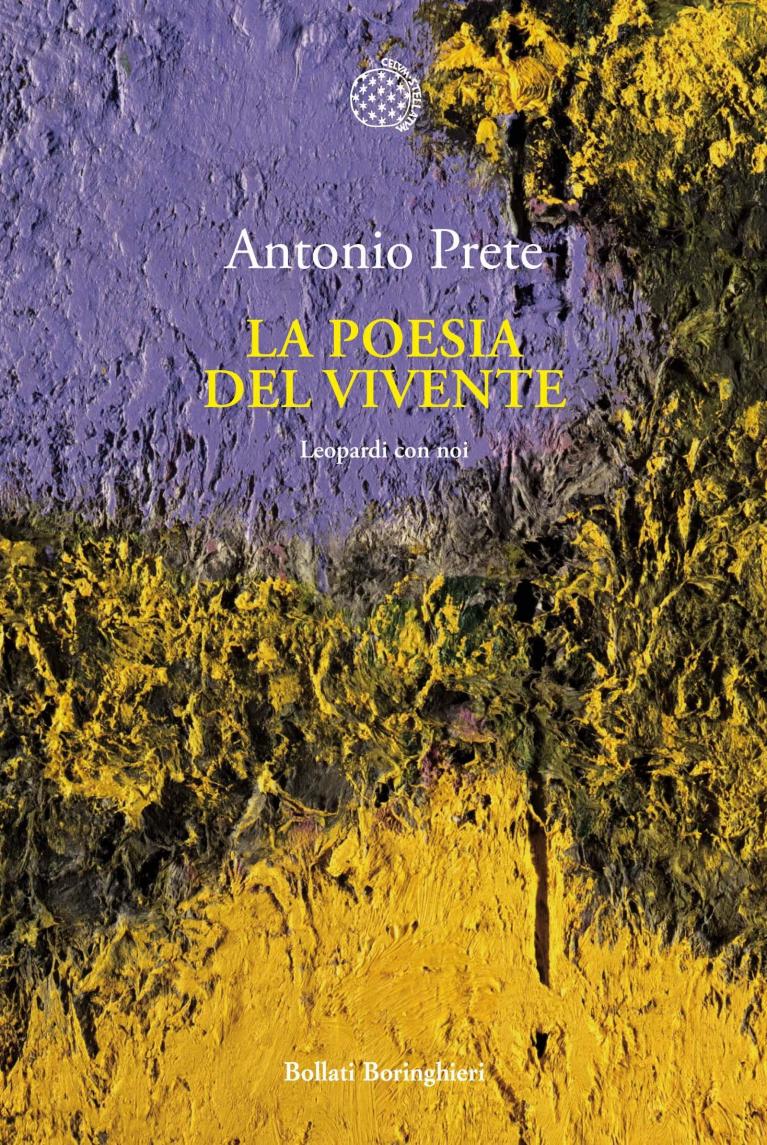
Ma Prete è leopardiano perché il suo dettato, anche in prosa, è sempre al tempo stesso concreto e molto aereo. I temi che gli sono cari sono la lontananza, la nostalgia, l’interiorità (si vedano, tra gli altri, il Trattato della lontananza e Il cielo nascosto. Grammatica dell’interiorità, Bollati Boringhieri), ma la sua lingua è per certi versi sempre il canto. Prete costruisce architetture testuali profondamente musicali: la abitano i poeti che spesso raccoglie tra le pagine, gli inquilini primi dei suoi libri, e la abita la lingua di Antonio Prete stesso, fatta di una gentilezza malinconica, che non di rado sembra essere felice perché sempre curiosa, sempre con lo sguardo sollevato al cielo.
Tutto è sempre ora (Einaudi) è il libro più recente di Antonio Prete da poeta. È diviso in cinque sezioni, di cui l’ultima, Dell’apparenza (prosa d’inverno), per l’appunto sono testi in prosa. Come succede raramente, si entra in un libro di versi di Prete, provenendo da un altro dei suoi libri, e non ci si trova spaesati. È una stanza di uno stesso edificio autoriale in cui il lettore si muove riconoscendo che l’inquilino è sempre lui: lasciarsi alle spalle Torre saracena. Viaggio sentimentale nel Salento (Manni) e poi aprire la porta di questa nuova silloge poetica significa solo cambiare ambiente, ma l’aria che si respira è la medesima, medesimi il paesaggio visuale e sonoro.
La materia dei versi di Prete è sempre un canto preciso ma non secco, l’endecasillabo s’incontra con una certa regolarità, come una presenza familiare sulla strada, che poi sparisce, lascia il posto ad altri suoni. E in questa raccolta – così bella da attraversare perché è un bosco amico -, si staglia prima di tutto ciò che fa da quinta alla vita dell’uomo sulla terra: le geografie dei luoghi, la sensualità appena malinconica dei colori e del ricordo del senese e della Puglia, e però anche una Milano che si staglia più dolente, come un ricordo che fa male quando cambia il tempo.
E ancora, è soprattutto la natura, la sonorità che pronuncia ciò che non è uomo (gli alberi, il cardo, si riaffacciano frequententemente tra i versi di Prete), e come tutto questo si raccorda a ciò che invece è l’uomo stesso, il suo dolore e la sua colpa, perché è lo stesso l’alfabeto che lo porta, che lo dice: “Dire degli alberi, dei loro ombrosi / pensieri. Dire del vento che li abita” (…) “Dire dei cieli che si acquietano tra i rami” (…) “Con quelle stesse sillabe non tacere / sulle stragi, sui loro mandanti, / sui corpi fatti cenere e memoria, / sui desideri crivellati di nero”. Le “pietre muschiate sui cigli” stanno insieme ai keatsiani nomi “scritti sulle acque” degli affogati nel Mediterraneo, mare e corpi, natura e violenza umana: “Nel grido del gabbiano c’è il tuo nome, /Dunya”.
Tutto è sempre ora ha un titolo eliotiano ma è poco modernista. In fondo non c’è guasto, per quanto Prete sia sempre pronto a riconoscere il dolore, persino a puntarlo con il dito. Quella di Prete non è un’epoca in frantumi, non lo è affatto: ed è questo che lo fa un poeta che prende in contropiede il tempo. Non lo nega, ma sa guardare anche altrove, riconosce un fatto persino assai banale: che si può sempre passeggiare. “Dopo la curva, la cuspide nevosa / di San Marino, con la striscia d’ombra / che s’avvalla”.
Del suo Leopardi – a cui andrebbe almeno aggiunto il suo Baudelaire, e l’amore per la traduzione che soffia in questo libro – Antonio Prete si è in fondo tenuto più l’amore per i luoghi che la metafora, che poi possono diventare, per dire di un dolore molto umano. Lo sguardo di Prete guarda quasi sempre in su, ma il suo su è ben più in alto della siepe. Sono gli alberi, è molto spesso il cielo, a volte è persino il firmamento: “Si è accesa una costellazione: / è l’abisso del tempo / nel volo della luce”. Perché Prete, in definitiva, accatasta l’alfabeto e ne fa una pira: le sue poesie sono fiamme dolci, e quello che interessa al poeta non è ciò che le fiamme illuminano. È piuttosto la cenere che resta dopo, quando il fuoco è spento. È lì che il cielo torna cielo, sulla testa, si rivedono le stelle. Ed è lì che il silenzio torna tale, e la poesia prova a dirlo: “Quel punto dove il silenzio si sporge / oltre il tacere, forse è lì il nido / della parola, diceva”.