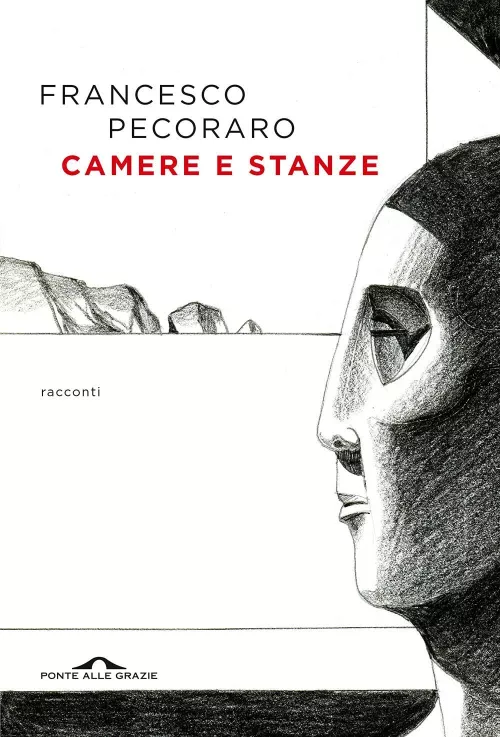Tutti i racconti / Francesco Pecoraro, Camere e stanze
Uno degli scrittori che di recente hanno più suscitato l’interesse della critica italiana è Francesco Pecoraro. Pecoraro è nato nel 1945 e ha esordito tardi, negli anni zero, come autore di racconti, seguiti nello scorso decennio dai romanzi La vita in tempo di pace e Lo stradone. Oggi Ponte alle Grazie, che ha pubblicato quei romanzi, riunisce tutti i suoi racconti sotto il titolo di Camere e stanze.
È un caso curioso, quello di Pecoraro; così come curiosa è la sua ricezione. Il suo stile e la sua fantasia sono, verrebbe da dire, medii: di quella medietà che sembra fatta apposta per lo sviluppo di un romanzo tradizionale. E i suoi romanzi in parte lo sono; però vogliono funzionare anche da saggi, anzi vogliono proporsi come delle evidenti macrometafore, delle vaste interpretazioni della civiltà. Il fatto, però, è che queste interpretazioni attingono con troppa facilità a un immaginario corrente per innervare in modo originale la narrazione. Ci guadagnano, invece, quando sono chiuse in uno spazio meno dilatato, nel racconto o bozzetto, anche se in questo modo mostrano un limite sul piano della densità.
Ecco il punto: siamo davanti a un autore che, per prendere a prestito le situazioni della sua raccolta, si dimostra un buon pittore di marine, di paesaggi e di ritratti, tratteggiati con mano abile su un fondo di conosciuta tradizione e di comune sentire, e insomma su una tela limitata. Questo pittore appare spontaneamente portato a realizzare affreschi più ampi: sembra aver bisogno di più spazio, dato che la sua pennellata è più lunga che intensa; ma se lo si chiude in un capannone troppo grande, imponendogli magari di compiere una performance “contemporanea”, andrà un po’ “in loop” come capita a uno dei suoi personaggi.
E invece, curiosamente, è proprio questa capacità che la critica gli riconosce. Non è difficile capire perché. Gli studiosi di letteratura della generazione successiva a quella di Pecoraro hanno spesso una concezione libresca della storia delle idee e della politica. Col suo dignitoso perbenismo ideologico, demistificato e rivendicato a un tempo, lo scrittore li conferma in una presunta verità che hanno già assorbito manualisticamente, ma che qui viene autenticata da uno che la sa ambientare, che sa restituire i costumi e le abitudini di chi c’era, ovvero da un testimone di epoche spesso mitizzate dai letterati più giovani.
Pecoraro lo fa con notevole mestiere narrativo – un mestiere che non è più merce così diffusa, e che forse ha potuto mettere bene a punto proprio perché è rimasto a lungo fuori dalla mischia, impegnato in un’altra professione. Ma come si accennava, l’idea che così dia un quadro originale del passato prossimo e del presente è un equivoco in cui solo chi ha poco fiuto per la politica e la storia concrete può cadere. Ciò che invece interessa è il sentimento estremo con cui Pecoraro vive la medietà della sua visione del mondo e della vita. Da decenni, lo sappiamo, una Storia maiuscola ormai indecifrabile ha lasciato il posto alla minacciosa Natura: e nei suoi libri, oltre a raccontarci il dramma-dell’assenza-di-dramma di chi ha stagnato per tutta la vita in una falsa pace, Pecoraro rende con fluida precisione il topos delle città che tornano foreste, dell’entropia melmosa della civiltà, dell’uomo schiacciato dall’infinitamente piccolo degli insetti e dall’infinitamente grande delle galassie.
Il Novecento si è chiuso, ci ricorda questo narratore, ma non è sorto un mondo nuovo. Il vecchio va alla deriva; e se politicamente Pecoraro vede la deriva con una certa genericità, concretissimo è invece nel restituire il suo strazio davanti all’affastellarsi incoerente di oggetti, spazi, stili, e soprattutto davanti al tramonto di quell’homo faber per cui ha un vero e proprio culto. Tutti i personaggi di Pecoraro sono come lui architetti – anche i bambini, anche l’avvocato napoletano del racconto Farsi un Rolex, che prima di essere fermato da un guappo riflette con puntiglio sui basoli della pavimentazione cittadina. Tutti soffrono davanti al degrado, a quei dettagli ripugnanti che il loro occhio inquadra ovunque nei loro simili e nelle strade (forfore, sudori, escrementi). Tutti, infine, sono in qualche modo sospesi tra l’acting out che fa reagire all’impotenza con un atto di violenza improvvisa, e la sublimazione del caos o della brutalità per il tramite di un’altra violenza – quella calma dell’ordine, della geometria essenziale, quella dell’eleganza impeccabile e di una platonica purezza delle forme.
Entrambe le soluzioni, che hanno origine nella figura di un “Padre” maiuscolo, rappresentante della Borghesia Romana del Boom, vengono adottate caso per caso dalle controfigure dell’autore. Ma la violenza in genere trionfa. Nei racconti di Pecoraro si sente sempre il respiro grosso di qualcuno che sta per esplodere. A volte è un ragazzino che sferra un pugno gratuito a un demente, a volte un pittore che ha perso il contatto col mondo, a volte un manager che rovescia letteralmente il tavolo per poi ritirarsi sul Mare, mito positivo e rovescio dell’Urbe purulenta.

Ma altrettanto spesso, e magari nello stesso pezzo, ci troviamo di fronte a una scelta contemplativa, all’evasione dal mondo in una vita di ascesi artigianale che ha quasi sempre a che fare col piacere fisico della pittura, o addirittura con l’ipnosi provocata dalla “grafica”: un altro manager, dopo aver visto la foto di un maori, si fa tatuare il viso come lui, e accetta l’emarginazione dalla sua azienda senza reagire; solo, forse parla un po’ troppo, togliendo efficacia alla storia, quando si mette a spiegare a un collega la sua filosofia della decorazione.
Le riflessioni esplicite reggono meglio dove i racconti si pongono apertamente come confessioni. È il caso, ad esempio, della vera e propria operetta morale intitolata Mi suicido per via dei miliardi di anni. “Mi suicido perché non tollero la contraddizione tra la matematica e il catarro”, vi afferma il suicida in una delle sue tante anafore senza scampo: cioè, appunto, non tollera la compresenza del caos e dell’idea di purezza lineare, funzionale ed estetica, che non riesce a estirpare da sé. Ma il pezzo più rappresentativo, sulla dialettica tra ordine e violenza, è Tecnica mista. Verrebbe da dire, scherzosamente ma non troppo, che si tratta del racconto più autobiografico di Pecoraro. Un pittore italo-anglo-libanese scrive un memoriale in cui racconta a un professore d’arte i fatti principali della sua formazione: il piacere primigenio per il gesto della pittura pura, espressionista e astratta; l’impossibilità di essere all’avanguardia; la crisi della vocazione; e alla fine la fascinazione per il vuoto e i colori puri di una moschea, oltre che per le certezze granitiche che vi si respira. Il suo problema di fondo è “come essere un artista contemporaneo?”. Lo risolve diventando un terrorista, e facendo scoppiare una bomba in Israele: mentre firma la strage col sangue, riconosce nei corpi dilaniati un’Opera totale.
Nulla di nuovo, come si vede; ma il memoriale resta un buon manufatto letterario. Oltre che nel Match, una quasi parodia di Tecnica mista, il motivo pittorico e quello della violenza si ritrovano anche nel primo racconto, senza dubbio il migliore – o come direbbe un personaggio pecorariano, il racconto che più “ci risulta”. L’eponimo Camere e stanze esaurisce infatti con plastica evidenza il tema che sintetizza tutte le inquietudini di Pecoraro: quello della profanazione. Il protagonista Silver, professore di sociologia dello spazio, vede per ironia il suo spazio più sacro (la raffinata casa-capsula novecentesca attraverso cui si difende dal caos di fuori) violato fin negli anfratti più intimi da un’orda di teppisti, che gli sottraggono tra l’altro quello che è per lui quasi un altare domestico, un idolatrato dipinto di Afro.
Il cavallo di Troia è la festa per i suoi cinquant’anni. A organizzarla, malgrado le sue resistenze, l’ha convinto la compagna Clara, una studentessa che lo affascina proprio perché fa pienamente parte di quell’orda senza memoria storica, e perché la rappresenta con una peculiare, torpida sfacciataggine, con una grazia incurante e “genetica” descritta al solito in termini da architetto ingrifato (la “curvatura della spina dorsale (…) le dava un portamento eretto, le proiettava i seni nello spazio, le estraeva il culo, in un gioco morbido di bilanciamenti e contrappesi”). Clara parla un linguaggio volubile, senza nessi: e durante la festa è come se quel linguaggio prendesse corpo negli atti illogici degli sconosciuti che come una pifferaia si trascina dietro, negli sfregi di “invasori” tribali appartenenti al mondo dove i jeans sono preconsunti artificialmente, e dove nessun oggetto ha un valore ancorato al tempo o al gusto. A questo punto, come spesso il suo autore, il sociologo diventa giocoforza etologo e biologo: sente nell’aria gli ormoni, sperimenta la forza belluina degli animali giovani che umiliano il suo corpo di vecchio gorilla, vede i pochi colleghi attempati diventare a loro volta parte gregaria del branco.
Di fronte a questo racconto realistico, i pezzi onirici o distopici appaiono sbiaditi, e comunque molto meno inquietanti. Ma in tutti il sentimento dell’esistenza è lo stesso: quello di un uomo che si crede tagliato fuori dai giochi, circondato da conoscenti che se la intendono contro di lui o da estranei prima insinuanti e poi arbitrariamente feroci. È un uomo progressivamente assediato da una realtà oscura e informe che gli si rivolta contro – una realtà di cui non è più l’erede-padrone ma la vittima smemorata, forse malata, e perciò violenta. E qui, ci sembra, sta la verità più vera di Camere e stanze, anzi dell’intera opera di Pecoraro per come la conosciamo fino a oggi.